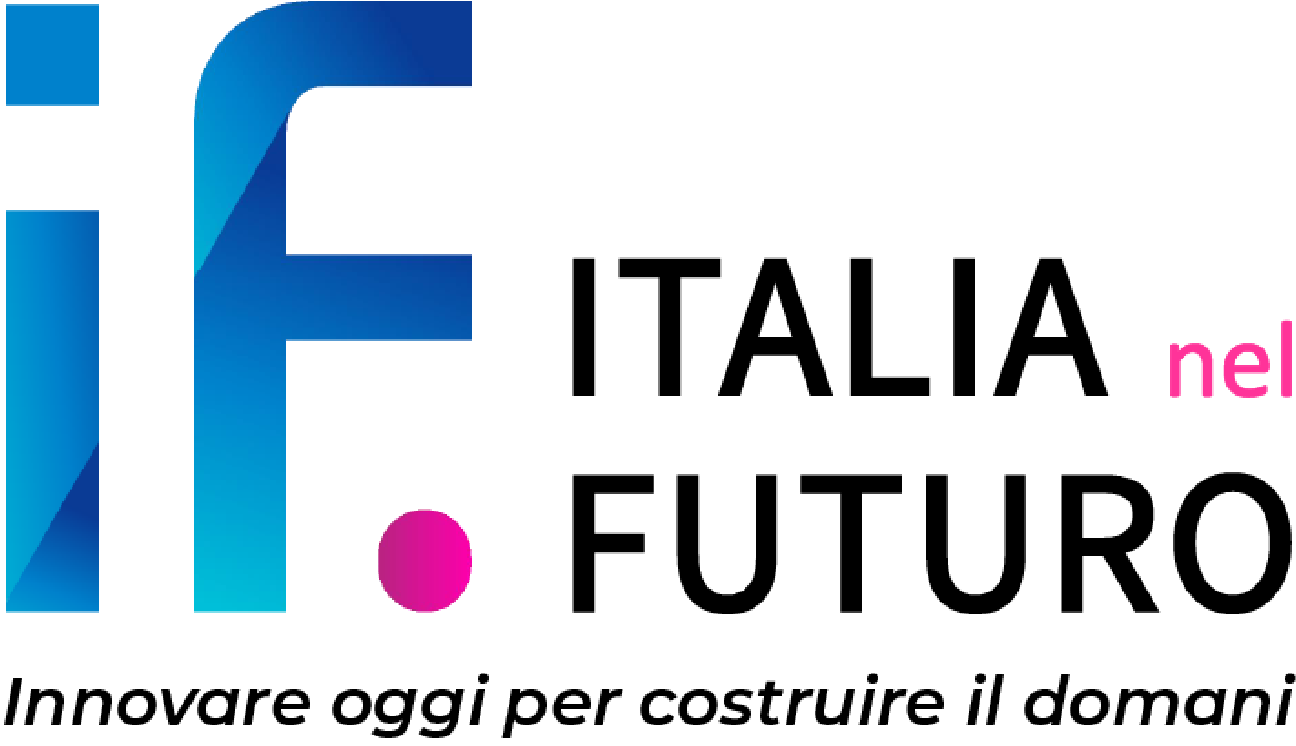Francesco Giavazzi ha ragione, e vale la pena dirlo subito con chiarezza. Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, “Startup, l’UE cambi le regole”, Giavazzi mette il dito nella piaga più scomoda e più concreta: l’Europa non soffre di mancanza di idee, di ricerca o di talenti. Soffre di un difetto strutturale, perché sistemico, che trasforma l’innovazione in un percorso a ostacoli: l’incapacità di trasformare idee eccellenti in imprese globali. Il continente produce brevetti, ingegneri, scienziati e imprenditori. Ma quando una startup entra nella fase decisiva — quella in cui servono capitale, talenti, mercato e velocità — l’Europa diventa un labirinto. E allora l’impresa fa la scelta più razionale: si sposta dove crescere è possibile, fuori dall’Europa. Non è ideologia: è sopravvivenza.
Il punto centrale è una parola che a Bruxelles amiamo ripetere e che nella pratica continuiamo a smentire: integrazione. Sulla carta siamo un mercato unico. Nella vita concreta di un’impresa innovativa siamo un arcipelago. Non è un mercato unico: è un mercato a pedaggio, dove ogni confine è un costo fisso. Regole societarie diverse, sistemi fiscali spesso incompatibili, norme del lavoro eterogenee, burocrazie che cambiano forma a ogni confine, tempi amministrativi che trasformano l’espansione in una prova di resistenza. Una startup che opera in cinque Stati membri non scala: ricomincia cinque volte. Ogni attraversamento di frontiera aggiunge costi e ritardi, oltre all’incertezza legale. E nel digitale l’attrito è letale, perché il tempo non è solo denaro: è il vantaggio competitivo stesso.
La differenza con gli Stati Uniti non è soltanto la dimensione del mercato. È la continuità del quadro. Il mercato è uno e le procedure sono replicabili: il diritto societario è prevedibile, la finanza è profonda, l’ecosistema sa accompagnare una società dall’idea alla quotazione senza dover reinventare tutto a ogni passaggio. Costituire una società, raccogliere capitale, assumere, aprire filiali, fare acquisizioni e preparare una quotazione sono tappe ordinarie, non un percorso di sopravvivenza burocratica. In Europa, invece, la crescita viene spesso penalizzata: diventa lenta, costosa e rischiosa. E poi ci stupiamo se le imprese, nel momento decisivo, guardano altrove.
Se vogliamo smettere di esportare startup e importare tecnologie, non servono nuove strategie dal titolo altisonante. Servono poche decisioni concrete, misurabili, e soprattutto rapide, capaci di ridurre l’attrito e aumentare la velocità. La prima è creare un vero diritto societario europeo per startup e scale-up: non una semplice armonizzazione, ma una forma giuridica europea opzionale e valida in tutta l’Unione, con costituzione digitale, governance standardizzata, regole uniformi per stock option e piani di incentivazione, e procedure di insolvenza compatibili con la natura dell’innovazione. Oggi in Europa la burocrazia societaria è un freno competitivo; domani deve diventare un acceleratore.
Il secondo pilastro è rendere reale l’Unione dei Mercati dei Capitali. Qui la retorica deve finire: senza capitale la crescita non esiste. Servono regole uniche e semplici per venture capital e growth capital, condizioni omogenee per fondi paneuropei e strumenti credibili per finanziare la fase late-stage, quando gli investimenti diventano centinaia di milioni e non più pochi milioni. Serve anche un mercato borsistico europeo capace di sostenere la crescita, con regole coerenti e sufficiente profondità. Altrimenti la storia è scritta: quando una società diventa grande, la finanza europea diventa stretta, e New York diventa la scelta naturale.
La terza priorità è la certezza fiscale. Non si tratta di dumping, ma di prevedibilità. Troppe decisioni di delocalizzazione nascono dall’incertezza su come verranno tassate stock option, exit e strutture societarie cross-border. È l’opposto di un ecosistema che vuole competere. Un’Europa che si dice pro-innovazione dovrebbe offrire un quadro stabile e trasparente proprio sulle leve che contano per attirare capitale e motivare i team. Perché, ancora una volta, ciò che i mercati premiano non è la perfezione: è la chiarezza.
A questo si lega un tema spesso rimosso, ma centrale: un regime del lavoro compatibile con la scalabilità. Le startup non possono essere regolate come imprese mature. Servono regole specifiche per la fase di crescita, con semplificazione amministrativa, maggiore agilità e soprattutto un modello europeo serio di partecipazione azionaria dei dipendenti. Se vuoi trattenere i migliori, devi permettere che condividano il valore creato. Oggi in Europa, troppo spesso, è più facile distribuire burocrazia che equity; e questa è una ricetta perfetta per perdere talenti, oltre che aziende.
C’è poi un errore culturale diventato abitudine istituzionale: la regolazione anticipatoria. L’Europa tende a regolamentare prima che un mercato esista davvero. La tutela dei cittadini è essenziale, ma la sequenza conta. Bisogna regolare dove c’è scala e rischio concreto, non comprimere la sperimentazione. In settori come intelligenza artificiale, dati, biotech e deep tech, l’ossessione per la regolazione preventiva finisce per trasformarsi in un sussidio involontario alla competitività altrui. Ogni mese speso a interpretare norme è un mese sottratto al prodotto.
In questo quadro, un pezzo decisivo va detto senza ambiguità: non esiste innovazione senza persone, e l’Europa deve diventare il luogo più semplice al mondo per attrarre e trattenere talenti non europei. Per farlo servono canali rapidi e davvero paneuropei per visti e permessi, riconoscimento veloce di titoli e competenze, percorsi chiari verso la residenza per chi lavora in settori strategici, e un contesto fiscale e amministrativo trasparente, non arbitrario. Oggi l’Europa rende difficile ciò che dovrebbe rendere automatico: portare qui le migliori menti del mondo e metterle nelle condizioni di costruire. Ogni talento respinto è un investimento regalato a un altro continente.
Infine, c’è un tema che completa il ragionamento di Giavazzi e spiega perché alcune aree del mondo costruiscono ecosistemi e altre no: la co-creazione vera tra industria e università. L’Europa parla molto di trasferimento tecnologico, ma pratica meno la co-creazione, che è un’altra cosa. Significa progettare insieme fin dall’inizio, condividendo obiettivi, strumenti e tempi; trasformare campus e distretti industriali in piattaforme comuni; creare joint lab permanenti e non progetti temporanei; costruire carriere ibride senza penalizzazioni accademiche; rendere veloce e standard la gestione della proprietà intellettuale per evitare che mesi di negoziazione uccidano l’innovazione; usare testbed industriali e urbani per validare sul campo tecnologie nuove. In altre parole, non far uscire l’innovazione dall’università quando è già tardi, ma farla nascere insieme alle filiere che la possono industrializzare e acquistare.
La conclusione, per quanto scomoda, è inevitabile. L’Europa non perde startup per colpa degli Stati Uniti. Le perde perché ha costruito un sistema in cui crescere è un’impresa eroica. Un continente che pretende competitività globale senza un mercato unico reale, senza capitale integrato, senza attrazione di talenti, e senza piattaforme stabili di co-creazione tra ricerca e industria, finisce per esportare le sue imprese migliori proprio nel momento in cui diventano interessanti. Ogni startup che se ne va non è solo un’azienda persa: è un pezzo di sovranità tecnologica, di produttività futura, di capacità industriale che scegliamo di cedere.
Finché crescere sarà più facile altrove, il futuro europeo continuerà a essere scritto fuori dall’Europa. E non basterà chiamarlo “mercato unico” per farlo diventare tale.