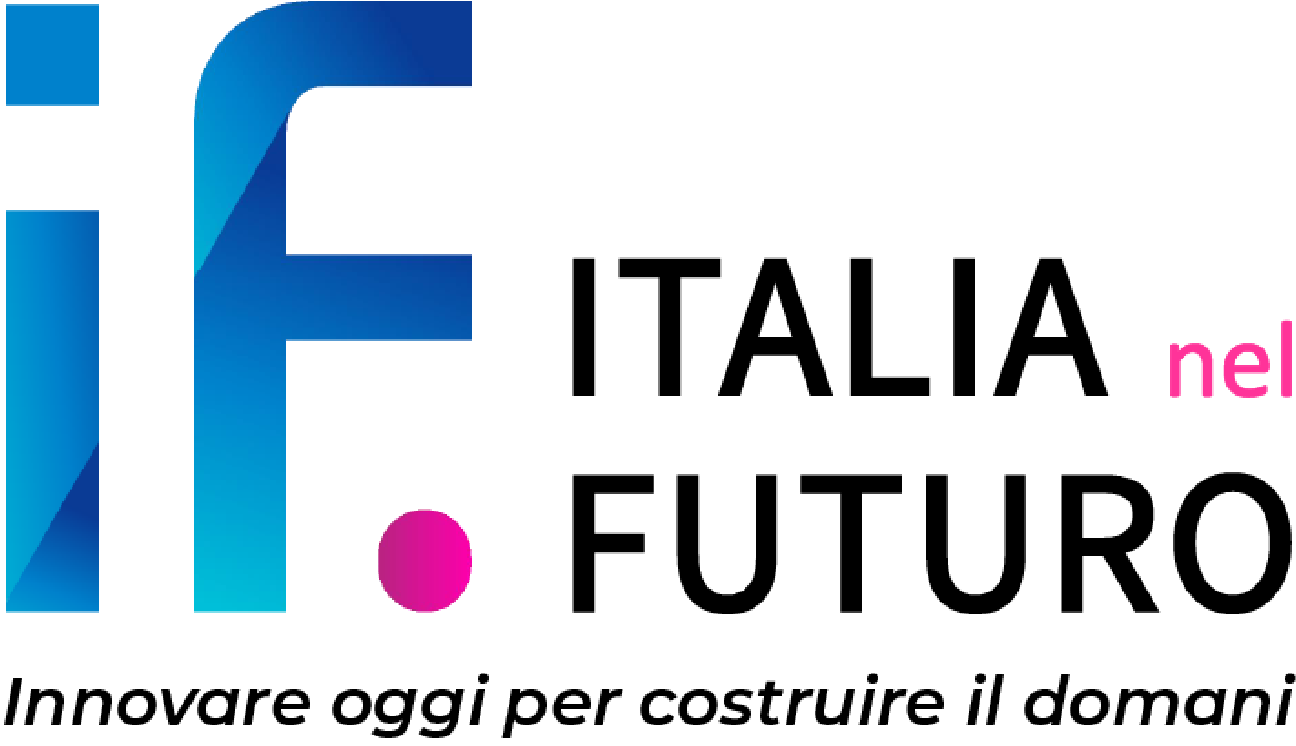Perché Leuven è diventata un cluster industriale, mentre Genova no
L’Italia non ha un problema di idee. Ha un problema di trasformazione: troppe innovazioni restano intrappolate tra paper, progetti pilota e bandi, senza diventare capacità industriale. Se vogliamo capire cosa significa “trasformare” davvero e cosa dovrebbe fare l’Italia per colmare il gap vale la pena guardare a un modello che funziona: quello che trasforma ricerca in industria. È un modello che dimostra che il successo non nasce da annunci, ma da istituzioni capaci di rendere conveniente collaborare, investire e trasferire tecnologia sul mercato.
IMEC nasce e cresce a Leuven, nel cuore delle Fiandre, a ridosso di un ecosistema universitario di altissimo livello, in particolare KU Leuven. Ma la geografia, da sola, non spiega il risultato. La differenza sta nel modo in cui Leuven è stata trasformata in un luogo dove la collaborazione è più razionale della frammentazione: l’istituto opera come piattaforma neutrale di open innovation, in cui aziende—anche concorrenti—possono lavorare sul pre-competitivo, condividere rischi e costi, accelerare l’apprendimento collettivo e poi competere sul mercato. È una neutralità “abilitante”: non compete con l’industria, la rende più veloce.
Questa logica si riflette in un dato essenziale: IMEC non si limita a produrre ricerca, ma costruisce territorio. Pubblica e fa validare misure di impatto—valore aggiunto, occupazione, crescita di startup e spin-off—e le rende parte integrante della propria legittimazione pubblica. In questo modello, la scienza è organizzata fin dall’inizio per diventare capacità industriale, e l’istituzione viene finanziata e valutata con logiche di continuità, KPI e accountability.
Ed è proprio qui che l’Italia dovrebbe fermarsi e guardare in faccia la differenza. IMEC ha avuto un impatto visibile e strutturante su Leuven e sulle Fiandre: ha contribuito a creare un cluster riconoscibile, una densità di competenze, una catena di relazioni industriali e un effetto di attrazione che cambia l’economia locale. Non è solo “un centro eccellente”: è un motore che sposta investimenti, imprese, talenti, filiere.
A Genova e in Liguria, questo effetto non si è visto in modo comparabile. L’Istituto Italiano di Tecnologia ha costruito una piattaforma scientifica di alto livello, con brevetti, joint lab e startup, e competenze che spaziano dalla robotica ai materiali avanzati, dalle scienze computazionali al life science. Eppure, dopo più di vent’anni, manca ancora un prodotto o servizio arrivato sul mercato su larga scala: un caso industriale riconoscibile. E manca, soprattutto, un impatto territoriale misurabile e sistemico su Genova e sulla Liguria: non retorica, ma indicatori concreti, aziende attratte e insediate, filiere locali che si specializzano, fornitori che crescono, posti di lavoro qualificati generati in modo stabile, capitale privato catalizzato sul territorio, scale-up nate vicino ai laboratori e rimaste a crescere lì.
Questo non è un attacco alla qualità della ricerca. È una domanda sul modello e sull’integrazione territoriale. Un istituto può produrre ottima scienza e, allo stesso tempo, non riuscire a diventare piattaforma industriale per il proprio ecosistema locale. È ciò che accade quando l’istituzione resta “verticale” o dispersa in molte direttrici, senza una strategia esplicita di clusterizzazione: attrarre aziende sul territorio, far crescere fornitori, creare domanda industriale stabile, generare occupazione qualificata locale, trattenere talenti e costruire una catena del valore intorno a sé. In Liguria, l’IIT non ha agito come perno del sistema produttivo locale: è rimasto, nella percezione e nei risultati, un’eccellenza scientifica più che un moltiplicatore industriale territoriale.
Ed è qui che entra in gioco la responsabilità della politica industriale italiana. Perché questa non è una scelta che può essere lasciata alle sole istituzioni di ricerca. Riguarda direttamente Governo e Parlamento, ma anche le amministrazioni che determinano le traiettorie di investimento e valutazione: il MIMIT e il MEF, le Regioni, i grandi programmi nazionali ed europei, le scelte su dove concentrare infrastrutture e capacità condivise. In altre parole, è una decisione di sistema.
Qui sta la lezione per l’Italia, e per l’IIT in particolare. Non basta avere brevetti, progetti e startup. Bisogna costruire un meccanismo che renda l’ecosistema industriale locale più competitivo e misurarlo con indicatori comparabili a quelli che IMEC usa per giustificare il proprio ruolo pubblico. Se l’Italia vuole davvero replicare una traiettoria simile, deve compiere tre scelte chiare.
La prima è istituzionale: rafforzare la neutralità e la funzione di piattaforma pre-competitiva verso l’industria, in modo che collaborare con l’IIT diventi la via naturale per accelerare l’innovazione anche per grandi imprese e filiere di PMI. La seconda riguarda scala e concentrazione: mantenere una rete di centri, ma costruire uno o due motori territoriali dove l’effetto cluster sia visibile, talenti che restano, aziende che si insediano, filiere che si specializzano, startup che scalano vicino al luogo in cui nascono. La terza è l’accountability: rendere l’impatto economico e territoriale un obiettivo esplicito, misurato periodicamente con indicatori indipendenti, valore aggiunto, occupazione, ritorno fiscale, crescita delle spin-off, attrazione di capitali.
Senza questa scelta, l’Italia continuerà a finanziare eccellenza scientifica senza costruire sovranità industriale. Perché, alla fine, la competizione tecnologica non la vincono i Paesi che annunciano più iniziative. La vincono quelli che costruiscono istituzioni capaci di trasformare ricerca in industria e industria in crescita.