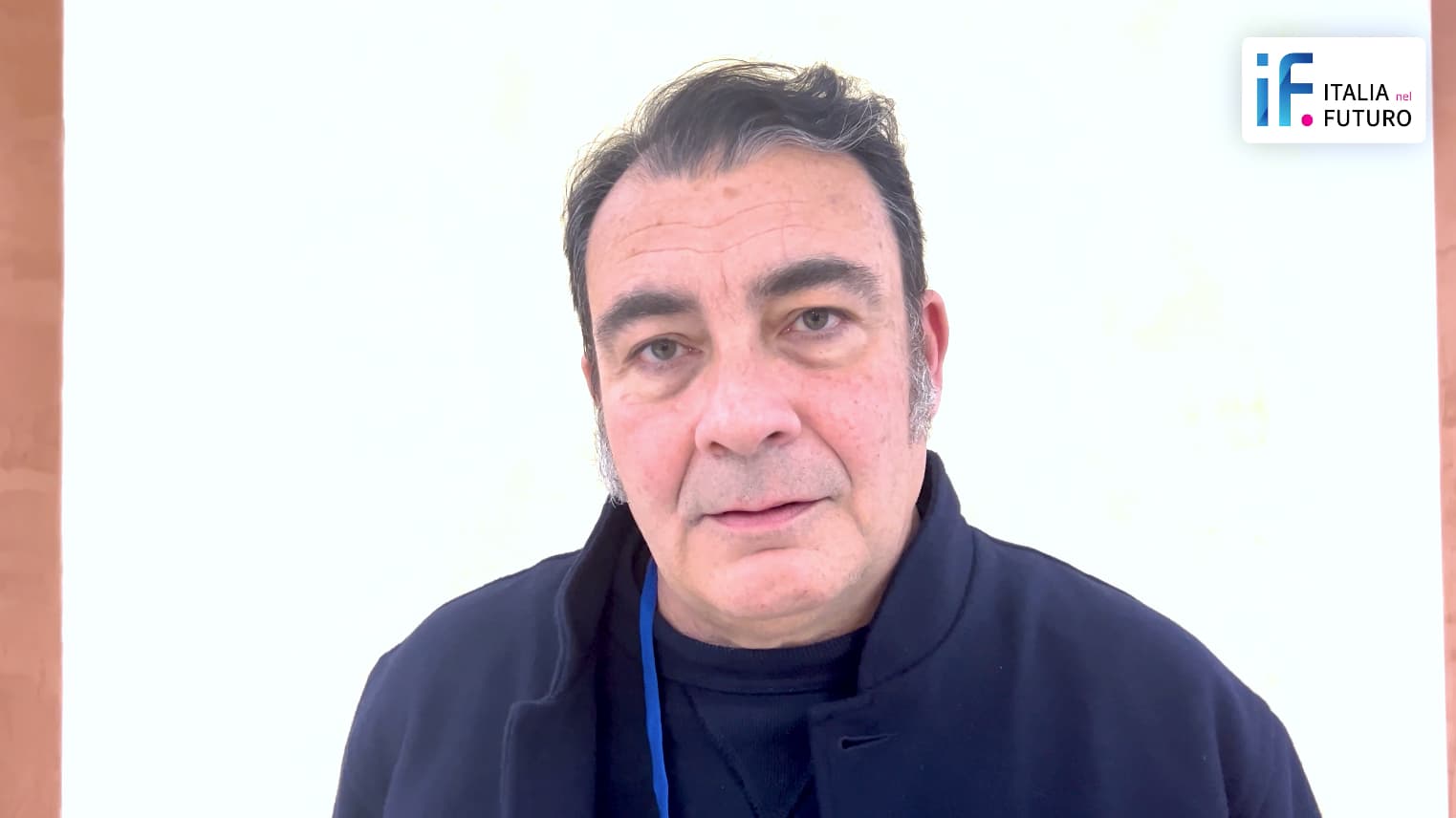Zuchongzhi 3.0 segna un’accelerazione senza precedenti per la Cina nella sfida tecnologica globale. Un’analisi tra scienza, strategia e geopolitica, dove il quantum computing diventa il nuovo campo di battaglia per la supremazia mondiale.
Zuchongzhi 3.0: il cuore tecnologico dell’innovazione cinese
Nel mondo in rapido mutamento della scienza e della tecnologia, dove un anno può valere un secolo e un chip può cambiare il destino di una nazione, il nome Zuchongzhi 3.0 ha iniziato a circolare con crescente insistenza. E non è un caso.
Annunciato con enfasi dai ricercatori dell’Università di Scienza e Tecnologia della Cina (USTC), questo processore da 105 qubit superconduttivi ha eseguito un test di benchmark — il noto Random Circuit Sampling — con una velocità che, a detta degli stessi autori, supera di un quadrilione di volte quella dei più potenti supercomputer del mondo.
Ma cosa significa tutto questo? Significa che un compito computazionale, che Frontier — secondo supercomputer mondiale — impiegherebbe 5,9 miliardi di anni a concludere, Zuchongzhi lo ha completato in pochi secondi. Significa anche che ha superato di un milione di volte il tempo di esecuzione del chip Sycamore di Google. Sì, un milione di volte.
Il paragone con il Willow QPU, l’ultima creazione di Google, è d’obbligo: il chip cinese lo tallona da vicino, con prestazioni leggermente inferiori in termini di fedeltà (99,90% contro 99,97% sulle porte a qubit singolo), ma con una velocità che — se confermata su larga scala — potrebbe ridefinire l’intero panorama della computazione quantistica.
Dietro l’eccellenza: materiali, ingegneria e innovazione di processo
Ogni rivoluzione ha i suoi strumenti, le sue alchimie nascoste. Zuchongzhi 3.0 non fa eccezione.
La sua architettura si fonda su materiali preziosi e selezionati con cura: tantalio e alluminio, legati tra loro grazie a un sofisticato processo flip-chip con bump in indio, che riduce le impurità e migliora la stabilità delle connessioni. Una scelta non banale — e nemmeno economica — ma necessaria per mantenere la coerenza quantistica in ambienti ultra-raffreddati.
La fedeltà operativa del chip — 99,90% per operazioni su singolo qubit, 99,62% per le operazioni su coppie — è un indicatore tecnico, certo, ma anche simbolico: dimostra che la Cina non si limita più a rincorrere; oggi, può innovare con piena consapevolezza dei propri mezzi.
Dietro questo traguardo, però, non c’è solo tecnologia: c’è una filiera scientifica ben orchestrata, fatta di accademia, laboratori pubblici e spin-off di Stato. Il nome di Pan Jianwei, fisico quantistico di fama internazionale, ricorre spesso: è lui la figura chiave dietro l’impulso che ha trasformato Hefei nella “Silicon Valley” quantistica d’Oriente.
USA vs Cina: la nuova Guerra Fredda della computazione
Chi guiderà il futuro? Chi detterà gli standard della sicurezza, della crittografia, delle comunicazioni digitali del domani?
La corsa al quantum computing è diventata un affare di Stato, e più ancora, una questione di supremazia globale. Gli Stati Uniti, con i loro colossi privati — Google, IBM, D-Wave — sembrano mantenere il vantaggio teorico. Ma la Cina, con la forza della pianificazione statale e della coesione istituzionale, ha lanciato una sfida che pochi anni fa sembrava impensabile.
Secondo il rapporto MERICS (2024), la Cina ha già stanziato oltre 15 miliardi di dollari per lo sviluppo quantistico — quattro volte gli investimenti pubblici statunitensi — e pubblica ormai più articoli scientifici a tema rispetto a qualsiasi altro paese. Il settore è dominato dall’approccio “whole-of-nation”, dove ogni attore — università, aziende, esercito — ha un posto preciso in un disegno di lungo periodo.
Il quantum non è più solo calcolo: è sicurezza nazionale, è difesa, è influenza globale. Lo dimostra un episodio del 2024: scienziati cinesi, usando un computer quantistico canadese, hanno dimostrato di poter decifrare segmenti del sistema di crittografia AES, quello utilizzato dalle forze armate. Un test, forse; ma anche un segnale. Un campanello d’allarme.
La Cina al centro: strategia, industria e indipendenza tecnologica
Che cosa rende la Cina così efficace, così veloce, così determinata in questa corsa? La risposta è duplice: centralizzazione e indipendenza.
Sul fronte industriale, aziende come QuantumCTek e Origin Quantum — entrambe con sede a Hefei — agiscono come prolungamenti del sistema statale. Producono, sperimentano, integrano. QuantumCTek, in particolare, ha costruito insieme allo Stato una rete nazionale di comunicazione quantistica lunga 12.000 km — la più estesa al mondo — e partecipa allo sviluppo dei satelliti quantistici Micius e Jinan-1, destinati a integrare una rete terra-spazio senza precedenti.
Ma l’indipendenza si gioca anche sui dettagli — e qui il report MERICS (2024) è illuminante: nel 2024, la Cina ha iniziato a produrre in proprio i refrigeratori a diluizione EZ-Q, componenti critici per raffreddare i computer quantistici a 0,1 Kelvin. Non si tratta solo di ingegneria: è sovranità tecnologica.
L’obiettivo è chiaro: de-occidentalizzare le filiere, rendere la Cina autosufficiente nel quantum, come lo è già nei satelliti o nelle telecomunicazioni 5G. Un obiettivo che ha implicazioni globali, ben oltre la scienza.
Governi, alleanze e standard: verso una governance globale del quantum
E l’Europa? E il resto del mondo? Davanti a questa accelerazione cinese, la comunità internazionale inizia a porsi domande — non solo tecniche, ma etiche, politiche, regolatorie.
Il problema non è solo chi arriva primo — ma chi decide cosa è giusto fare con queste tecnologie. La Cina, attraverso il proprio comitato di standardizzazione istituito nel 2023, ha iniziato a proporre regole e protocolli internazionali, spesso senza confronto con i partner occidentali. E se ciò dovesse consolidarsi, il rischio è evidente: una dominazione normativa, più che tecnologica.
Organismi come l’IEEE stanno correndo ai ripari, cercando di coinvolgere i vari blocchi geopolitici nella definizione di uno standard condiviso. Ma la strada è in salita, anche per via delle barriere crescenti alla collaborazione scientifica, imposte da entrambe le parti. Anche in Europa — pur eccellente nella ricerca di base — mancano infrastrutture, fondi privati, visione industriale. Il progetto EuroQCI è ancora troppo acerbo per rappresentare una vera risposta strategica.
Dunque: come si governa il futuro? Come si condividono tecnologie che possono essere usate per proteggere o dominare, connettere o sorvegliare, liberare o vincolare?
Non sarà una questione solo di scienza. Sarà, sempre più, una questione di governo del mondo.