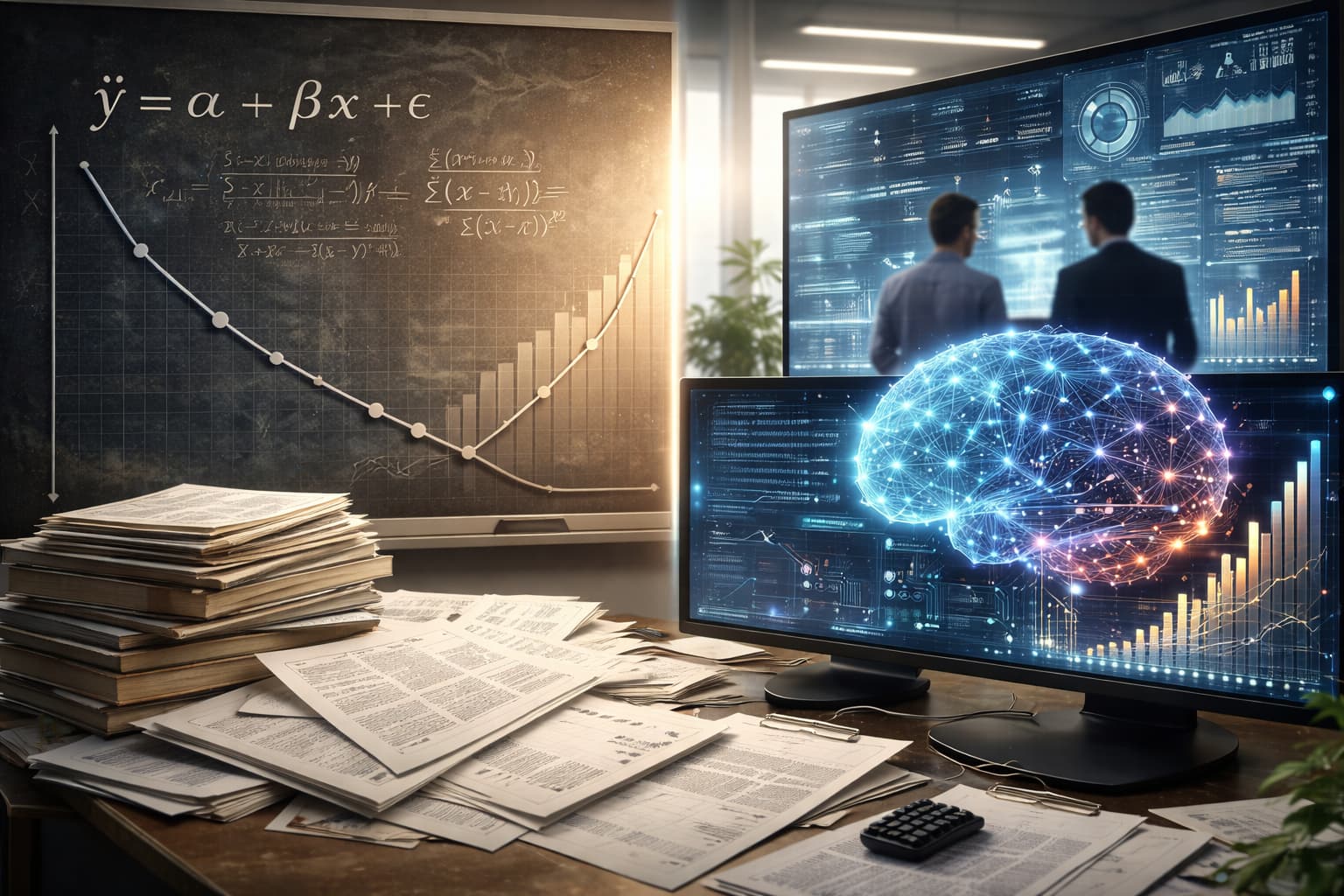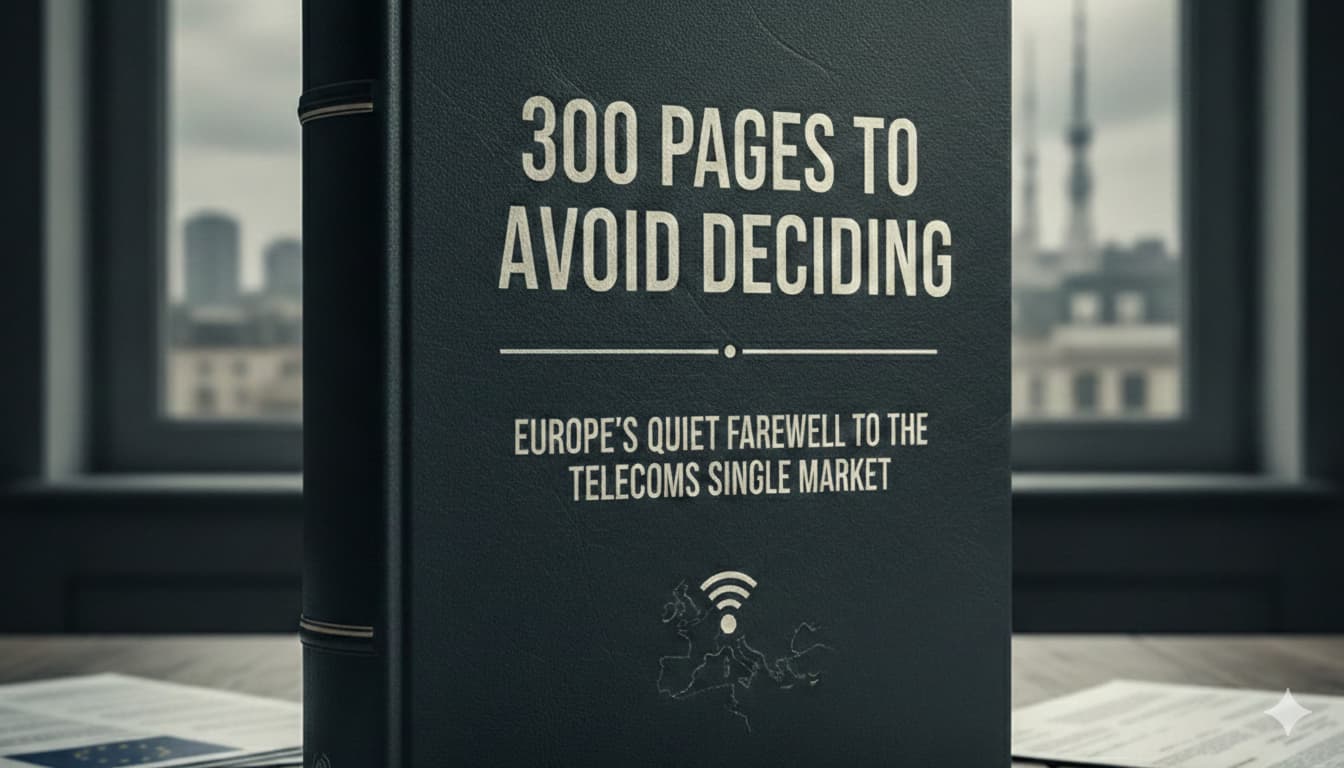Ricercatori internazionali rivelano comunità chimio-sintetiche negli abissi più profondi della Terra, sfidando le teorie sull’origine e i limiti della vita.
Un team scientifico internazionale ha annunciato la scoperta di forme di vita complesse che prosperano a oltre 9.500 metri di profondità nelle fosse delle Curili-Kamčatka e delle Aleutine, nell’oceano Pacifico nord-occidentale. Pubblicati sulla rivista Nature, i risultati rappresentano la prima prova sistematica dell’esistenza di vaste comunità marine che si sviluppano in ambienti caratterizzati da oscurità totale, temperature vicine allo zero e pressioni superiori a 1.000 atmosfere.
Utilizzando sommergibili di ultima generazione, i ricercatori hanno identificato reti stabili di vermi tubicoli, molluschi e microrganismi. Il contesto esplorativo e la complessità degli habitat osservati confermano che la biodiversità degli abissi è molto più dinamica e adattabile di quanto si pensasse.
Sfida alle teorie tradizionali sull’abitabilità
La scoperta mette in discussione assunti di lunga data sulla sopravvivenza biologica in ambienti estremi. Fino a pochi anni fa, si riteneva che le profondità superiori agli 8.000 metri potessero ospitare solo forme di vita microbiche. Tuttavia, la presenza di organismi pluricellulari a tali profondità suggerisce che le condizioni ambientali estreme non sono necessariamente incompatibili con la complessità biologica.
Julie Huber, microbiologa presso la Woods Hole Oceanographic Institution, ha definito il ritrovamento una “svolta concettuale nella biologia marina”. Gli autori principali dello studio, Mengran Du dell’Accademia Cinese delle Scienze e Vladimir Mordukhovich dell’Accademia Russa delle Scienze, hanno sottolineato come queste scoperte possano ridefinire i limiti noti della biosfera terrestre.
Sopravvivenza basata sulla chemiosintesi
A differenza della maggior parte della vita marina che dipende dalla fotosintesi, gli organismi identificati in queste profondità sfruttano la chemiosintesi per sopravvivere. Questo processo, che utilizza l’energia derivante da reazioni chimiche piuttosto che dalla luce solare, consente a microbi e invertebrati di alimentarsi grazie a composti come l’idrogeno solforato e il metano, presenti nel sedimento oceanico.
I microrganismi formano la base della catena alimentare locale, sostenendo la vita di organismi più complessi che si nutrono direttamente di batteri o dei loro sottoprodotti. Questi ecosistemi “isolati” dimostrano una sorprendente autosufficienza, basata esclusivamente su processi geochimici e microbiologici.
Implicazioni per la scienza planetaria e l’evoluzione
Il contesto di queste scoperte ha profonde implicazioni interdisciplinari. Non solo rafforzano la tesi che la vita possa esistere in ambienti estremi anche su altri pianeti o lune del sistema solare (come Europa o Encelado), ma forniscono nuove piste per comprendere le origini della vita sulla Terra stessa.
Secondo gli scienziati, questi habitat profondi possono aver funzionato come “incubatori” evolutivi, isolati ma stabili, dove la selezione naturale ha favorito adattamenti unici. Inoltre, rappresentano potenziali riserve genetiche per applicazioni future in biotecnologia, farmacologia e ingegneria ambientale.
Esplorazione delle zone abissali: una frontiera ancora aperta
La ricerca si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per l’esplorazione oceanica profonda. Solo quest’anno, il sommergibile cinese Fendouzhe ha individuato oltre 3.000 nuove specie microbiche nella Fossa delle Marianne. Queste iniziative confermano che gran parte della biodiversità terrestre si trova ancora in ambienti non esplorati.
Con l’80% della zona abissale globale ancora sconosciuta, gli esperti sottolineano l’urgenza di investire in tecnologie di esplorazione, sensoristica ad alta pressione e sistemi di campionamento remoti. L’interesse crescente da parte di agenzie spaziali e organismi intergovernativi suggerisce che gli abissi oceanici potrebbero diventare il prossimo grande laboratorio di frontiera per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica.