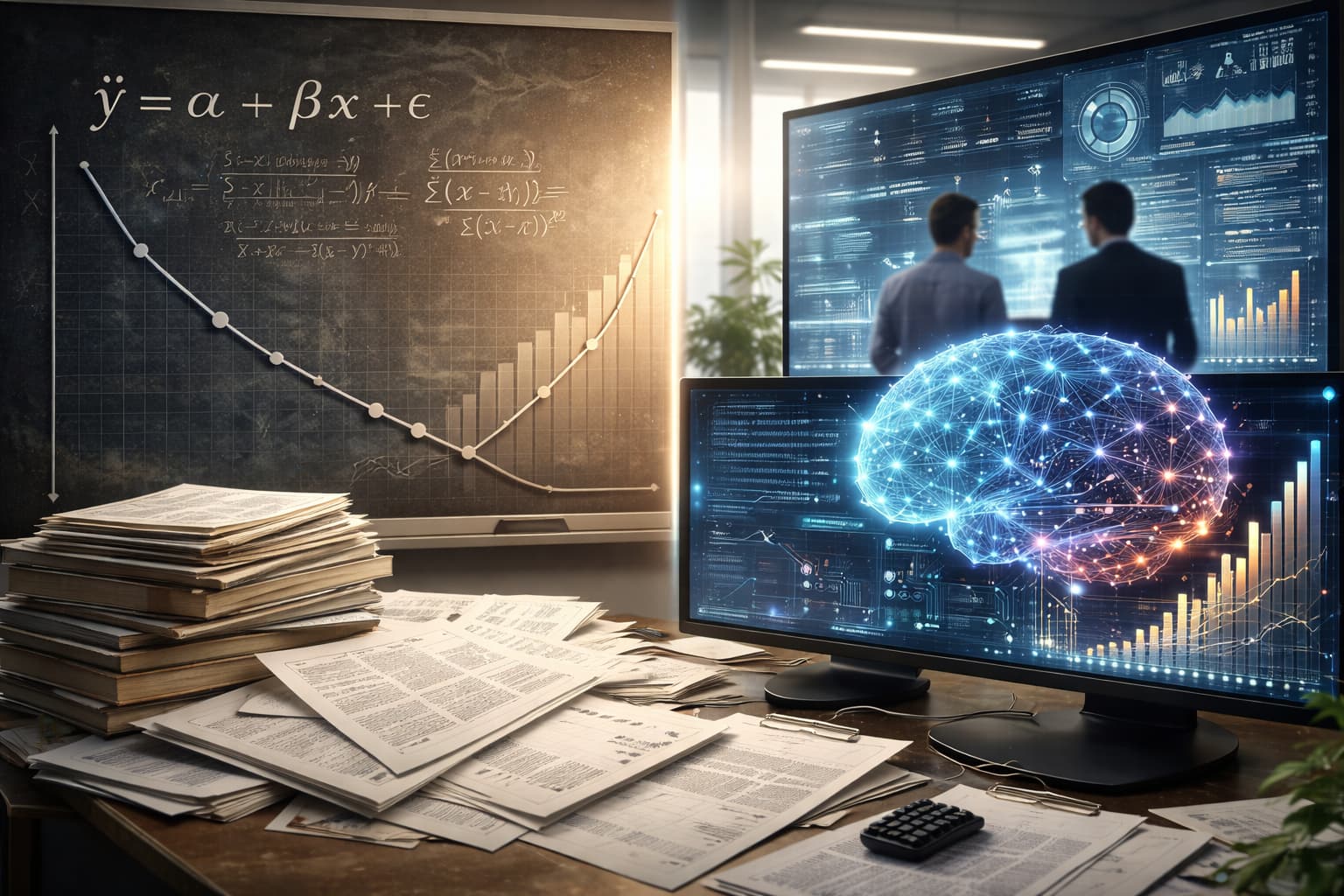L’ultima edizione del rapporto Emissions Gap dell’ONU descrive come le politiche attuali ci stiano spingendo verso un riscaldamento globale di circa 2,8 °C rispetto all’era preindustriale, ben oltre gli obiettivi di Parigi.
Malgrado impegni e promesse, le emissioni globali continuano a salire: solo un cambiamento radicale può ancora evitare la frattura della sicurezza climatica mondiale.
Nel corso dell’ultima settimana, il United Nations Environment Programme (UNEP) ha lanciato un allarme che non si può più ignorare: le politiche climatiche attuali stanno spingendo il pianeta su una traiettoria di circa +2,8 °C di aumento medio della temperatura globale entro fine secolo.
Questo dato, che supera largamente l’obiettivo più ambizioso dell’Paris Agreement di contenere l’aumento a 1,5 °C, segnala che non siamo più semplicemente in ritardo: siamo in rotta verso un collasso climatico, parola scelta dallo stesso segretario generale dell’ONU.
In questo articolo esploreremo cosa significa questa soglia, perché siamo arrivati a questo punto, quali rischi concreti ci attendono e, soprattutto, quali scelte ci restano.
Scenario +2,8 °C. Oltre la soglia dell’“accettabile”
Il rapporto dell’UNEP evidenzia che, se tutti gli attuali impegni nazionali venissero rispettati senza ulteriori miglioramenti, l’aumento stimato scenderebbe a circa +2,3 °C–2,5 °C. Ma con i livelli di politica attuale (ossia quanto effettivamente in atto, non solo annunciato), la cifra sale appunto a +2,8 °C.
Questo significa che, anche nel caso più ottimistico, il margine di sicurezza si è quasi dissolto: il limite di 1,5 °C non è più realisticamente evitabile. E se prevalgono le politiche “business as usual”, rischiamo di superare anche la soglia di 2 °C, un traguardo che molti scienziati considerano punto di non ritorno per alcune catastrofi ambientali.
È utile ricordare che solo pochi anni fa le proiezioni parlavano di +3 °C o oltre per questo secolo: il fatto che il margine sia sceso a 2,8 °C è un piccolo progresso, ma la sostanza è che non è abbastanza.
Le cause del divario tra promesse e realtà
Perché siamo in questa situazione? Il rapporto indica diverse ragioni critiche:
- Le emissioni globali nel 2024 sono aumentate del 2,3% rispetto all’anno precedente. Un’accelerazione rispetto alla media decennale.
- Le politiche climatiche annunciate (“Nationally Determined Contributions” o NDC) in molti casi non sono accompagnate da misure concrete di implementazione. Il rapporto segnala che gran parte del miglioramento nel calcolo delle proiezioni dipende da aggiornamenti di dati o metodologie e non da svolte politiche reali.
- Alcuni grandi emettitori, tra cui gli Stati Uniti, hanno annunciato o attuato inversioni di rotta nelle politiche climatiche. Questo ha giocato un ruolo nella revisione verso l’alto delle stime.
- La crisi della deforestazione, l’uso del suolo e la combustione di combustibili fossili rimangono driver essenziali delle emissioni globali.
Abbiamo, quindi, molta buona volontà a parole, ma poca volontà reale nei fatti e ogni anno di procrastinazione rende più difficile il riavvolgimento della traiettoria.
Impatti anticipati: non è più “domani” ma “oggi”
Un riscaldamento medio globale di +2,8 °C non è un numero astratto: comporta impatti profondi su società, economia, biodiversità. Tra i principali:
- Ondate di calore estreme, con lunghezze e intensità superiori a quelle viste fino ad oggi, aumenteranno la mortalità per surriscaldamento e peggioreranno le condizioni sanitarie nelle aree urbane e rurali.
- L’innalzamento del livello del mare accelererà, con maggiore frequenza di inondazioni costiere e perdita di terreni abitativi o agricoli. Anche differenze di pochi decimi di grado in meno di riscaldamento hanno effetti significativi sul numero delle persone a rischio.
- Ecosistemi sensibili come barriere coralline, foreste pluviali tropicali, ghiacciai alpine e artici subiranno contrazioni e collassi: la perdita biologica non è solo una questione ambientale, ma economica e sociale.
- Sicurezza alimentare e idrica saranno messe a dura prova: siccità più frequenti o precipitazioni più intense, combinate con sistemi agricoli fragili, rischiano di alimentare crisi migratorie, conflitti e instabilità geopolitiche.
Si apre una finestra di conseguenze che estende la crisi climatica dal regno dell’“altro futuro” a quello del presente.
Quali azioni ancora sono possibili e perché il tempo è contro di noi
Nonostante il quadro cupo, il rapporto dell’ONU ricorda che non è ancora del tutto troppo tardi: tecnicamente, contenere l’aumento entro 1,5 °C è ancora possibile, a patto di una riduzione immediata e drastica delle emissioni.
Tuttavia, questo richiede:
- La fine incontestabile dei sussidi ai combustibili fossili e la chiusura graduale delle centrali più inquinanti.
- Investimenti rapidi e massicci nelle energie rinnovabili, infrastrutture resilienti e tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio.
- Cooperazione internazionale rafforzata: i paesi più vulnerabili rischiano di essere travolti e occorre che i grandi emettitori assumano leadership concreta e includano la finanza climatica come pilastro del negoziato globale.
- Cambiamenti sociali e comportamentali: non basta la politica, serve una trasformazione culturale ed economica che renda la decarbonizzazione un fatto quotidiano.
Il rapporto avverte che ogni anno di attesa aumenta il fabbisogno di riduzione delle emissioni: più si aspetta, più drastica dovrà essere la manovra dopo, con costi enormi in termini economici, sociali e ambientali.
Il bivio geopolitico-economico
Al di là delle tecnologie e delle politiche, la crisi climatica è anche una crisi geopolitica ed economica. Il rapporto dell’ONU arriva in un momento di fragile cooperazione internazionale: il percorso verso la COP 30 è segnato dall’assenza di alcuni leader chiave e dalla mancanza di nuovi impegni vincolanti.
L’economia globale, inoltre, resta altamente legata ai combustibili fossili: l’industria, gli investitori e i mercati stanno ancora scommettendo su profitti legati a petrolio, gas e carbone. La contraddizione è evidente: da un lato emergono allarmi netti, dall’altro la logica del lucro e della crescita salvaguarda l’inerzia.
Questo rende la crisi climatica non solo un problema tecnico, ma politico e etico: decidere di uscire dalla “zona di comfort” economica oggi significa evitare che la vita adulta delle prossime generazioni diventi un bilancio di danni incalcolabili.
Verso una visione critica e visionaria
Il mondo si trova ora a un bivio: procedere come finora significa accettare un futuro segnato da rotture ambientali, costi sociali elevatissimi e una vita umana profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Oppure, e c’è ancora una scelta, reagire con urgenza, coerenza e coraggio.
Immaginiamo un pianeta dove le città costiere non sono sommerse, dove la biodiversità continua a sostenere il benessere umano, dove l’agricoltura non è costantemente in crisi e dove la coesione globale prevale sulla competizione degli Stati-Nazione per risorse finite. Questo non è un sogno ingenuo: è un orizzonte concreto a portata di mano, ma solo se agiamo subito.
L’allarme dell’ONU sul +2,8 °C non è un bollettino di fine; è un appello: urgente, chiaro, irrevocabile. Quando si dice “collasso climatico” non si tratta di un’iperbole mediatica: è il linguaggio che riflette la realtà di un sistema che sta per superare i suoi limiti.
Così, guardando oltre: la vera domanda non è più «se» ma «come»» avremo il coraggio di plasmare il prossimo decennio. Perché il tempo delle “politiche dilazionate” è finito. La storia del pianeta non aspetta.