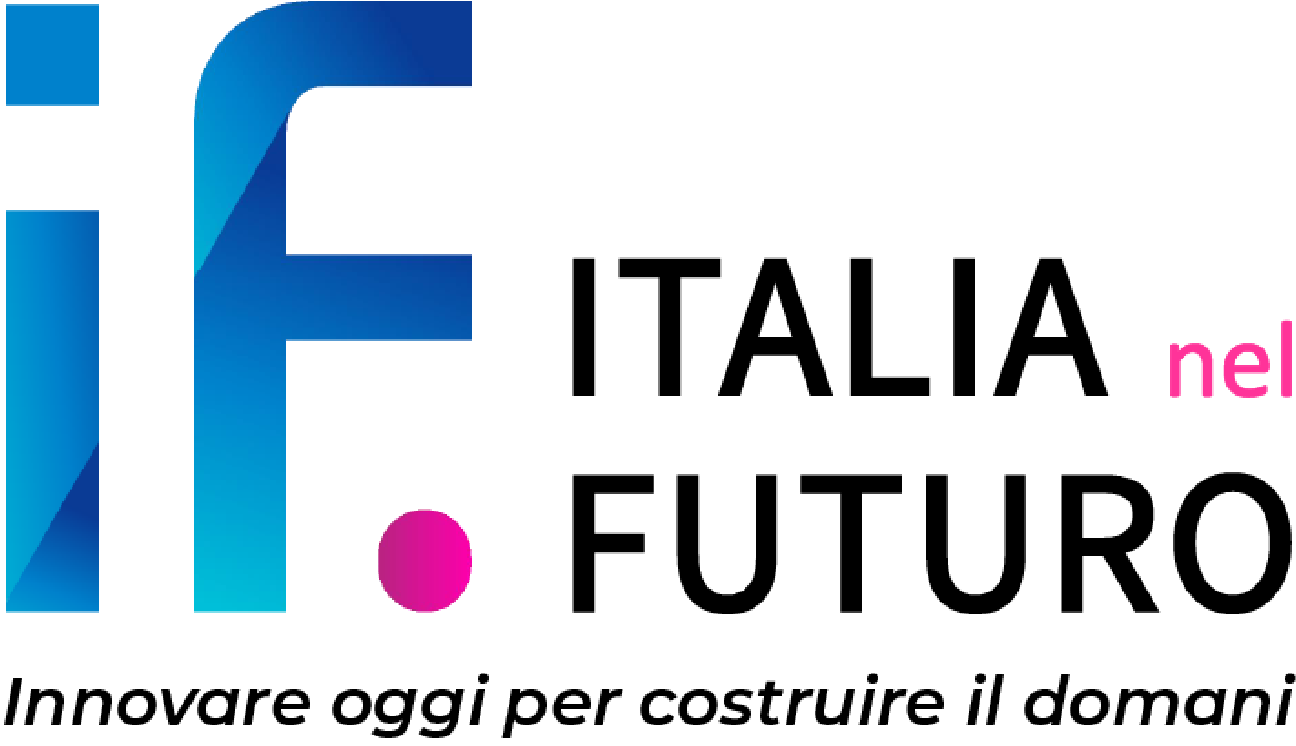Nel dibattito pubblico l’intelligenza artificiale continua a essere raccontata come una tecnologia leggera, diffusa, quasi immateriale. Il linguaggio del cloud ha svolto a lungo una funzione rassicurante: evocare una potenza di calcolo sempre disponibile, senza attrito, senza luogo. Oggi quella metafora non regge più. L’AI contemporanea non fluttua nell’etere digitale: poggia su una base fisica estesa, costosa ed energivora che assomiglia sempre più a una grande industria del Novecento. Riconoscere questa trasformazione non è un dettaglio semantico, ma il punto di partenza per una riflessione strategica sul futuro economico e politico dell’innovazione.
L’intelligenza artificiale vive di infrastrutture materiali: data center, reti ad altissima capacità, sistemi di raffreddamento, approvvigionamenti energetici continui. Ogni modello avanzato è il risultato di elettricità trasformata in calcolo, di silicio trasformato in previsione statistica, di capitale immobilizzato in impianti che consumano suolo, acqua ed energia. Parlare di AI senza parlare di questa base significa accettare una narrazione incompleta, che nasconde costi, vincoli e asimmetrie. È su questo terreno che l’AI smette di essere solo una tecnologia e diventa un fatto industriale.
Al centro di questa trasformazione c’è il calcolo come fattore produttivo. Nell’economia dell’AI il compute non è abbondante: è scarso, costoso e concentrato. La domanda cresce più rapidamente della capacità di renderlo accessibile, mentre i miglioramenti di efficienza algoritmica rallentano ma non invertono la tendenza. Ne deriva un circuito cumulativo ben noto alla storia industriale: chi investe su larga scala riduce il costo unitario, attrae applicazioni e ricavi, reinveste in infrastrutture sempre più grandi. Chi resta fuori da questo circuito utilizza l’AI, ma non ne orienta lo sviluppo. La competizione sugli algoritmi si sposta così a monte, sull’accesso al calcolo. Questa dinamica produce concentrazione e rendite infrastrutturali. Il controllo del compute consente non solo vantaggi economici, ma anche un potere cognitivo: decide quali traiettorie di ricerca sono esplorabili, quali sperimentazioni sono sostenibili, quali applicazioni diventano standard. Il parallelo con le grandi infrastrutture del passato è evidente. Come ferrovie ed energia elettrica, anche l’AI ridisegna economie e territori non per ciò che promette, ma per come viene costruita e governata. La differenza è che, nel caso dell’AI, questa trasformazione avviene spesso senza una deliberazione esplicita. Il nodo energetico rende la questione ancora più concreta. I data center sono nuove industrie energivore che concentrano la domanda in aree specifiche, incidendo sulle reti, sui prezzi e sull’accettabilità sociale. Il costo dell’energia determina il costo del calcolo; la sua disponibilità orienta la localizzazione; la sua sostenibilità ambientale condiziona il consenso. L’AI, frequentemente presentata come alleata della transizione, diventa essa stessa una variabile critica della politica energetica. Non si tratta solo di quanta energia serva, ma di quando, dove e a quali condizioni venga fornita.
A questa dimensione si aggiunge quella territoriale. Le infrastrutture dell’AI occupano spazio, modificano l’uso del suolo, generano benefici spesso lontani dai luoghi che ne sopportano i costi. Senza una governance consapevole, il rischio è la proliferazione di enclavi tecnologiche scollegate dal contesto economico e sociale che le ospita. L’innovazione, invece di diventare leva di sviluppo diffuso, si traduce in una nuova forma di estrazione di valore. In Europa questa consapevolezza sta emergendo. Le iniziative per costruire capacità di calcolo condivise, come quelle legate a EuroHPC, segnalano un cambio di paradigma: non solo regolare l’AI, ma costruirne le basi materiali. È una risposta a un problema riconosciuto anche da organismi internazionali come OECD e World Bank, che evidenziano come l’accesso al compute condizioni la capacità di innovare e competere. Ma l’infrastruttura non è neutra. Senza criteri di accesso, competenze adeguate e una domanda pubblica consapevole, anche l’investimento condiviso rischia di rafforzare dipendenze esistenti. Il caso italiano rende queste tensioni particolarmente visibili. Il Paese è al tempo stesso attrattivo per nuovi investimenti e segnato da fragilità strutturali: reti energetiche sotto pressione, iter autorizzativi complessi, frammentazione delle politiche. In assenza di una strategia integrata, l’infrastruttura dell’AI tende a svilupparsi per opportunità contingenti più che per disegno collettivo. Il rischio non è l’arretratezza tecnologica, ma una modernizzazione senza direzione: si adotta l’AI senza governarne le condizioni.
Governare l’intelligenza artificiale significa quindi partire dall’infrastruttura. Riconoscerla come bene strategico, definire criteri di localizzazione, condizioni di accesso, meccanismi di compensazione territoriale. Integrare il calcolo nelle politiche industriali ed energetiche, anziché trattarlo come un effetto collaterale dell’innovazione digitale è una scelta politica nel senso più pieno del termine, perché riguarda la distribuzione del potere, delle opportunità e dei costi. Rendere visibile il peso dell’AI non vuol dire negarne il valore, ma restituire realtà a ciò che la rende possibile. Il cloud, così come viene raccontato, non esiste; esistono infrastrutture che decidono il futuro un rack alla volta. E se l’intelligenza artificiale è destinata a trasformare economie e società, è su questa base materiale che va esercitata, prima di tutto, una responsabilità pubblica.