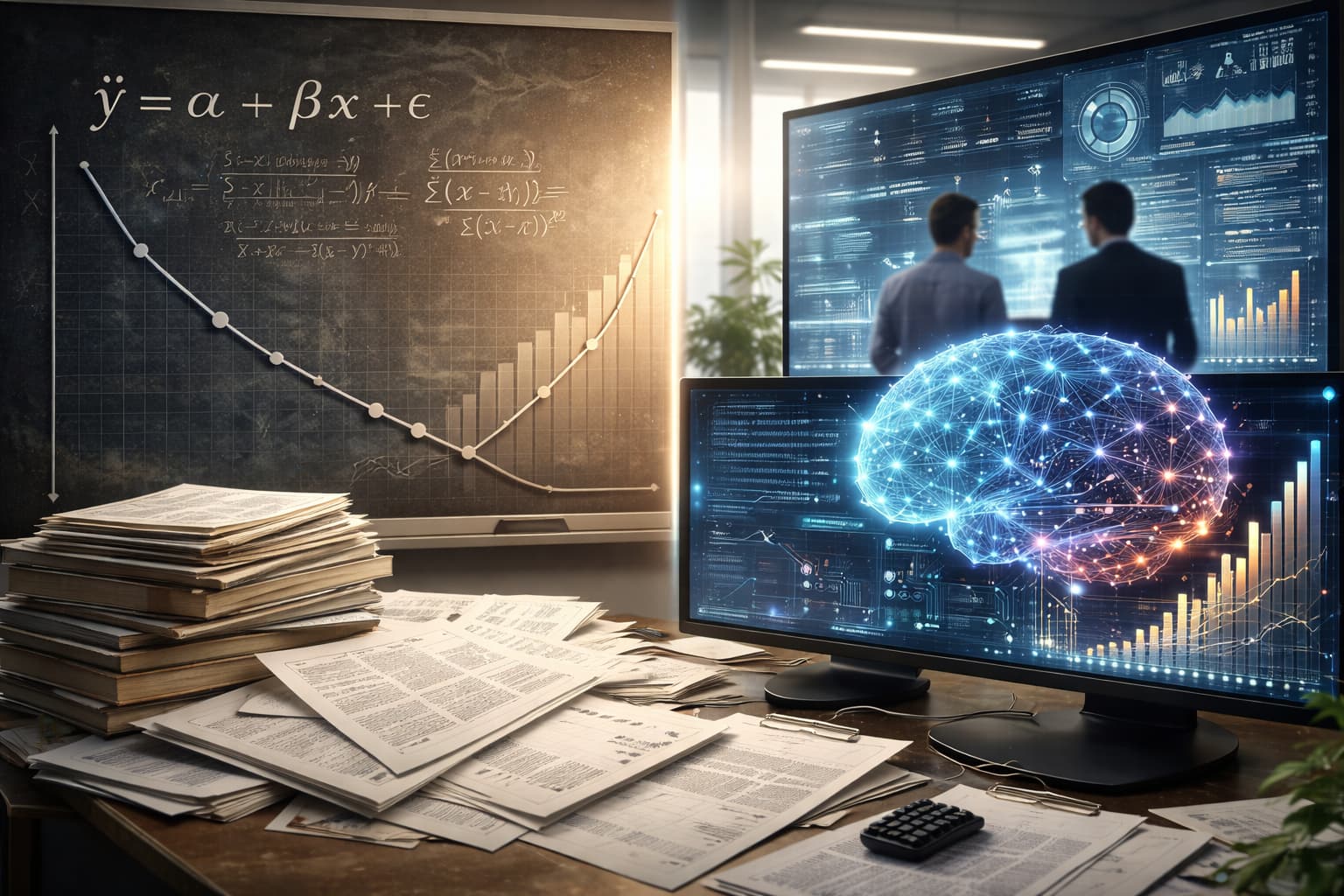La presidente della BCE mette in guardia Bruxelles: senza regole equivalenti per gli emittenti esteri, il sistema europeo potrebbe trovarsi al centro di corse ai riscatti e squilibri finanziari.
L’Unione Europea ha costruito uno dei quadri normativi più rigidi al mondo per i mercati digitali, convinta di blindare la propria stabilità finanziaria. Ma ciò che doveva essere un vantaggio rischia di trasformarsi in vulnerabilità: Christine Lagarde avverte che i capitali globali potrebbero riversarsi sull’Europa nei momenti di crisi, sfruttandone le garanzie. La partita dei stablecoin non è più una questione tecnica: è la nuova frontiera della geopolitica monetaria.
L’Europa e la sfida di governare la finanza digitale
Con il MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), l’Unione Europea si è posta come laboratorio mondiale di regolamentazione della finanza digitale. La normativa impone agli stablecoin, ossia cripto-attività ancorate a valute ufficiali, di essere coperti al 100% da riserve liquide. L’obiettivo dichiarato è ridurre i rischi sistemici e proteggere i consumatori.
Questa architettura, però, non è sufficiente se gli operatori esteri possono accedere al mercato europeo senza sottostare agli stessi obblighi. L’asimmetria crea un rischio evidente: l’Europa diventa il porto sicuro dove investitori di tutto il mondo cercheranno di riscattare i propri token in caso di crisi.
L’intervento di Christine Lagarde: un allarme preventivo
Alla conferenza regolatoria di Bruxelles, Lagarde non ha usato mezzi termini: “La legislazione europea deve garantire che gli schemi di stablecoin non possano operare nell’UE se non supportati da regimi di equivalenza solidi e da salvaguardie sui trasferimenti di asset tra entità comunitarie ed extra-UE”.
Il suo messaggio è duplice. Da un lato, invita a rafforzare la protezione contro i rischi di arbitraggio normativo; dall’altro, avverte che la stessa solidità del quadro europeo può attirare pressioni indesiderate. In altre parole, più l’Europa si mostra sicura, più rischia di diventare un magnete per crisi nate altrove.
Il nodo dei riscatti: quando la fiducia diventa vulnerabilità
Gli episodi del passato dimostrano quanto sia fragile la fiducia nei mercati digitali. Il crollo di TerraUSD nel 2022 mise in luce la velocità con cui un meccanismo di ancoraggio può saltare, trascinando con sé miliardi di dollari in poche ore.
Con il MiCAR, l’UE ha previsto la possibilità di riscattare i token in qualsiasi momento, senza commissioni. È una garanzia per gli investitori, ma rappresenta anche un potenziale boomerang: in caso di panico globale, la corsa ai riscatti si concentrerebbe in Europa, drenando le riserve locali e mettendo sotto pressione il sistema bancario. Un rischio che la BCE non può ignorare, considerato il suo ruolo di garante della stabilità.
Stablecoin e geopolitica: oltre la finanza
Dietro la questione regolatoria si nasconde un confronto geopolitico. Gli Stati Uniti stanno cercando di adattare le regole bancarie ai cripto-asset, pur mantenendo un approccio meno restrittivo. La Cina ha imboccato una strada diversa, puntando sullo yuan digitale per ridurre lo spazio degli operatori privati e rafforzare il controllo statale.
L’Europa si trova in mezzo: abbastanza regolamentata da garantire sicurezza, ma esposta al rischio di diventare terreno di arbitraggio. Per questo Lagarde insiste sulla necessità di una cooperazione internazionale: senza regole comuni, i flussi finanziari globali tenderanno sempre verso la giurisdizione più vantaggiosa, indipendentemente dalla sua stabilità di lungo periodo.
La BCE tra innovazione e prudenza
Il ruolo della BCE in questo scenario è delicato. Da un lato, deve difendere la stabilità del sistema bancario europeo; dall’altro, non può frenare l’innovazione. L’avanzamento del progetto euro digitale si inserisce proprio in questa logica: creare un’alternativa pubblica ai token privati, capace di ridurre i rischi e rafforzare la sovranità monetaria europea.
Tuttavia, il percorso è lungo e complesso. Nel frattempo, il problema più immediato rimane la gestione delle riserve e la prevenzione di shock di liquidità. È qui che si misura la capacità dell’UE di coniugare ambizione normativa e pragmatismo finanziario.
La cooperazione globale come unica via
“Senza un campo di gioco globale livellato, i rischi cercheranno sempre la via di minor resistenza”, ha ribadito Lagarde. La natura stessa dei cripto-asset, transnazionale e fluida, rende inutile qualsiasi tentativo di regolazione puramente nazionale. Gli episodi recenti – dal fallimento di FTX alle tensioni sui mercati delle stablecoin – hanno mostrato che i rischi non conoscono confini e si diffondono alla velocità della rete.
Il compito politico è, dunque, costruire un dialogo tra potenze economiche che oggi competono anche sul controllo delle infrastrutture digitali e finanziarie. Senza una cornice internazionale, l’Europa rischia di pagare il prezzo della propria avanguardia regolatoria.
La stabilità come condizione dell’innovazione
Il messaggio di Lagarde va oltre il tecnicismo. Gli stablecoin possono rappresentare una leva per integrare i mercati e migliorare l’efficienza dei pagamenti, ma senza regole equivalenti diventano una minaccia per la stabilità.
L’Europa ha scelto di fare da apripista nella regolamentazione globale, ma ora deve affrontare il lato oscuro di questa scelta: diventare troppo attraente nei momenti di crisi. La sfida è duplice: guidare l’innovazione e proteggere il sistema. Perché, in un’economia digitale interconnessa, stabilità e progresso non sono alternative, ma due facce della stessa sopravvivenza economica.