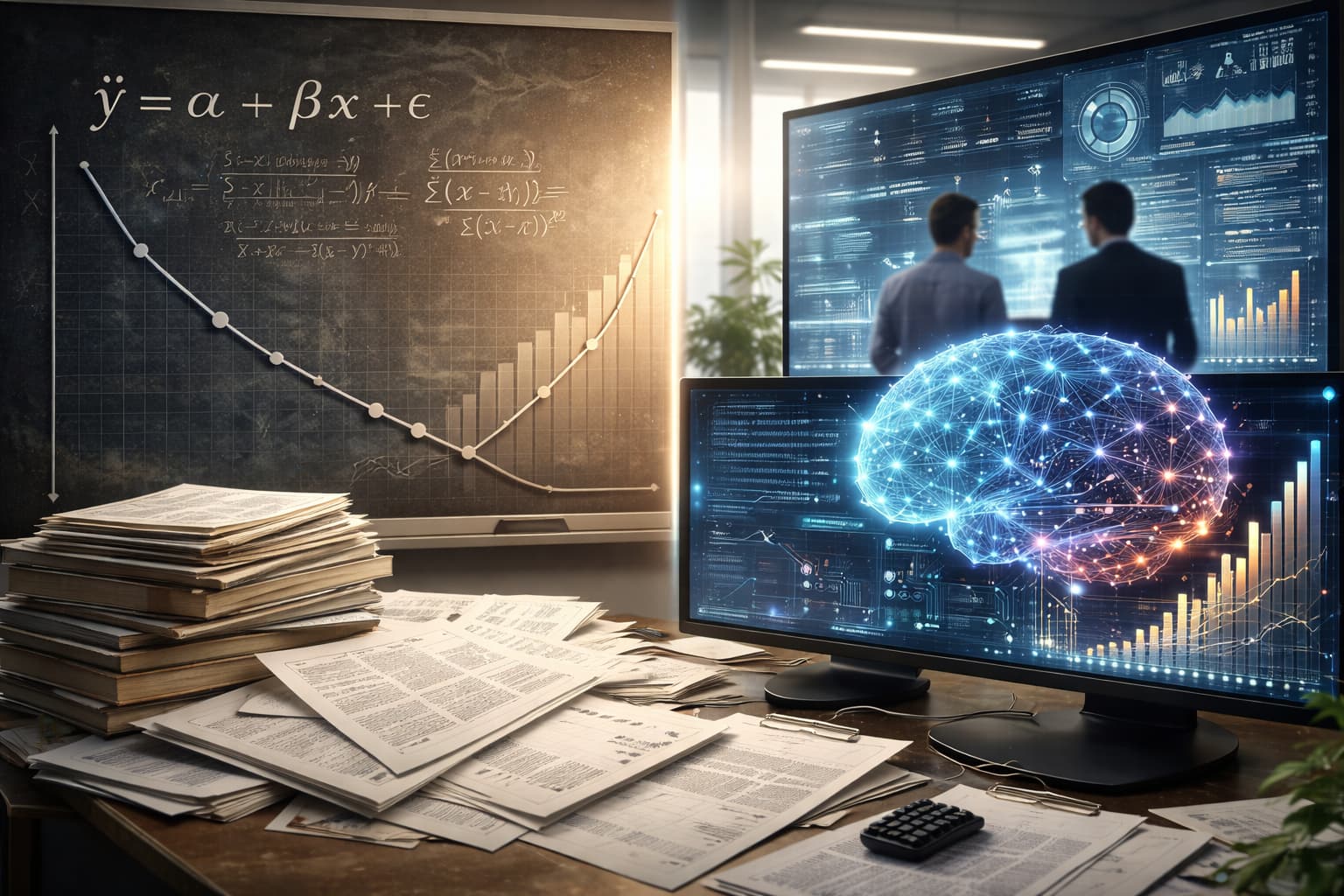Verso una nuova architettura climatica europea: transizione, compensazioni e competitività industriale nel Green Deal 2.0
La Commissione Europea ha presentato ufficialmente una proposta per ridurre del 90% le emissioni nette di gas serra entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990. Il target, parte della roadmap per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, introduce per la prima volta un elemento di flessibilità regolatoria che potrebbe ridefinire gli equilibri tra transizione ecologica, competitività industriale e diplomazia climatica internazionale.
Obiettivo 2040: una svolta strategica e politica
La proposta, pubblicata dalla Commissione oggi, rappresenta un passaggio cruciale nella costruzione della strategia climatica post-2030 dell’Unione Europea, superando il precedente traguardo intermedio del -55% entro il 2030. Il nuovo target del -90% si configura come un elemento cardine nel Green Deal Europeo, ma con un’impostazione più pragmatica rispetto al passato.
Per la prima volta, infatti, la Commissione ammette il ricorso a crediti di carbonio internazionali, consentendo agli Stati membri di acquistare quote da Paesi in via di sviluppo e di contabilizzarle fino a un massimo di 3 punti percentuali del target 2040.
Flessibilità e compensazioni: nuova governance del carbonio
Il meccanismo di compensazione proposto segna una discontinuità con le politiche climatiche europee precedenti, che avevano fatto del principio di riduzione domestica un pilastro identitario. Secondo la proposta, i crediti esterni dovranno comunque rispettare criteri stringenti di addizionalità, trasparenza e verifica, e potranno essere impiegati esclusivamente per compensare le emissioni residue in settori difficilmente decarbonizzabili.
Questa apertura rappresenta un segnale politico importante verso:
- una integrazione più ampia dei mercati del carbonio globali
- una maggiore flessibilità per l’industria europea
- una leva di finanza climatica per supportare la transizione nei Paesi emergenti.
Impatti per industria, finanza e diritto dell’innovazione
La proposta introduce implicazioni rilevanti su più fronti:
- Industria e manifattura: la possibilità di compensazione attenua il rischio di delocalizzazione (carbon leakage) e offre un buffer per settori strategici come acciaio, cemento, chimica e trasporti pesanti.
- Mercati finanziari: l’apertura ai crediti internazionali può stimolare il mercato volontario del carbonio, rafforzando l’interesse verso strumenti finanziari legati alla decarbonizzazione (green bonds, transition finance).
- Politica industriale: il pacchetto si allinea con la strategia Net-Zero Industry Act, rafforzando le sinergie tra obiettivi climatici e capacità produttiva europea nel settore clean tech.
- Diritto dell’innovazione: si delinea un contesto normativo più favorevole a soluzioni tecnologiche ibride, tra mitigazione e compensazione.
Geopolitica e negoziato istituzionale
La proposta dovrà ora essere negoziata e approvata dal Parlamento Europeo e da una maggioranza qualificata degli Stati membri, in un contesto istituzionale sensibile: il nuovo Parlamento eletto a giugno 2024 ha mostrato un orientamento più frammentato sul tema climatico, con crescenti tensioni tra obiettivi ambientali e costi sociali della transizione.
In parallelo, il ricorso ai crediti internazionali apre un fronte geopolitico delicato, in cui l’UE dovrà:
- evitare accuse di “green colonialism” o offsetting opportunistico
- garantire che i fondi generati contribuiscano realmente allo sviluppo sostenibile dei Paesi beneficiari
- presidiare i nuovi standard globali di integrità dei crediti di carbonio (inclusi quelli definiti da ICVCM, VCMI, ISO e Articolo 6 dell’Accordo di Parigi).
Verso un nuovo equilibrio climatico europeo
Il target -90% al 2040, con flessibilità incorporata, rappresenta una svolta nella regolazione della transizione ecologica europea: non solo un obiettivo ambientale, ma un atto di governance industriale, diplomazia verde e realismo economico. Il dossier climatico si conferma come una delle leve più strategiche della politica europea, con effetti trasversali su tecnologia, supply chain, investimenti e sicurezza energetica.