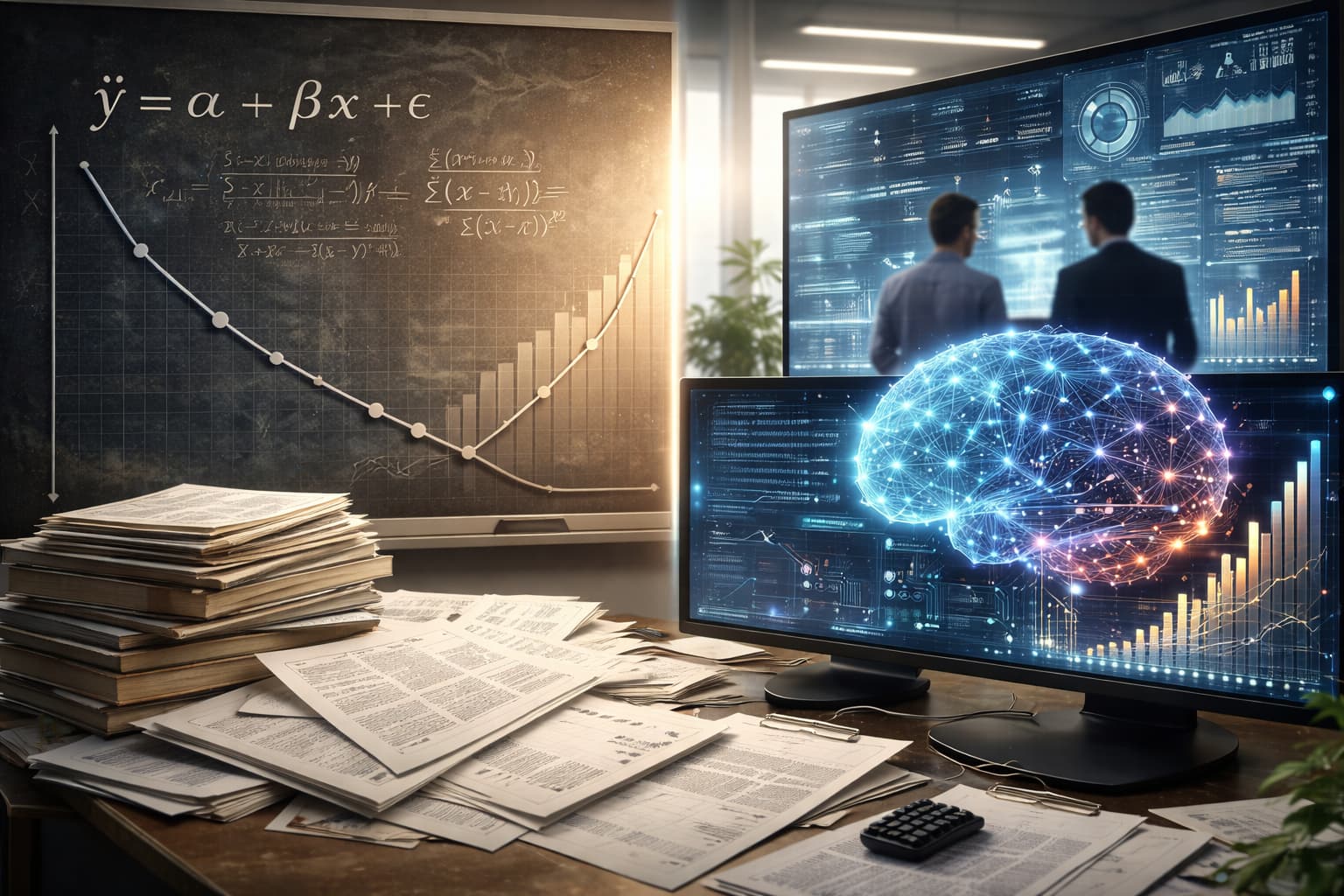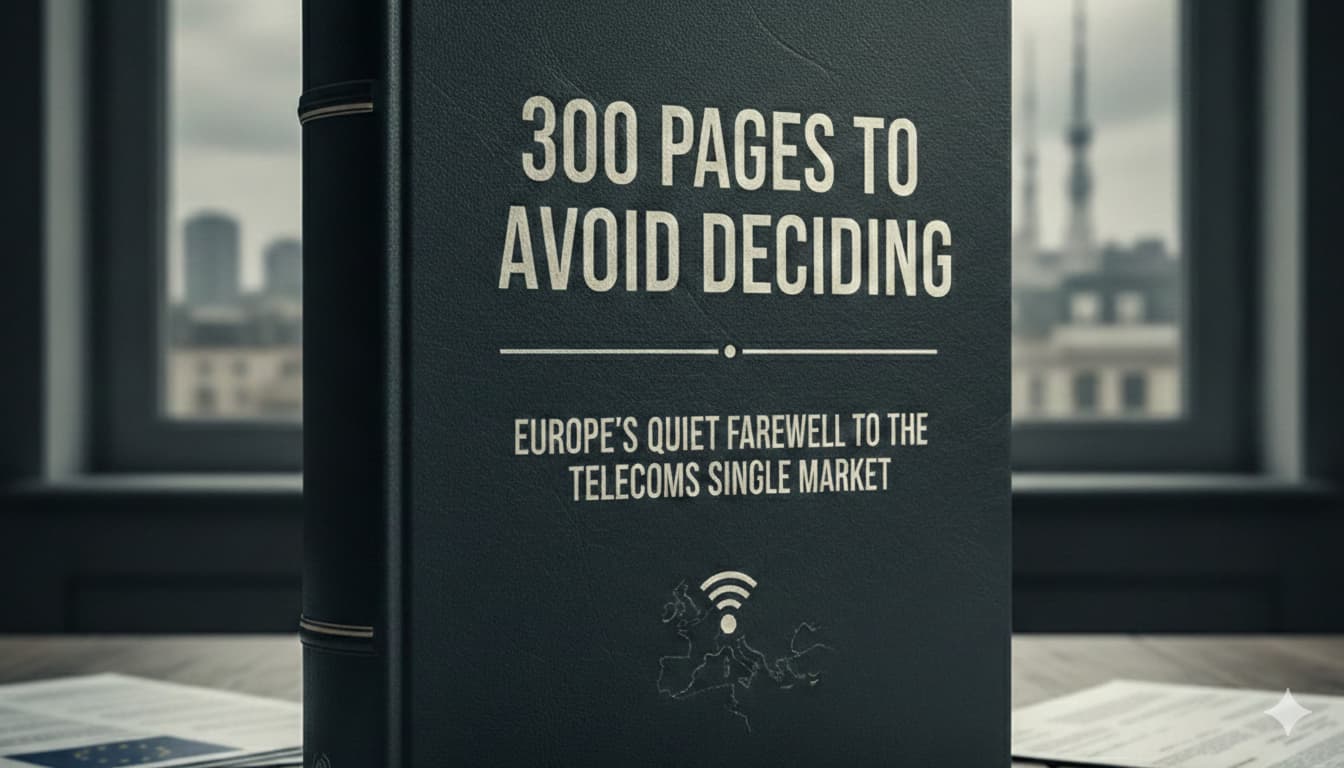L’idrogeno viene spesso rappresentato come la chiave della transizione energetica, ma dietro l’immaginario ottimistico si nascondono inefficienze strutturali e narrazioni utopiche. Analisi tecniche e culturali svelano un quadro ben più complesso e problematico.
Dietro il velo dell’efficienza apparente
È davvero possibile che l’idrogeno sia il protagonista della nostra prossima rivoluzione energetica? Potrebbe un elemento tanto leggero, il più leggero dell’universo, sostenere da solo il peso dell’intera infrastruttura energetica globale?
Sebbene spesso venga presentato come la panacea, l’idrogeno, se analizzato con attenzione e con una certa pazienza, rivela più problemi che soluzioni. Le celle a combustibile a idrogeno mostrano efficienze del 50–60%, superiori, almeno apparentemente, ai motori a combustione interna. Ma tutto questo, come spesso accade, è troppo bello per essere vero.
Perché sì, proprio lì, nella parte nascosta della catena, si celano le perdite più sostanziose. Dalla produzione all’uso finale, passando per stoccaggio, compressione, liquefazione e trasporto, l’energia si disperde. Si dissolve. Si spegne. Alla fine, ciò che rimane è un misero 20–30% dell’energia iniziale (Bossel, 2006). Vale davvero la pena?
Intanto, dall’altro lato della barricata, i veicoli elettrici a batteria conservano l’80–90% dell’energia. Sì, ottanta. Novanta. Un confronto, questo, che lascia poco spazio all’entusiasmo idrogenista.
E se qualcuno obietta che le celle a combustibile sono comunque più efficienti dei motori a scoppio tradizionali, è bene ricordare che nei contesti reali, nell’uso quotidiano, l’efficienza effettiva delle celle a idrogeno scende spesso al 40–50% (Rabbani & Grant, 2020), con il rischio concreto di offrire una prestazione appena comparabile a quella di un buon sistema ibrido. Ma con molti più problemi.
Un’economia dell’idrogeno tra frizioni fisiche e mitologie letterarie
Eppure il sogno persiste. Perché?
Forse perché non si nutre di dati, ma di storie. Di visioni seducenti, di futuri levigati e puliti, dove ogni casa, ogni aereo, ogni nave, ogni treno, si muove grazie all’idrogeno, come in un romanzo utopico. È qui che entrano in scena Jeremy Rifkin ed Erik Rakhou, con i loro libri The Hydrogen Economy (2002) e Touching Hydrogen Future (2022). Non si tratta di saggi tecnici, bensì di narrazioni speculative travestite da previsioni scientifiche.
Cosa ci raccontano questi autori? Che l’idrogeno è pronto. Che può, anzi deve, sostituire i combustibili fossili. Che può alimentare tutto, senza attriti, senza ostacoli, senza problemi. Eppure, le transizioni tecnologiche, quelle vere, non funzionano così. Non funzionano mai così.
Dove sono i costi, le infrastrutture, le transizioni industriali, le implicazioni geopolitiche? Dove sono le persone che dovranno vivere, lavorare, adattarsi e — non meno importante — pagare questo futuro?
La verità, scomoda ma necessaria, è che Rifkin e Rakhou scrivono fantascienza. Ma non quella sofisticata e problematizzante di Iain M. Banks. La loro è una fantascienza semplificata, una promessa patinata che non sopporta il peso della realtà. Un’utopia disegnata con pennarelli ad acqua, che si scioglie non appena incontra la pioggia dell’esperienza.
Le infrastrutture dimenticate e le illusioni della “curvatura energetica”
Un’intera economia a idrogeno? Un’immagine potente, seducente, scintillante.
Ma quanto costerebbe davvero costruirla?
Condutture ad alta pressione, stazioni di rifornimento sparse su tutto il territorio, impianti di liquefazione a -253 gradi Celsius, depositi ad alta sicurezza, trasporti specializzati. Tutto questo non esiste, o esiste in forma embrionale, frammentaria, inadeguata. È come voler costruire la Morte Nera dell’Impero galattico, mentre ciò di cui abbiamo bisogno sono flotte leggere, agili, decentralizzate, come gli X-Wing dell’Alleanza Ribelle.
Eppure, Rifkin e Rakhou ci parlano come se tutto questo fosse già pronto, già operativo, già testato. Come se vivessimo su un’astronave alimentata da cristalli di dilitio, dove l’energia è infinita, gratuita, invisibile. Ma l’energia, quella vera, quella che scorre nelle reti elettriche, nei serbatoi, nei tubi e nelle turbine, non ha nulla di invisibile. È materiale, è misurabile, è costosa.
E allora ci chiediamo: chi pagherà per tutto questo? Con quali fondi, con quali ritorni, con quali garanzie? E perché mai dovremmo farlo, quando l’elettrificazione diretta — più semplice, più economica, più disponibile — è già qui, già funzionante, già vincente?
I costi ignorati, la società invisibile, l’equità trascurata
Cosa accade ai lavoratori, agli artigiani, agli autotrasportatori, agli installatori, ai tecnici di rete, in un mondo completamente idrogenato? Che tipo di formazione sarà necessaria? Chi la finanzierà?
Nei futuri idrogenati di Rifkin e Rakhou, le persone scompaiono. Non ci sono scioperi, né conflitti, né disoccupazione tecnologica. Solo una transizione impeccabile, da manuale. Ma la storia dell’energia — da James Watt ai pannelli solari — racconta ben altro. Ogni rivoluzione energetica ha causato scosse telluriche: sociali, economiche, politiche.
Perché mai questa dovrebbe essere l’eccezione?
Mentre la narrativa idrogenista sorvola sulla società, l’elettrificazione distribuita lavora con essa. Coinvolge le comunità. Rafforza le economie locali. Crea posti di lavoro a chilometro zero. L’idrogeno, invece, rischia di essere un progetto centralizzato, verticale, tecnocratico. Una nuova forma di impero energetico.
L’idrogeno come Forza: universale ma ineffabile
Un altro mito si annida tra le righe dei sostenitori dell’idrogeno: quello secondo cui il vettore sarebbe perfetto per risolvere l’intermittenza delle fonti rinnovabili. L’argomento, a prima vista, sembra plausibile. Ma lo è davvero?
Produrre idrogeno da surplus fotovoltaico o eolico richiede elettrolizzatori, infrastrutture dedicate, consumo d’acqua e grandi quantità di energia. La conversione non è mai perfetta. Le perdite si sommano. Ogni passaggio — elettrolisi, compressione, trasporto, stoccaggio, riconversione in elettricità — comporta dissipazioni. Alla fine, ciò che resta dell’energia originaria è poco, talvolta troppo poco per giustificare lo sforzo.
Nel racconto dominante, invece, l’idrogeno agisce come la Forza in Star Wars: invisibile, potente, armonizzante. Ma anche la Forza, come ci ricorda Yoda, richiede equilibrio. Senza disciplina, senza saggezza, diventa pericolosa. Il lato oscuro della Forza, qui, è l’inefficienza.
L’ultima frontiera: l’immaginazione critica
Quale spazio resta, allora, per sognare?
Grande, enorme, necessario. Ma non ogni sogno è degno. Alcuni sogni illudono. Altri guidano. L’immaginazione è uno strumento potente, ma come ogni strumento richiede cura. E critica.
Le narrazioni come quelle di Rifkin e Rakhou possono ispirare. Ma non devono guidare le politiche. Perché se i sogni sostituiscono i piani, se la fiction sostituisce la progettazione, se le metafore inghiottono i bilanci, allora ci sveglieremo — ancora una volta — con l’incompiuto tra le mani.
Sogniamo, dunque. Ma sogniamo bene. Sogniamo con Iain M. Banks. Sogniamo con la Flotta Stellare. Sogniamo con la ribellione. Ma mai con l’Impero.
L’idrogeno è una promessa mancata, non una rivoluzione
L’idrogeno — affascinante, leggero, evocativo — non è la risposta definitiva che ci è stata promessa.
Non lo è per l’efficienza, che si dissolve nel ciclo energetico. Non lo è per i costi, che crescono senza controllo. Non lo è per l’infrastruttura, che richiede sforzi ciclopici. E non lo è, soprattutto, per la società, che merita soluzioni semplici, eque, partecipate.
Mentre inseguiamo il sogno idrogenato, la realtà bussa con urgenza. E ci chiede altro. Ci chiede elettricità pulita, reti intelligenti, accumuli efficienti, comunità energetiche. Ci chiede verità.
E forse, solo forse, ci chiede di crescere.