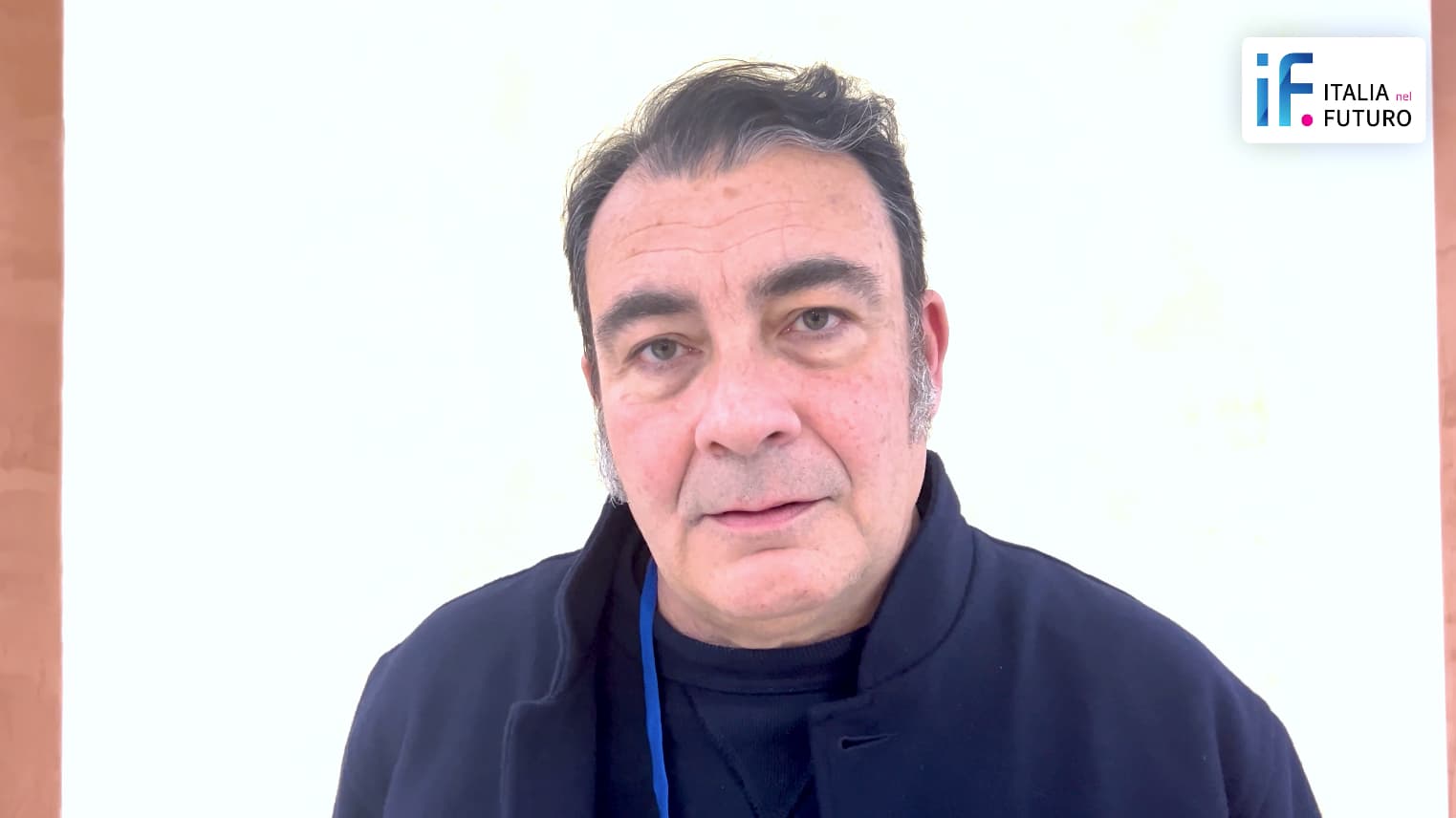Con Starlink sempre più incerto in Ucraina, l’Europa guarda a Eutelsat per garantire connettività sicura. Il gruppo franco-britannico rilancia la sua missione: uno spazio europeo, libero da dipendenze esterne e tecnologicamente sovrano.
Un progetto europeo nato per essere libero
C’era una volta – e non poi così tanto tempo fa – un’Europa che guardava al cielo non per desiderio di conquista, ma per la necessità, pressante e strategica, di rendersi indipendente. Così, nel 1977, nacque Eutelsat: frutto dell’intesa fra diciassette Stati, fu concepita con l’intento di spezzare le catene tecnologiche che legavano il continente a Washington e Mosca. Da allora, molta strada è stata fatta. Divenuta nel 1983 la prima emittente satellitare europea, la società ha ampliato i propri orizzonti, consolidando anno dopo anno la sua presenza tra le stelle – prima con la televisione, poi con la rivoluzione digitale.
Ma è il 2023 a segnare un punto di svolta – un punto che, per certi versi, pare segnato da un destino scritto nelle orbite. La fusione con la britannica OneWeb ha generato il primo operatore GEO-LEO al mondo: una costellazione ibrida, resiliente, pronta a garantire copertura e continuità là dove le connessioni terrestri si fermano. Non si tratta solo di efficienza – no – ma di identità: Eutelsat non è più semplicemente un’azienda, è la voce di un’Europa che vuole restare padrona del proprio cielo (Eutelsat, 2024).
Questa trasformazione, tuttavia, non si è compiuta in silenzio. È stata accompagnata da un fermento di discussioni politiche, di strategie condivise e di visioni di lungo respiro – visioni che puntano non solo a un rafforzamento economico, ma a una rinascita tecnologica, quasi morale, del progetto europeo. Cosa significa davvero autonomia, oggi, se non poter contare su una rete che, dallo spazio, protegga le libertà digitali dei cittadini europei? Ed è proprio in questa luce che Eutelsat assume un ruolo non solo industriale, ma quasi simbolico – come se ogni satellite lanciato fosse anche una dichiarazione d’intenti, un pezzo di sovranità che torna a casa.
Il presente si chiama Eutelsat
Ma cosa accade quando una nazione – o un intero continente – affida le proprie comunicazioni vitali, critiche, essenziali, a un fornitore privato, per giunta straniero? La guerra in Ucraina ha dato una risposta – non teorica, bensì tangibile, concreta, drammatica. Starlink ha rappresentato una salvezza, ma anche una fragilità. Perché, se un uomo – Elon Musk – può spegnere un’intera rete con una decisione, allora è evidente che c’è bisogno di un’alternativa. Una vera alternativa.
Eutelsat, già attiva in Ucraina con circa 2.000 terminali – un numero modesto, sì, ma promettente – punta a colmare il divario con Starlink, che ne conta circa venti volte tanti. La CEO Eva Berneke, con tono misurato, ma deciso, ha affermato che, con il giusto supporto – logistico, istituzionale, finanziario – Eutelsat può raggiungere quell’obiettivo. La rete terrestre è in fase avanzata, le infrastrutture si preparano, l’Europa ascolta. Intanto, la Polonia – pragmatica e preoccupata – dichiara pubblicamente che, se SpaceX dovesse mostrare segni d’inaffidabilità, si guarderà altrove (TNW, 2024). È un segnale chiaro – uno fra tanti.
Chi scruta il cielo, oggi, non lo fa solo per desiderio di scoperta – lo fa per necessità, per difesa, per sopravvivenza digitale. E in questo contesto, Eutelsat non si presenta come una seconda scelta, ma come una risposta matura, europea, consapevole. Una risposta che – se sostenuta da fondi, volontà politica, cooperazione transnazionale – può diventare la colonna portante di un ecosistema spaziale tutto nostro. E allora non stupisce che, da Bruxelles a Varsavia, da Roma a Parigi, si moltiplichino le voci che chiedono più Eutelsat, più Europa, più indipendenza.
Tecnologia orbitale e ambizioni geopolitiche
Chi governa le orbite, governa il mondo – non è forse così? I satelliti OneWeb, 634 occhi vigili sospesi a 1.200 chilometri sopra le nostre teste, portano connessioni là dove nulla, o quasi, arriva: deserti, montagne, navi, aerei, campi profughi. Non è solo tecnologia, è servizio. È presenza. È strategia. Certo, non sono perfetti – mancano ancora i collegamenti laser tra i satelliti, e i terminali sono costruiti da terzi – ma la direzione è tracciata, e il passo, ormai, è sicuro.
Che significato ha, oggi, possedere una costellazione? È solo infrastruttura? O è qualcosa di più profondo – un segno di forza geopolitica, un messaggio, un gesto di orgoglio continentale? In questo quadro – dinamico, competitivo, per certi versi affollato – l’Unione Europea rilancia. Il progetto IRIS², previsto per il 2030, sarà una costellazione multi-orbita made in Europe, con Eutelsat al centro della scena. E come se non bastasse, a fianco prende forma anche “Project Bromo” – un’alleanza industriale che suona come un giuramento: Airbus, Leonardo, Thales Alenia Space – nomi, sì, ma anche garanzie. L’Europa, insomma, non vuole più restare ai margini dello spazio. Vuole tornarvi. E restarci. Da protagonista (Eutelsat, 2024).
E allora ci si chiede: riuscirà davvero Eutelsat, con i suoi mezzi e i suoi uomini, a costruire non solo reti ma alleanze, non solo connettività ma influenza? E se la risposta fosse sì – allora avremmo di fronte non un semplice operatore, ma un attore geopolitico di prima grandezza.
Strategia industriale, investimenti e performance
Nel silenzioso fruscio dei dati finanziari si celano storie di trasformazione, strategie, visioni. Dietro ai numeri – freddi in apparenza, ma incandescenti di conseguenze – si cela il cuore pulsante di Eutelsat. Con ricavi 2023–24 pari a 1.213 milioni di euro e un portafoglio ordini da 3,9 miliardi – sì, miliardi – l’azienda si afferma non solo come operatore, ma come garante di stabilità a lungo termine (Eutelsat, 2024).
Eutelsat oggi governa una flotta formidabile: 35 satelliti geostazionari (GEO), sentinelle silenziose a 36.000 km dalla Terra, e oltre 600 satelliti LEO, instancabili messaggeri che sfrecciano più vicini, più veloci, più agili. Un esercito spaziale, potremmo dire – ma al servizio della comunicazione, della connessione, del dialogo. È l’integrazione di queste due anime – GEO e LEO – che fa di Eutelsat qualcosa di unico nel panorama globale.
La traiettoria industriale è chiara: espandere la capacità, migliorare la latenza, aumentare l’efficienza. Per farlo, l’azienda ha varato un piano di investimenti da 700–800 milioni di euro, destinato a finanziare la nuova generazione OneWeb – più capace, più sostenibile, più europea. Nel frattempo, si consolidano alleanze: con EQT Infrastructure VI, Eutelsat ha ceduto parte delle sue infrastrutture terrestri, mantenendo però il timone come “anchor tenant” – una mossa audace, strategica, calibrata.
E che dire dei mercati? Gli investitori, affascinati da questa metamorfosi, hanno mostrato fiducia. Le azioni hanno reagito, le analisi si sono moltiplicate, gli osservatori parlano di “modello Eutelsat” come esempio di trasformazione industriale europea. Forse non sarà tutto oro – ma la direzione è, senza dubbio, quella giusta.
Sostenibilità, impatto sociale e futuro europeo
E infine, giungiamo al cuore – al battito più profondo di Eutelsat: la sostenibilità. Perché, se è vero che lo spazio è silenzioso, è altrettanto vero che la sua gestione parla forte – parla di responsabilità, di futuro, di rispetto. Eutelsat ha ridotto del 3,2% le sue emissioni dirette (Scope 1 e 2) rispetto al 2021; ma non si ferma qui. L’obiettivo per il 2030 è ambizioso, ma dichiarato con chiarezza: -50% (Eutelsat, 2024).
A certificare questo impegno, il massimo rating platinum da parte della Space Sustainability Rating per la costellazione OneWeb. Un riconoscimento? Certamente. Ma anche un vincolo morale – quello di mantenere, e superare, uno standard che non riguarda solo i satelliti, ma l’intero pianeta.
E poi c’è l’aspetto umano – troppo spesso trascurato, ma centrale. Portare internet in un villaggio sperduto, collegare un ospedale in mezzo al deserto, consentire a una scuola rurale di accedere al mondo: questi non sono miracoli, ma risultati. E sono, nel loro piccolo, rivoluzioni. Eutelsat serve oltre un miliardo di persone – non come numero, ma come promessa mantenuta. Con 1.500 dipendenti, 76 nazionalità, uffici in 28 Paesi, rappresenta un microcosmo di quell’Europa che vorremmo: inclusiva, innovativa, ispirata.
Non solo ESG, dunque. Ma una visione. Una visione che unisce tecnologia e solidarietà, profitto e impatto, orbite e umanità. Perché, in fin dei conti, lo spazio non è solo lassù – è anche qui. Ed è da qui, da questa Terra così fragile, che l’Europa ha deciso di guardare in alto. Con occhi propri.