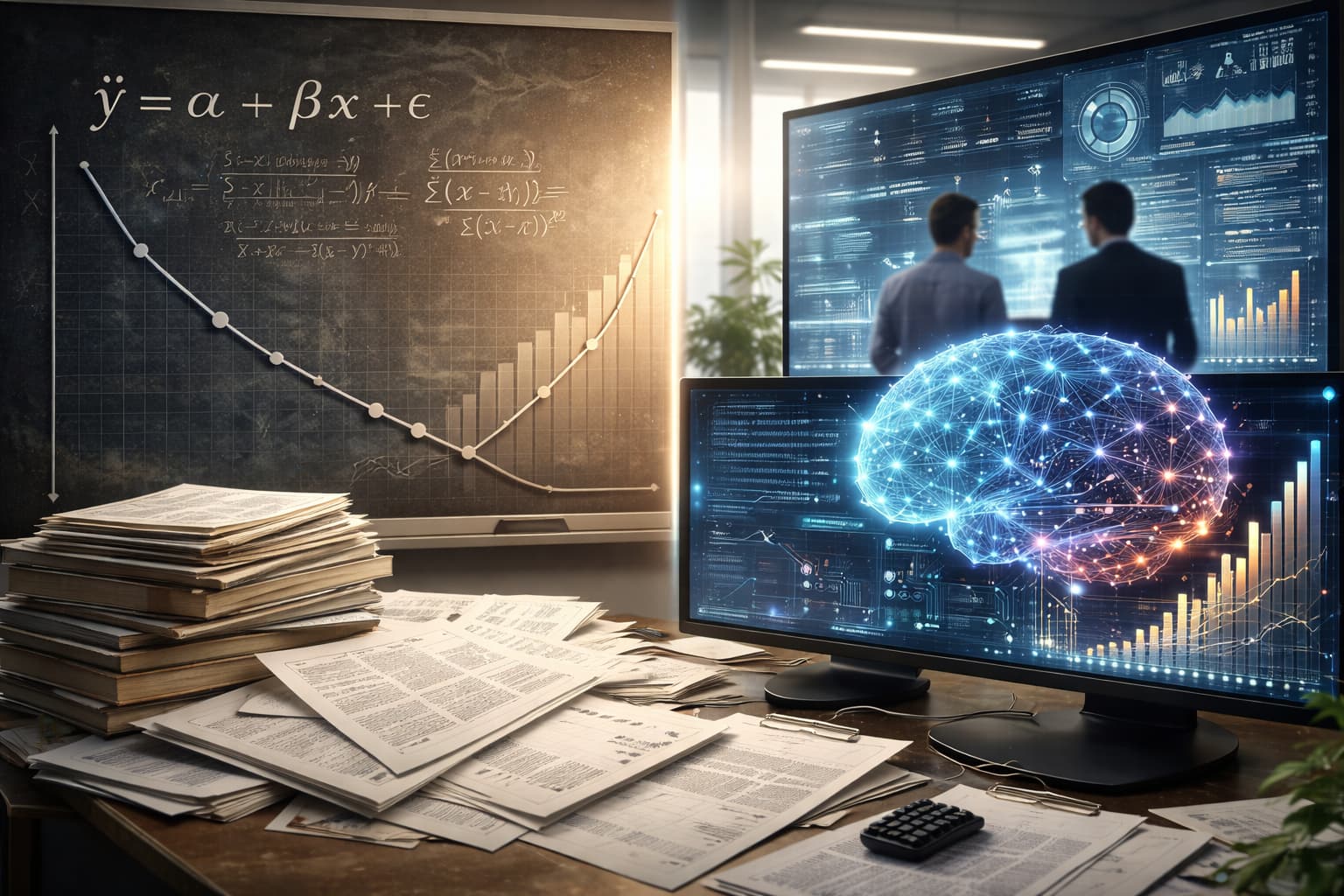La manifattura europea cresce per l’ottavo mese consecutivo, ma resta intrappolata tra stagnazione e incertezza. Produzione stabile, ordini deboli e occupazione in calo delineano una ripresa fragile e disomogenea. L’industria del Sud Europa resiste, mentre Germania e Francia rallentano, segnalando un’Europa manifatturiera divisa e vulnerabile.
La manifattura europea cresce per l’ottavo mese consecutivo, ma resta sospesa tra stagnazione e incertezza. Ordini fermi, occupazione in calo e fiducia debole disegnano il volto di una ripresa senza slancio, dove la produzione tiene, ma il motore della domanda resta spento.
Otto mesi di crescita non bastano a parlare di ripresa.
Il PMI manifatturiero HCOB Eurozone, diffuso da S&P Global, si è attestato a 50,0 punti in ottobre: una cifra simbolica, perché segna stagnazione pura, nessun miglioramento rispetto a settembre (49,8).
Dopo un anno e mezzo di contrazione, la produzione europea sta lentamente risalendo, ma senza forza propulsiva.
È un’espansione in apnea: le fabbriche lavorano, i macchinari girano, ma gli ordini restano fermi e l’occupazione continua a calare.
A prima vista, il dato sembra rassicurante: otto mesi di espansione consecutiva non si vedevano dal 2021. Ma guardando sotto la superficie, emergono tensioni profonde: una ripresa senza domanda, sostenuta più da riduzione di scorte e micro-efficienze produttive che da nuovi ordini.
Il Sud Europa guida, ma il Nord resta la zavorra
Il quadro geografico dell’industria europea racconta due realtà parallele.
Nel Sud Europa, la manifattura tiene viva la fiammella della crescita: Grecia (53,5) e Spagna (52,1) registrano i risultati migliori, seguite dai Paesi Bassi (51,8) e dall’Irlanda (50,9), seppur in rallentamento.
Al contrario, il cuore storico dell’industria continentale — Germania, Francia, Austria — resta sotto quota 50, segno di contrazione.
L’Italia (49,9) sfiora la soglia neutra, sospesa tra stagnazione e ripartenza.
La divergenza è significativa: il Sud cresce per effetto di un’industria più snella, agile e meno dipendente dall’export intraeuropeo. Il Nord, invece, soffre di una domanda interna debole, di un’industria automobilistica in difficoltà e di un rallentamento globale che pesa sulle esportazioni.
È la fotografia di un continente industrialmente diviso: da un lato chi resiste per inerzia, dall’altro chi si reinventa per necessità.
Produzione in lieve aumento, ma senza nuovi ordini
Il dato più inquietante è il disallineamento tra output e domanda.
La produzione cresce, seppure lentamente, da otto mesi consecutivi, ma gli ordini restano stagnanti.
In tre anni e mezzo, la domanda di beni europei è aumentata una sola volta, ad agosto 2024.
Da allora, anche le nuove commesse estere, incluse quelle intra-eurozona, si sono ridotte per il quarto mese consecutivo.
Il messaggio è chiaro: si produce di più, ma non si vende di più.
Le imprese stanno lavorando per svuotare magazzini, ridurre inventari e mantenere operativa la filiera, non per rispondere a una domanda crescente.
Questo tipo di crescita “a vuoto”, sostenuta più dall’offerta che dal mercato, non è sostenibile nel medio periodo: genera fatturato nel breve, ma non margini né occupazione stabile.
Occupazione in calo: la ripresa che non crea lavoro
Sul fronte dell’occupazione, ottobre ha segnato un altro mese di tagli netti.
È quasi due anni e mezzo che l’industria europea riduce personale, mese dopo mese.
A ottobre, la contrazione si è accentuata leggermente, toccando il ritmo più rapido da giugno.
Le imprese tagliano perché la domanda è debole e l’incertezza alta.
Molte scelgono di difendere la produttività riducendo la forza lavoro piuttosto che accumulare costi fissi in eccesso.
Un segnale di prudenza, ma anche un freno per la domanda interna: meno occupazione significa meno reddito disponibile, e meno reddito significa meno consumi.
Il rischio è un circolo vizioso: produzione senza occupazione, occupazione senza consumo, consumo senza crescita.
Scorte in caduta e forniture più lente
L’intera catena industriale continua a smaltire scorte.
Le aziende riducono magazzini di materie prime e prodotti finiti a ritmi superiori alla media, mentre gli acquisti di input, dai metalli ai componenti elettronici, scendono per il 40° mese consecutivo.
Un dato storico: mai un ciclo di contrazione così lungo.
Paradossalmente, però, i tempi di consegna dei fornitori si allungano.
È l’effetto combinato di tensioni logistiche, scarsità di semiconduttori e incertezza geopolitica (dal Mar Rosso all’Est Europa), che continuano a disturbare la catena di approvvigionamento.
Il risultato è un mercato che lavora su scorte minime, con costi più alti e margini più stretti.
Nel breve periodo, il “destocking” sostiene la produttività. Ma se la domanda non riparte, rischia di trasformarsi in un boomerang: magazzini vuoti e ordini futuri in ritardo.
Prezzi fermi, ma margini sotto pressione
Sul fronte dei prezzi, ottobre ha mostrato stabilità dei costi di acquisto dopo un lieve calo a settembre.
Tuttavia, per la prima volta da aprile, le imprese hanno aumentato i prezzi di vendita: un rialzo marginale, più simbolico che sostanziale.
La maggior parte dei produttori europei non ha spazio per aumenti significativi, il mercato non li assorbirebbe.
La conseguenza è un’erosione dei margini e un incentivo a ridurre ulteriormente i costi, anche tagliando occupazione o investimenti.
Questo equilibrio precario tra stabilità dei costi e debolezza della domanda tiene per ora l’inflazione sotto controllo, ma rischia di comprimere la capacità d’investimento dell’industria proprio quando servirebbero innovazione e riconversione green.
Fiducia industriale: ottimismo in frenata
Nonostante tutto, i produttori europei restano moderatamente ottimisti: la maggioranza prevede un aumento dell’output entro i prossimi dodici mesi.
Ma il livello di fiducia si è ridotto per il secondo mese consecutivo e rimane inferiore alla media storica.
La prudenza è evidente: l’incertezza geopolitica, i tassi d’interesse ancora elevati e la debolezza della domanda cinese pesano sulle aspettative.
Le imprese europee, oggi, non pianificano una ripresa: la attendono.
È una fiducia passiva, non proattiva. Più speranza che visione.
De la Rubia: “Una ripresa fragile e disomogenea”
Secondo Cyrus de la Rubia, capo economista di Hamburg Commercial Bank, “possiamo parlare al massimo di un germoglio di ripresa”.
“La produzione cresce, ma non accelera. La domanda resta piatta. Le aziende tagliano personale per difendere i margini. I colli di bottiglia nelle forniture, specialmente di semiconduttori, prolungano i tempi di consegna e pesano su settori chiave come automotive e meccanica”.
De la Rubia individua un’Europa manifatturiera a geometria variabile: “Fragile in Germania, recessiva in Francia, debole in Italia, solo moderatamente positiva in Spagna. La tensione politica in Francia — aggiunge — sta incidendo sulla fiducia e riducendo la domanda per beni industriali anche nei Paesi partner”.
Sullo sfondo, il ciclo delle scorte continua a contrarsi “senza segnali di inversione. Le aziende non accumulano perché non si fidano del mercato”.
Oltre il dato: la nuova vulnerabilità industriale europea
La fotografia che emerge è quella di un’Europa industriale che tiene, ma non avanza.
Il continente resta un colosso manifatturiero, ma il modello su cui si è retto per decenni — export, energia a basso costo, supply chain globali affidabili — sta scricchiolando.
L’aumento dei costi logistici, la digitalizzazione a metà, la concorrenza asiatica e le transizioni green non ancora assorbite stanno ridisegnando la mappa industriale europea.
La ripresa del 2025 somiglia a un equilibrio precario: si produce, ma non si investe. Si esporta, ma con margini sempre più sottili. Si assume, ma con contratti brevi e incerti.
È una ripresa senza trazione, più simile a un rimbalzo tecnico che a un ciclo economico vero e proprio.
Una ripresa da reinventare
L’industria europea si trova in un punto di flesso storico.
Non basta più “tenere”, serve reinventarsi.
Una manifattura basata su costi bassi e domanda esterna non è più sostenibile in un mondo di transizioni verdi, reshoring e tensioni geopolitiche.
Occorre un nuovo modello fondato su innovazione, resilienza e domanda interna di qualità.
La sfida è duplice: non solo uscire dalla stagnazione, ma costruire un’economia industriale capace di crescere in modo organico, stabile e sostenibile.
L’Europa non può più contare solo sui dati trimestrali per misurare la propria forza.
Deve tornare a chiedersi che tipo di crescita vuole e per chi.
Perché crescere a ritmo zero non è stabilità. È un modo elegante di chiamare la fragilità.