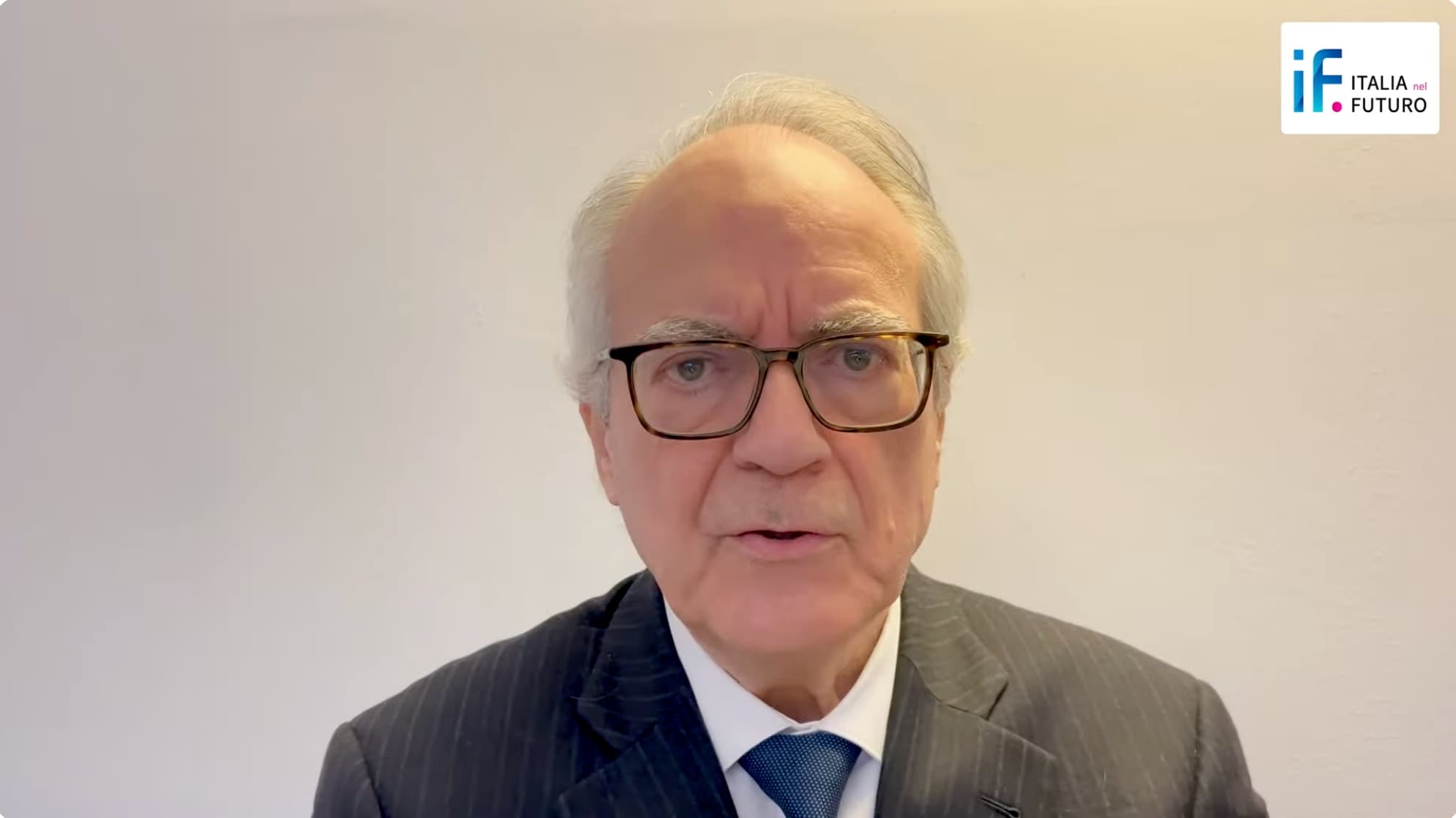Bruxelles fissa al 2028 la data di addio a petrolio e gas russi, trasformando una scelta politica in legge vincolante. Una decisione che rafforza l’autonomia strategica dell’Unione, ma apre nuove tensioni con i partner industriali e mette in luce la crescente influenza energetica degli Stati Uniti.
L’annuncio del Commissario all’Energia Dan Jorgensen ha un significato che va oltre la politica energetica: sancisce l’inizio di una fase storica in cui l’Unione Europea punta a emanciparsi definitivamente dal gas e dal petrolio russi. Entro il 2028, Mosca sarà fuori dai mercati comunitari, ma la strada è irta di sfide: dal rischio di nuove dipendenze all’impatto sui prezzi, fino alla pressione crescente di Washington per accelerare i tempi. Sullo sfondo, la guerra in Ucraina e la geopolitica dell’energia trasformano una scadenza tecnica in un banco di prova cruciale per il futuro dell’Europa.
Una scadenza scolpita nella legge europea
La novità del piano annunciato a Bruxelles sta nella sua natura giuridica: il phase-out dal petrolio e gas russi sarà fissato in un atto legislativo vincolante. Non più sanzioni temporanee da rinnovare ogni sei mesi, ma un impegno strutturale, blindato nel diritto comunitario. Questo passaggio riduce l’incertezza politica e garantisce continuità strategica anche in caso di cambi di governo o di divergenze interne tra gli Stati membri. In un contesto in cui la sicurezza energetica è diventata questione di sicurezza nazionale, la scelta di trasformare una misura contingente in norma di lungo periodo segna una cesura storica.
I progressi compiuti e i nodi irrisolti
Dal 2022, anno dell’invasione russa in Ucraina, l’Europa ha dimezzato la propria dipendenza energetica da Mosca: le importazioni di gas sono passate dal 40% a meno del 15% del fabbisogno complessivo. Tuttavia, il definitivo azzeramento resta una sfida imponente. Paesi come Ungheria e Slovacchia dipendono ancora fortemente dalle forniture russe e rischiano di trovarsi in difficoltà senza soluzioni di transizione. A ciò si aggiungono i vincoli infrastrutturali: non tutte le reti europee sono in grado di assorbire nuovi flussi di GNL o di elettricità da fonti rinnovabili. La sfida non è più solo politica, ma profondamente tecnica e industriale.
Washington e la diplomazia dell’energia
Gli Stati Uniti hanno accolto la decisione europea con favore, ma anche con una chiara aspettativa: accelerare i tempi. Il Segretario all’Energia Chris Wright ha ribadito che gli USA sono pronti a colmare il vuoto lasciato da Mosca con le proprie esportazioni di gas naturale liquefatto. Per Washington, ridurre a zero i flussi russi verso l’Europa non è solo un modo per indebolire il Cremlino, ma anche un’opportunità industriale colossale per rafforzare il ruolo del GNL americano nei mercati globali. La guerra in Ucraina, dunque, ha trasformato il settore energetico in un terreno di diplomazia economica transatlantica, dove sicurezza e commercio si intrecciano indissolubilmente.
Sanzioni e diritto dell’energia: il doppio binario
Mentre si definisce il percorso legislativo, Bruxelles lavora al 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia. L’idea è creare un doppio binario: una scadenza legale fissata al 2028 e, parallelamente, sanzioni che possano imporre restrizioni più rapide. Questo approccio bilancia fermezza politica e flessibilità diplomatica. Dal punto di vista giuridico, rappresenta una nuova frontiera: usare il diritto europeo come leva di politica industriale e geopolitica. Non è più soltanto una questione di regolamentazione dei mercati interni, ma di costruzione di un quadro normativo capace di incidere sugli equilibri globali.
Il prezzo della transizione
L’ambizione politica deve fare i conti con la realtà economica. Azzerare le importazioni da Mosca significa ricorrere sempre più al GNL, che resta più costoso del gas via pipeline. Per l’industria europea, già penalizzata da bollette più alte rispetto ai competitor americani e asiatici, il rischio è una perdita di competitività strutturale. L’acciaio, la chimica e la manifattura pesante sono i settori più esposti. Senza un piano comune di sostegno, il phase-out potrebbe trasformarsi in un fattore di deindustrializzazione. La Commissione dovrà conciliare tre variabili in tensione: autonomia energetica, stabilità dei prezzi e competitività industriale.
La geopolitica delle dipendenze
Ridurre a zero le importazioni dalla Russia ha un impatto immediato: il Cremlino perde la leva energetica che per decenni ha esercitato sull’Europa. Ma il rischio è che la dipendenza venga semplicemente trasferita da est a ovest, con gli Stati Uniti pronti a diventare il principale fornitore. Mosca, intanto, ha già riorientato gran parte delle sue esportazioni verso Cina e India, consolidando nuove alleanze energetiche. Per l’UE, il phase-out è, quindi, un’operazione di geopolitica delle dipendenze: emanciparsi da una vulnerabilità senza crearne un’altra. La vera sfida è costruire una sovranità energetica che non sia ostaggio di fornitori esterni.
Un equilibrio tra ambizione e realismo
Il 2028 non è solo una data: è la sintesi delle contraddizioni europee. Da un lato l’urgenza di emanciparsi da Mosca e di rafforzare la propria autonomia strategica; dall’altro il rischio di squilibri economici, nuove dipendenze e tensioni sociali legate ai costi dell’energia. La decisione di trasformare il phase-out in legge rappresenta un passo storico, ma non elimina gli ostacoli. L’Europa sarà giudicata non dalla fermezza dell’annuncio, ma dalla capacità di tradurlo in innovazione, resilienza e competitività. Solo così la promessa di indipendenza energetica potrà diventare realtà, senza sacrificare il futuro industriale del continente.