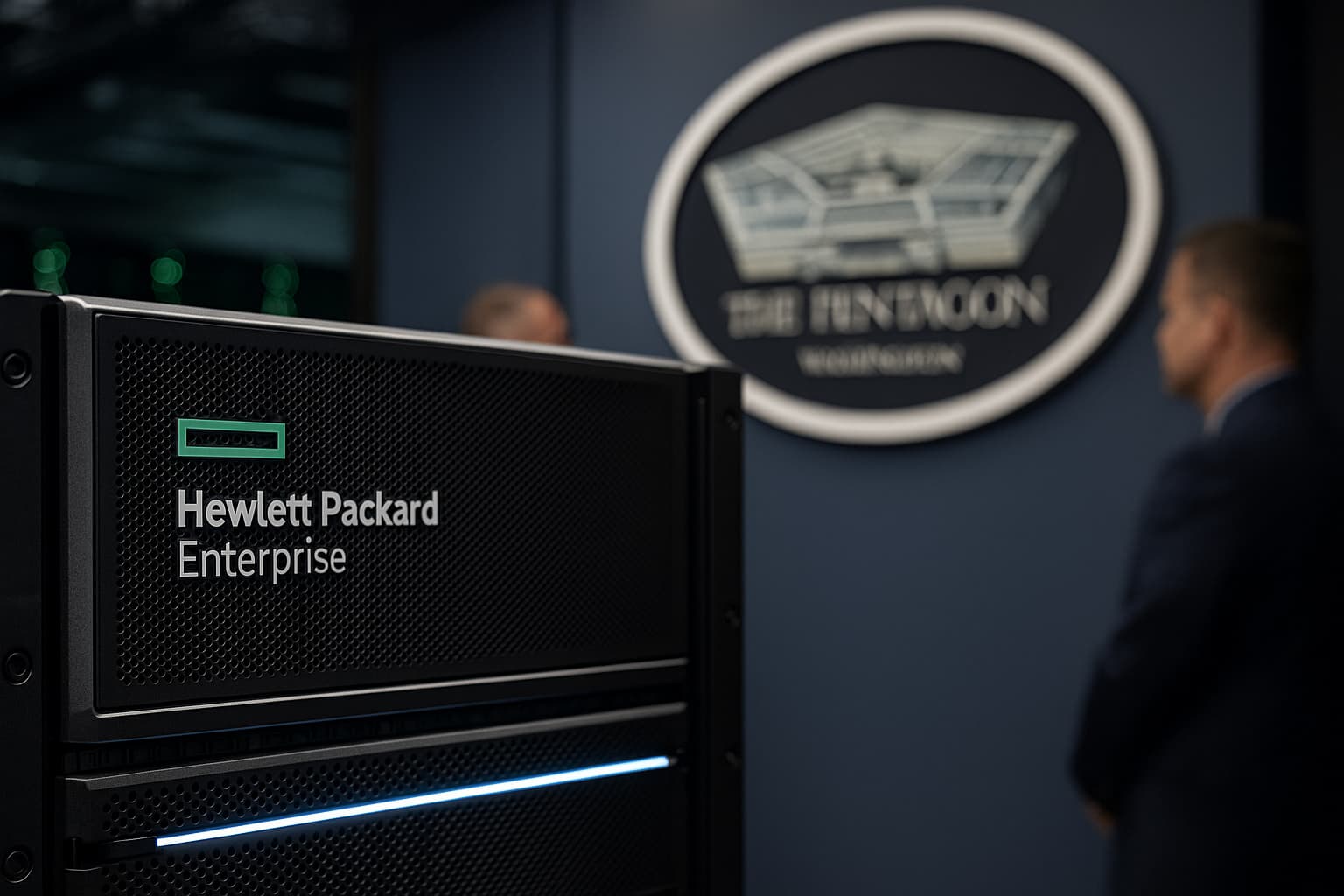Con un progetto infrastrutturale che si è sviluppato per 15 anni e si estende per oltre 4.000 km, Pechino sta trasformando il “mare della morte” in un hub strategico per le energie rinnovabili.
Nel cuore arido della Cina occidentale, dove il deserto del Taklamakan ha a lungo rappresentato una barriera naturale, sta prendendo forma uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi degli ultimi decenni. Le autorità cinesi hanno appena annunciato il completamento di un anello ad altissima tensione da 750kV che circonda l’intero Bacino del Tarim, nella regione autonoma dello Xinjiang. Con i suoi 4.197 chilometri di estensione, questo progetto, descritto come un “energy ring”, si prepara a diventare un pilastro fondamentale della rete elettrica della Cina occidentale. Si tratta di una trasformazione che ha un impatto non solo infrastrutturale, ma anche economico e geopolitico, rispondendo alla crescente domanda di connettività energetica tra le province interne e i centri industriali della costa.
Dalla periferia al centro: la nuova centralità strategica dello Xinjiang
Il Bacino del Tarim è un’area tanto vasta quanto remota, dominata dal deserto del Taklamakan e caratterizzata da condizioni ambientali estreme. Tradizionalmente definita “mare della morte” per l’ostilità del territorio, la regione è oggi al centro di una strategia energetica che mira a trasformare il deserto in fonte di energia pulita.
Lo Xinjiang è, infatti, uno dei territori più promettenti in Cina per l’espansione delle energie rinnovabili – in particolare solare ed eolico – grazie all’ampia disponibilità di superfici libere e all’intensità dell’irraggiamento solare. Tuttavia, l’assenza di infrastrutture di trasporto ha rappresentato storicamente un ostacolo alla valorizzazione di questo potenziale.
Con il completamento dell’“energy loop” ad altissima tensione, Pechino intende integrare la produzione decentrata di energia rinnovabile all’interno della rete elettrica nazionale, favorendo la trasmissione di elettricità verso i centri industriali orientali e contribuendo a riequilibrare lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
Implicazioni tecnologiche, giuridiche e ambientali del progetto
Dal punto di vista tecnologico, l’anello del Tarim rappresenta un caso di studio avanzato sull’applicazione di infrastrutture UHV (Ultra High Voltage) in contesti ambientali estremi. Le linee a 750kV devono resistere a escursioni termiche, sabbia, vento e isolamento prolungato. Il progetto evidenzia l’evoluzione dell’ingegneria elettrica cinese, oggi esportata anche nell’ambito della Belt and Road Initiative.
Sul piano giuridico, la governance di un’infrastruttura di tale portata implica un articolato regime normativo multilivello, che include autorizzazioni ambientali, regolazione tariffaria e norme sulla sicurezza delle infrastrutture critiche. L’approccio cinese evidenzia una tendenza alla centralizzazione decisionale e all’accelerazione procedurale nel settore energetico strategico.
Ambientalmente, la scommessa è significativa: un impianto infrastrutturale di queste dimensioni, sebbene destinato a favorire l’energia verde, ha un impatto sul territorio e sulla biodiversità desertica, generando interrogativi sulla compatibilità con le strategie di tutela ecologica.
Rilevanza geopolitica e implicazioni internazionali
Il completamento dell’“energy loop” nel Bacino del Tarim avviene in una fase storica particolarmente sensibile per gli equilibri globali. Da un lato, l’Asia centrale è tornata al centro dell’interesse economico e geopolitico, sospinta dalla necessità di diversificare le catene di approvvigionamento energetico, dal progressivo disimpegno occidentale da alcune aree produttive tradizionali e dal consolidamento della Belt and Road Initiative (BRI) cinese. In questo scenario, il Xinjiang – pur essendo una regione periferica – si trasforma in un ponte energetico e infrastrutturale verso l’Asia centrale, il Caucaso e, indirettamente, l’Europa.
Il progetto consente a Pechino di rafforzare la propria posizione in almeno tre dimensioni chiave:
- Sovranità energetica, riducendo la dipendenza da fonti fossili esterne e consolidando il controllo interno delle filiere elettriche.
- Capacità di influenza regionale, offrendo energia elettrica a basso costo come leva diplomatica e industriale nei confronti di Paesi vicini.
- Leadership tecnologica, promuovendo lo standard cinese sulle linee elettriche ad altissima tensione (UHV), che Pechino sta già esportando in Africa, Medio Oriente e America Latina.
Inoltre, l’anello del Tarim rappresenta un test geopolitico su scala locale: dimostrare che lo Stato può controllare e “civilizzare” territori considerati storicamente instabili o marginali. Questo ha implicazioni anche sul piano etnico e politico, trattandosi di una regione abitata da minoranze musulmane turcofone – in particolare la popolazione uigura – al centro di attenzione e critiche internazionali.
Sul piano globale, la Cina mira a porsi come fornitore di soluzioni sistemiche per la transizione energetica: non solo pannelli solari o batterie, ma anche infrastrutture di rete, digitalizzazione e capacità logistica. In un mondo in cerca di alternative sostenibili, l’ambizione è che il modello cinese di integrazione tra energia rinnovabile e ingegneria di sistema possa diventare uno standard replicabile su scala planetaria.
In questo senso, l’anello energetico del Tarim è molto più di un’infrastruttura: è una dichiarazione di visione, una piattaforma per esportare un modello tecnologico e politico, capace di unire interessi ambientali e logiche di potere.
L’elettrificazione del deserto come paradigma del XXI secolo
L’anello ad altissima tensione che cinge il Bacino del Tarim non è solo un’infrastruttura energetica: è l’emblema di una strategia trasformativa, capace di ridefinire il significato stesso di territorio, risorsa e margine. Nel cuore di uno dei deserti più ostili del pianeta, la Cina ha realizzato un’opera che sintetizza ambizione tecnologica, capacità logistica e visione geopolitica. Dove un tempo dominavano isolamento, inaccessibilità e inefficienza, oggi si affermano interconnessione, resilienza e autosufficienza energetica.
Questo progetto rappresenta una nuova grammatica infrastrutturale del XXI secolo, in cui l’elettrificazione non si limita più ai centri urbani o industriali, ma si estende alle aree estreme per abilitarne nuove funzioni produttive, ambientali e strategiche. Il deserto, da limite geografico, diventa piattaforma di innovazione e decarbonizzazione, offrendo un modello esportabile per altri contesti aridi, marginali o ad alto stress climatico.
In un’epoca segnata da transizioni complesse – energetiche, climatiche, geopolitiche – la Cina non propone semplicemente soluzioni, ma paradigmi di governance tecnologica. L’“anello elettrico del deserto” mostra che, con pianificazione a lungo termine e integrazione tra pubblico e privato, anche gli spazi più inospitali possono diventare nodi vitali della nuova geografia della sostenibilità. Non è solo un’opera ingegneristica, ma una dichiarazione politica e industriale, che invita il mondo a ripensare cosa significhi, oggi, generare sviluppo.