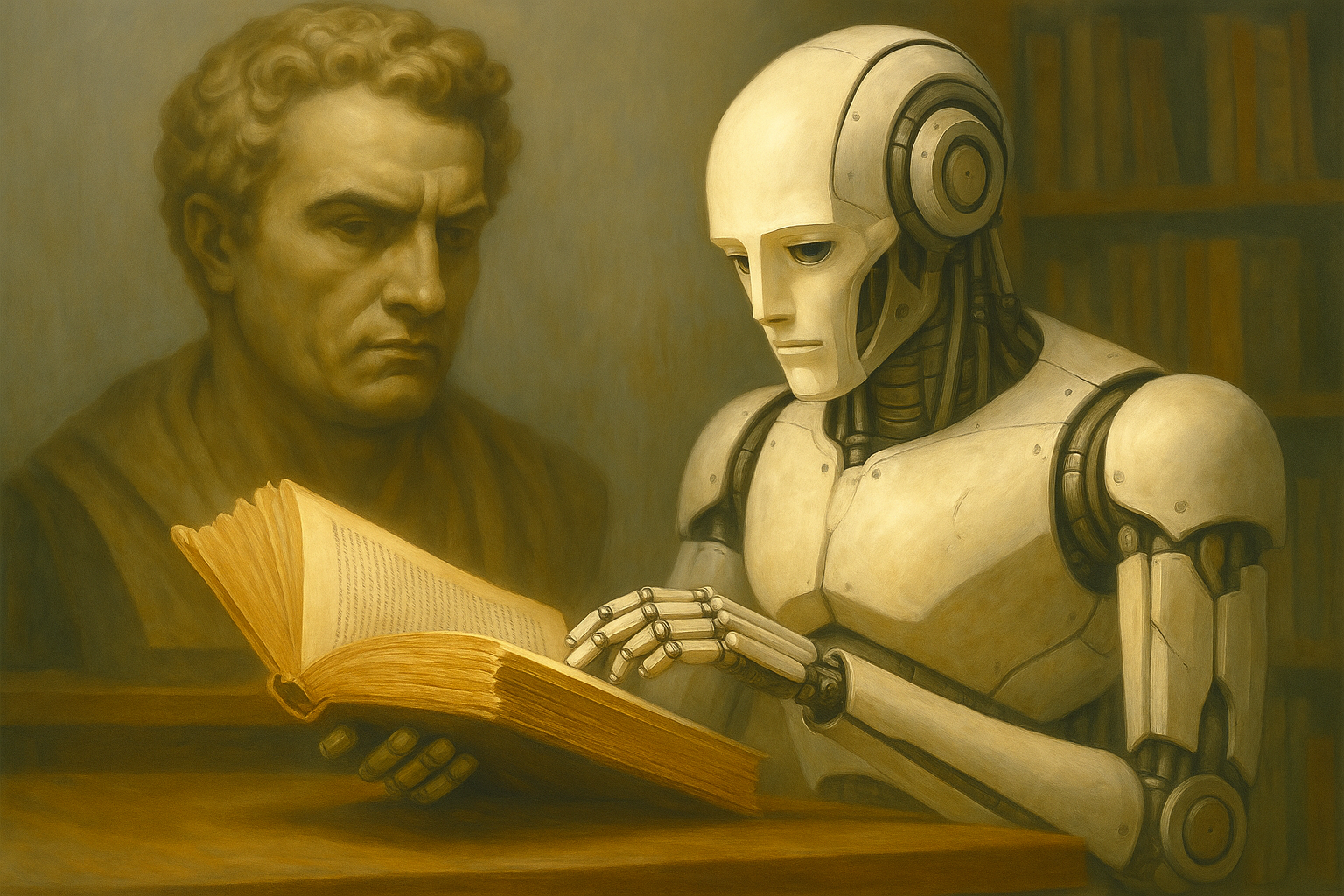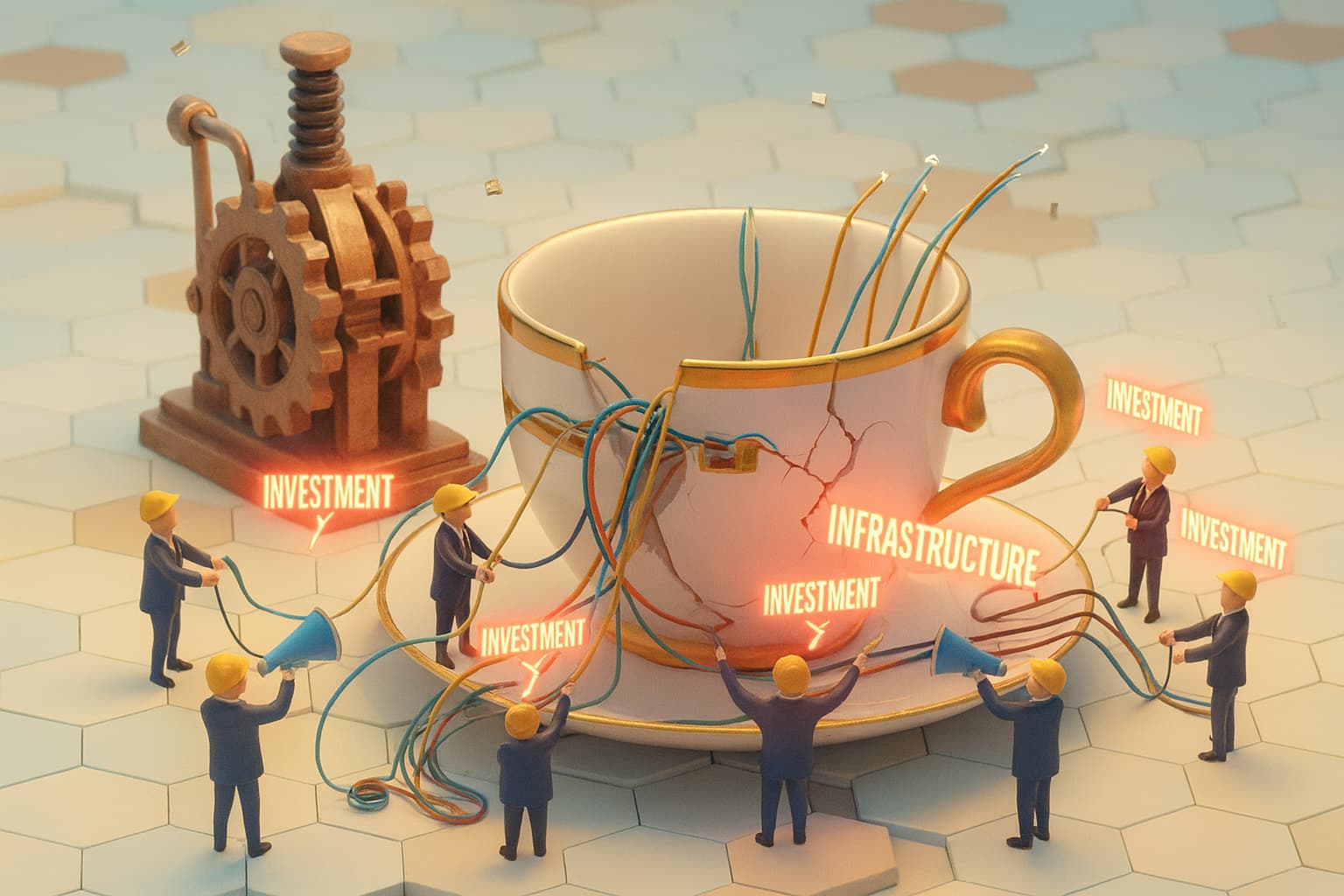Nell’era dell’intelligenza artificiale generativa, ci troviamo di fronte a un interrogativo tanto antico quanto rinnovato: quanto conta sapere chi ha scritto ciò che leggiamo? La “Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali” del gennaio 2023 parla di “garantire un livello adeguato di trasparenza” sull’uso dell’IA, come se identificare la mano (o il software) dietro un testo fosse improvvisamente diventato fondamentale per la sopravvivenza della civiltà.
Ma se ragioniamo con un po’ di buon senso abbiamo qualche difficoltà a capire quale è il problema e per quale motivo dovremmo ossessionarci dell’identità dell’autore, invece che concentrarci sulla qualità e veridicità dei contenuti.
La giustificazione più frequente, ma anche più ridicola di questa preoccupazione è che “Solo conoscendo l’autore possiamo attribuire responsabilità”. Come se i ghostwriter non esistessero da secoli! Politici, celebrità e persino autori di best-seller si avvalgono regolarmente di scrittori ombra, senza che nessuno gridi allo scandalo. L’IA sta semplicemente democratizzando questa pratica, trasformando chiunque in un potenziale committente di contenuti.
Siamo onesti: quando leggiamo un discorso presidenziale, davvero crediamo che sia stato scritto personalmente dal capo di Stato? Eppure nessuno chiede che ogni discorso riporti in calce “Scritto da Johnny, speechwriter dell’ufficio comunicazione”.
La paura della disinformazione attraverso testi generati artificialmente è comprensibile, ma decisamente tardiva. La possibilità di diffondere contenuti anonimi o sotto falsa identità è una caratteristica intrinseca di internet sin dai suoi albori, ben prima che ChatGPT imparasse a scrivere la sua prima poesia. Il problema non è l’IA, ma l’assenza di meccanismi efficaci per attribuire responsabilità a chi pubblica.
E poi cerchiamo di considerare la realtà, invece di attaccarci a elucubrazioni astratte di legulei: quanti testi generati dall’IA vengono pubblicati senza revisione umana? Praticamente nessuno. A che punto, dunque, il testo smette di essere “generato dall’IA” e diventa co-creato?
La scuola al bivio o forse al capolinea
Ecco dove il dibattito si fa davvero interessante, o tragicamente comico, a seconda dei punti di vista. Il sistema educativo, con la sua venerabile tradizione di temi in classe e tesi di laurea, si trova improvvisamente nudo come l’imperatore della fiaba. Se non possiamo più determinare con certezza chi ha scritto cosa, non c’è più nessuna logica nel valutare gli studenti sulla base di elaborate produzioni scritte.
La risposta più logica sarebbe spostare il focus dalla forma al contenuto, dalla vuota apparenza stilistica all’originalità del pensiero. E invece preferiamo creare improbabili guerre tecnologiche: studenti che affinano l’arte di mascherare l’uso dell’IA contro professori che brandiscono sempre più sofisticati software anti-plagio. Un gioco del gatto e del topo dove nessuno impara davvero qualcosa di utile.
Nel mondo reale, quello che attende gli studenti dopo la laurea, nessuno chiederà loro da dove provengono le idee, ma solo quanto sono valide ed innovative. E, ironia della sorte, chi saprà sfruttare al meglio questi strumenti AI avrà probabilmente un vantaggio competitivo.
I luddisti dell’era digitale
Tutto questo ci ricorda stranamente le resistenze che hanno accompagnato ogni innovazione tecnologica.
Molti anni fa un noto scrittore mi raccontò di essere ostracizzato dai colleghi per l’imperdonabile crimine di usare un personal computer invece della sacra macchina da scrivere: “Il PC blocca la creatività”, dicevano i puristi, gli stessi che oggi scrivono le loro filippiche contro l’IA su un PC. E anni dopo un noto filosofo francese si scandalizzò quando gli dissi che da tempo non compravo più libri perché il web è molto più interessante e tratta gli argomenti in modo più sintetico senza tante parole inutili.
La storia si ripete con monotona prevedibilità. Ieri era la calcolatrice che avrebbe atrofizzato il cervello degli studenti di matematica, oggi è l’IA che minaccia la sacralità dell’espressione umana. Domani sarà qualcos’altro a terrorizzare i custodi della tradizione.
Forse dovremmo semplicemente ammettere che l’unica nostra caratteristica veramente umana è la capacità di adattarsi e integrare nuovi strumenti nell’attività quotidiana, non di respingerli in nome di una purezza che non è mai esistita. In fondo, anche la scrittura stessa fu un’intelligenza “artificiale” che estese le capacità della nostra memoria biologica. E non sembra che ci abbia fatto poi così male.
Voi che state leggendo queste righe, vi chiedete se le ha scritte un essere umano o un’IA, oppure state valutando se hanno senso, indipendentemente dalla loro origine? La risposta a questa domanda dice molto più su di voi che su chi (o cosa) ha scritto il testo.