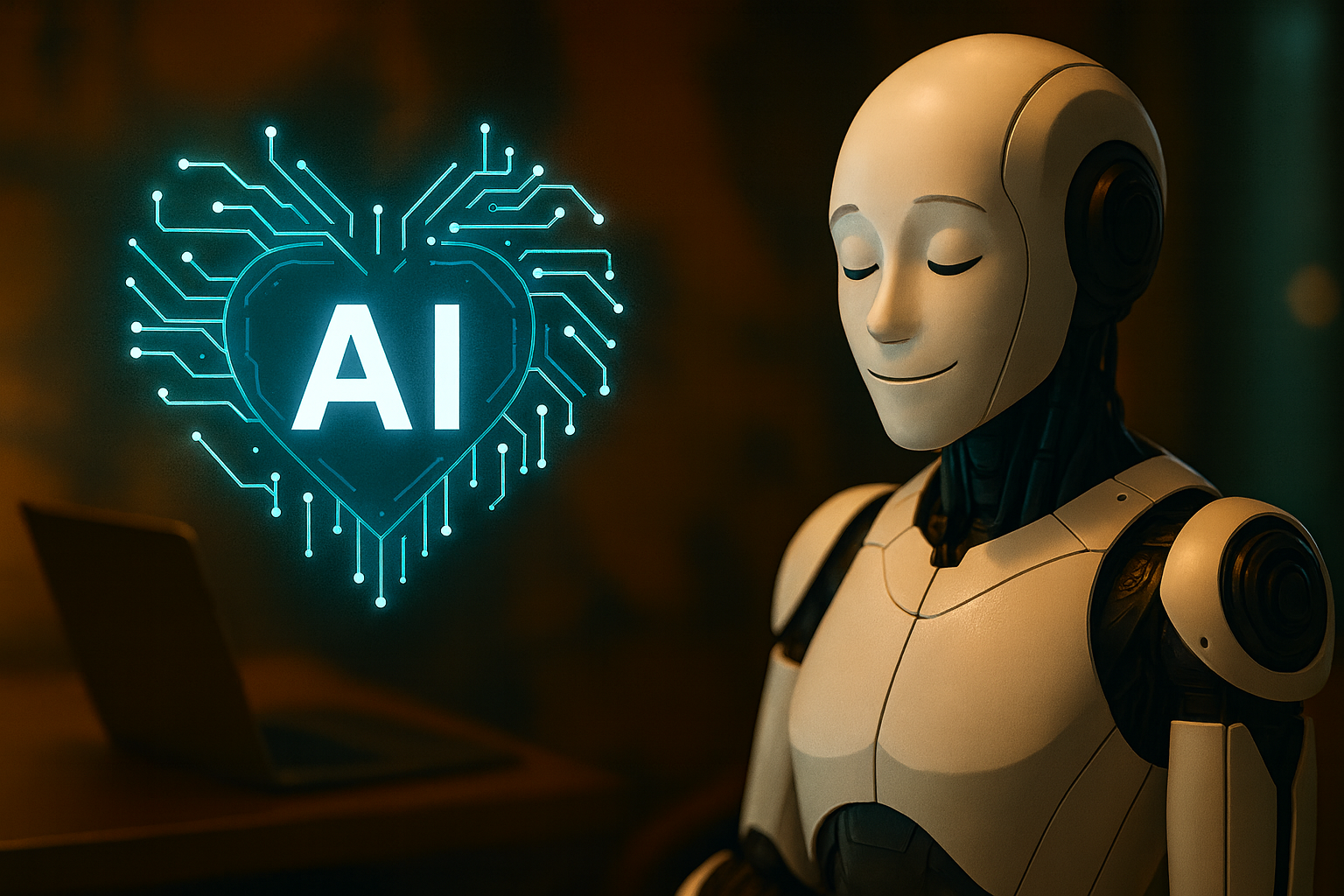L’evoluzione del rapporto tra umanità e tecnologie digitali ha attraversato una transizione tanto radicale quanto trascurata: dalla fatica al godimento. Se le prime generazioni di strumenti informatici erano pensati per potenziare le capacità operative dell’uomo in termini di calcolo, previsione e controllo, oggi assistiamo all’affermazione di un paradigma nuovo: l’edonismo computazionale.
L’intelligenza artificiale, in particolare nella sua declinazione generativa e conversazionale, non si limita più a risolvere problemi o ottimizzare processi, è progettata per piacere, sedurre, rassicurare, gratificare. Per costruire una relazione emotiva e affettiva con il fruitore. Di seguito proporremo una breve analisi sistemica di questa mutazione, restituendo al lettore le chiavi interpretative per comprendere come l’edonismo sia divenuto oggi una funzione integrata nei processi di progettazione algoritmica e un nodo critico per la governance delle tecnologie emergenti.
Il primo incontro tra uomo e macchina fu tutto fuorché edonico. I mainframe degli anni Cinquanta e Sessanta incarnavano l’ideale della macchina austera, destinata a pochi specialisti. L’interazione era mediata da linguaggi simbolici, comandi mnemonici, routine di input/output ad alta complessità. Fu con l’avvento dell’interfaccia grafica (GUI) – grazie a progetti pionieristici come lo Xerox Alto e, successivamente, i sistemi Apple Macintosh – che la relazione uomo-macchina si trasformò in esperienza. Il design non era più solo ergonomia: diventava estetica funzionale, gratificazione sensoriale, accessibilità emotiva. L’informatica, da strumento tecnico, si fece linguaggio sensibile.
L’emergere della user experience (UX) negli anni Novanta sancì l’ingresso dell’edonismo nella progettazione software: l’utente non doveva solo compiere azioni, ma trovarle piacevoli. La gamification, la logica delle ricompense, l’economia del feedback positivo segnarono il passaggio a una concezione esperienziale della tecnologia. L’utente diventava fruitore, e la macchina si configurava come partner dell’attenzione e del desiderio.
L’AI ha consolidato questa traiettoria. I modelli generativi attuali – da ChatGPT a Claude, da Gemini ai sistemi di recommendation di Netflix e Spotify – non sono solo strumenti logici, ma dispositivi affettivi. Funzionano perché apprendono ciò che ci piace: stile, tono, ritmo, lessico. E ce lo ripropongono in forme predittive che appaiono nuove, ma in realtà perfettamente calibrate sulle nostre preferenze cognitive e sensoriali.
Questa logica edonica è fondata sul reinforcement learning: l’algoritmo riceve una “ricompensa” ogni volta che produce un output gradito all’utente (click, like, tempo di permanenza). L’AI viene così addestrata non solo sulla veridicità dei dati, ma sulla qualità esperienziale dell’interazione. Emergono forme di intelligenza affettiva simulata, progettate per apparire empatiche, comprensive, rassicuranti. Il rischio non è la finzione, ma la coazione al piacere: un ambiente in cui ogni frizione viene rimossa, ogni attrito neutralizzato, ogni dissenso anticipato e dissolto.
La funzione edonica dell’AI si intreccia con le logiche dell’economia dell’attenzione. Tristan Harris ha parlato di “race to the bottom of the brainstem”, una corsa verso la manipolazione più profonda degli istinti primari. Le AI odierne, per come sono implementate nei contesti commerciali, sono ottimizzate per catturare l’interesse, prolungare l’interazione, massimizzare l’engagement. Ma l’engagement è un indicatore del piacere somministrato, non del valore generato. Le metriche dell’edonismo computazionale sono quantità di tempo, intensità di risposta, persistenza nel ciclo.
Aumentano così i rischi di dipendenza comportamentale, alienazione cognitiva, consumo passivo di contenuti generati per compiacere più che per stimolare. La macchina ci rende felici, ma di una felicità piatta, confezionata, addomesticata.
Nel nuovo contratto uomo-macchina, il lavoro non è più l’unica finalità. La macchina si propone
come alleata del benessere, della gratificazione, dell’appagamento. L’edonismo algoritmico si traduce in interfacce carezzevoli, in companion AI che dialogano con il nostro io emotivo, in dispositivi che si adattano al nostro tono d’umore. Siamo di fronte a una forma di intimità artificiale. Nel quadro del postumanesimo, ciò solleva interrogativi profondi: quale antropologia si va delineando? Quali soggettività sono compatibili con un ecosistema costruito per piacere?
L’edonismo, una volta cifra della libertà individuale, rischia di diventare vincolo strutturale.
L’edonismo computazionale richiede una nuova forma di regolazione: non più solo tecnico- normativa, ma anche psicoetica. Servono strumenti per rendere visibile il modo in cui gli algoritmi apprendono, riproducono e modulano la gratificazione. Serve una trasparenza emotiva dei sistemi, che mostri non solo ciò che fanno, ma perché ci piace ciò che fanno. Occorre affermare un diritto al disincanto: la libertà di scegliere esperienze non ottimizzate, di vivere anche l’errore, il dubbio e la noia come parti essenziali della vita digitale. Per realizzarlo, servono tre direzioni operative: innanzitutto, un’educazione critica che renda visibili i meccanismi di gratificazione algoritmica e sviluppi soggettività autonome; in secondo luogo, strumenti di audit psicotecnico per valutare l’impatto affettivo dell’AI sull’utente; infine, nuove metriche di benessere digitale che misurino qualità, significato e libertà, superando il paradigma dell’engagement come unico criterio di valore.
L’edonismo non è un nemico da combattere, ma un campo da comprendere e ripoliticizzare. L’AI può essere progettata per generare piacere senza colonizzare il desiderio. Ma ciò richiede una nuova etica della progettazione e una nuova estetica della responsabilità. L’obiettivo non è spegnere il piacere, ma restituirgli senso, sottrarlo all’automazione e restituirlo alla scelta. In ultima istanza, la domanda che dobbiamo porci non è: “quanto ci piace l’AI?”, ma: “che tipo di piacere ci sta insegnando a desiderare?”
Algoritmi del piacere: edonismo digitale e intelligenza artificiale nel nuovo patto uomo-macchina
 Giovanni Di Trapani
Giovanni Di Trapani