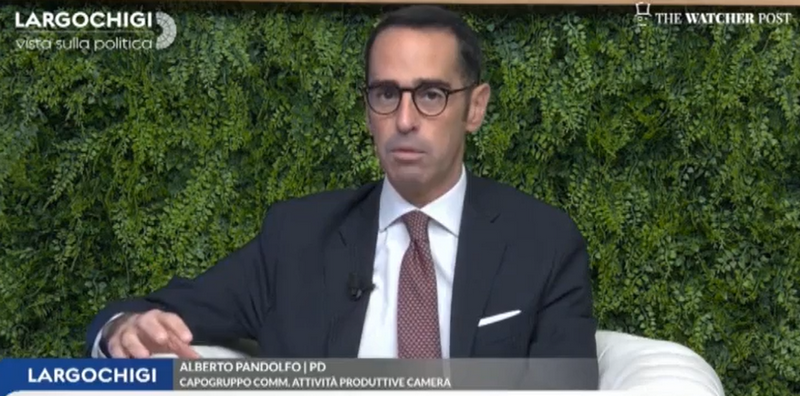Il nuovo Rapporto ORES 2025 dell’Istituto per la Competitività svela un Paese a due velocità: connesso come mai prima, ma ancora impantanato in una cultura digitale che non decolla.
Tra 5G, fibra ottica e data center, l’Italia si è costruita una rete d’avanguardia. Ma senza competenze diffuse, formazione mirata e una visione industriale di lungo periodo, rischia di rimanere una nazione tecnologicamente moderna ma culturalmente analogica.
L’Italia nell’era del paradosso digitale
C’è qualcosa di profondamente simbolico nel ritratto che I-Com fa dell’Italia del 2025. È un Paese che corre veloce nei cavi di fibra e nelle onde del 5G, ma che inciampa ancora nelle persone che dovrebbero abitare quella rete.
Il Rapporto ORES 2025, intitolato “Sui bit della competitività”, non è solo un’analisi tecnica: è una diagnosi culturale. Racconta una nazione che ha investito miliardi in infrastrutture, spesso con risultati eccellenti, ma che non ha ancora costruito l’ecosistema umano e formativo necessario per trasformare la connettività in innovazione e produttività.
Roma, sede della presentazione del rapporto, diventa così lo specchio di un Paese che oscilla tra entusiasmo e ritardo: capitale di una rivoluzione digitale che avanza, ma che rischia di lasciare dietro di sé interi segmenti di società, imprese e pubbliche amministrazioni ancora ancorati al passato.
La fibra corre, le persone no
Sul fronte infrastrutturale, l’Italia non ha nulla da invidiare ai grandi player europei. Il 5G copre oltre il 99% della popolazione e la banda ultralarga raggiunge ormai anche le aree interne, grazie a una spinta decisa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Eppure, dietro la potenza della rete, si nasconde una fragilità strutturale: la distanza tra infrastruttura e competenza.
Secondo l’I-Com Ultrabroadband Index 2025, l’Italia scende al 14° posto in Europa, nonostante una rete tra le più capillari. Il motivo è semplice e inquietante: non basta essere connessi se non si sa cosa farne. Solo il 45,8% degli italiani possiede competenze digitali di base, un dato che racconta un divario culturale prima ancora che tecnologico.
La velocità della connessione non coincide con la velocità del pensiero digitale. E mentre i bit corrono, la crescita rallenta. È il sintomo di una modernità incompiuta: un Paese che ha imparato a navigare, ma non ancora a orientarsi.
PMI: il cuore produttivo resta in modalità analogica
Il cuore economico dell’Italia – le piccole e medie imprese – pulsa ancora in modalità analogica.
Secondo I-Com, solo il 27,2% delle aziende italiane presenta un’elevata intensità digitale, contro una media UE del 34,3%. E appena il 17,9% offre formazione ICT ai dipendenti.
È un dato che pesa, perché le PMI non sono una categoria, ma l’ossatura stessa del sistema produttivo italiano.
La transizione digitale per loro non è una moda, ma una questione di sopravvivenza: chi non digitalizza processi, logistica e marketing, rischia di sparire in pochi anni dal mercato globale.
Il presidente di I-Com, Stefano da Empoli, lo dice con chiarezza: “Serve una scossa culturale. Le imprese devono essere messe nelle condizioni di innovare, ma anche spinte a farlo. La burocrazia deve diventare alleata dell’innovazione, non il suo freno”.
È un messaggio che tocca un nervo scoperto: l’Italia non manca di talento, ma di organizzazione, fiducia e formazione continua. E finché la trasformazione resterà concentrata in poche multinazionali o startup urbane, il Paese continuerà a dividersi tra chi vola e chi arranca.
Servizi pubblici digitali: la rivoluzione che cambia la quotidianità
C’è però un fronte in cui l’Italia mostra una crescita tangibile: i servizi pubblici digitali.
Il 69,4% dei processi amministrativi è ormai digitalizzato, con una spinta decisiva su identità digitale e pagamenti elettronici.
Lo SPID e la CIE sono diventati strumenti familiari per milioni di cittadini e il sistema PagoPA ha rivoluzionato il modo in cui lo Stato incassa, riducendo costi e tempi.
Ma al di là dei numeri, il dato più interessante è percettivo: oltre il 70% degli italiani ritiene che la digitalizzazione dei servizi renda la vita più semplice. È la prova che il digitale, quando è accessibile e trasparente, smette di essere una promessa astratta e diventa esperienza quotidiana.
I-Com stima che entro il 2027 i servizi digitali per i cittadini saranno completati, compresa la piena attivazione della cartella clinica elettronica, mentre quelli per le imprese seguiranno entro il 2031.
L’Italia, in questo campo, sta imparando che il digitale non è un obiettivo, ma un linguaggio amministrativo del futuro.
Formazione digitale: l’Italia degli autodidatti
C’è un tratto quasi antropologico nel modo in cui gli italiani imparano la tecnologia: da soli.
Il 58% dei cittadini dichiara di apprendere competenze digitali autonomamente, il 43% grazie a parenti e amici e solo il 16% attraverso corsi formali.
È il segno di una cultura che si adatta, ma non si struttura.
Eppure, un segnale inatteso arriva dall’intelligenza artificiale. Un quarto degli italiani afferma di aver imparato qualcosa di nuovo grazie a strumenti di IA generativa: dai modelli linguistici come ChatGPT alle app creative basate su machine learning.
L’AI, insomma, non è più solo un argomento di dibattito, ma un nuovo ambiente di apprendimento.
Cresce anche la richiesta di politiche pubbliche più coraggiose: quasi la metà degli intervistati invoca corsi gratuiti promossi dallo Stato o dalle università e il 27% suggerisce obblighi formativi con incentivi fiscali per le imprese.
L’Italia digitale non è un sogno lontano: è un’aspirazione diffusa che chiede di essere trasformata in sistema.
Data Center: la spina dorsale invisibile dell’economia digitale
Dietro la connettività e i servizi, ci sono infrastrutture fisiche spesso ignorate: i data center.
L’Italia ne conta 204 attivi, concentrati nel Nord, ma in crescita anche al Centro e al Sud.
Sono il motore silenzioso della rete, dove scorrono i dati che alimentano banche, sanità, pubblica amministrazione e industria.
La percezione dei cittadini è sorprendentemente matura: oltre la metà del campione intervistato riconosce nei data center una leva economica e occupazionale.
Nonostante una scarsa conoscenza diretta (il 47% non sa se ne esistano nel proprio territorio), prevale una visione positiva: infrastrutture non più percepite come minaccia, ma come opportunità di sviluppo sostenibile.
L’Italia, dopo anni di esitazioni, sembra pronta ad abbracciare la sfida della sovranità digitale, comprendendo che senza una base dati nazionale e resiliente non esiste competitività tecnologica possibile.
L’intelligenza artificiale: la rivoluzione che divide
Se c’è un terreno dove il futuro è già iniziato, è quello dell’intelligenza artificiale.
In Italia, l’adozione cresce rapidamente: l’8,2% delle imprese utilizza soluzioni IA, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Ma la media europea (13,5%) resta lontana.
L’IA generativa, capace di creare testi, immagini e codici, è la nuova frontiera. Il 20% delle aziende italiane la impiega in modo strutturale, il 43% la sta sperimentando e un altro 28% la considera nel medio termine.
È una rivoluzione silenziosa, che sta riscrivendo modelli produttivi, marketing e comunicazione, ma che solleva anche interrogativi etici e sociali.
L’interesse pubblico cresce di pari passo: l’Italia guida l’Europa per ricerche online sui vantaggi e sui rischi dell’IA, segno di una curiosità attenta, non ingenua.
Siamo un Paese che vuole capire prima di adottare, riflettere prima di correre. E questo, nel lungo periodo, potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo.
Università e formazione in IA: il laboratorio italiano del futuro
L’università italiana si sta muovendo e con ritmo sorprendente.
Per l’anno accademico 2025/2026, I-Com censisce 1.143 corsi dedicati all’intelligenza artificiale, tra lauree, master e dottorati.
Il Lazio primeggia per corsi specializzati, la Lombardia per quelli integrati, mentre la Campania emerge come polo di sperimentazione nel Mezzogiorno.
È un ecosistema ancora disomogeneo, con regioni – come Basilicata, Molise e Valle d’Aosta – completamente assenti, ma rappresenta un segnale chiaro: la formazione è tornata al centro del discorso sull’innovazione.
E non solo nell’IA. Crescono anche i corsi sull’economia spaziale, con oltre 340 programmi attivi che intrecciano satelliti, big data e sostenibilità.
L’Italia sembra finalmente comprendere che la competitività non nasce nei consigli di amministrazione, ma nelle aule universitarie.
Verso il 2030: la sfida del capitale umano
Guardando avanti, le proiezioni I-Com sono chiare: l’Italia raggiungerà i target di copertura 5G e FTTP entro il 2028 e completerà i servizi pubblici digitali entro il 2030.
Ma il resto, ovvero competenze, adozione del cloud, digitalizzazione delle PMI, richiederà decenni, se non secoli, ai ritmi attuali.
La sfida non è più tecnologica, ma antropologica.
La transizione digitale è diventata una questione di fiducia, cultura e visione collettiva.
Non si tratta solo di installare reti, ma di cambiare mentalità: nelle scuole, nelle imprese, nella politica.
Il capitale umano è la nuova infrastruttura strategica e la formazione digitale è il suo carburante.
Dal segnale al significato: l’Italia che deve ancora connettersi a sé stessa
L’Italia del 2025 è un Paese che ha imparato a connettersi, ma non ancora a comunicare con se stessa.
Ha costruito la rete, ma non il significato che la abita.
Ha portato la fibra nelle case, ma non sempre la cultura nelle menti.
Il Rapporto ORES 2025 ci ricorda che il futuro non dipenderà solo da quanto siamo veloci, ma da come sapremo usare quella velocità per costruire valore, conoscenza e coesione.
La sfida del prossimo decennio non sarà solo digitale, ma profondamente umana: saper trasformare la connessione in comprensione.
Perché nel nuovo secolo, la vera infrastruttura di un Paese non è la rete, ma la coscienza collettiva che la percorre.
E quella, in Italia, ha ancora molto da imparare.