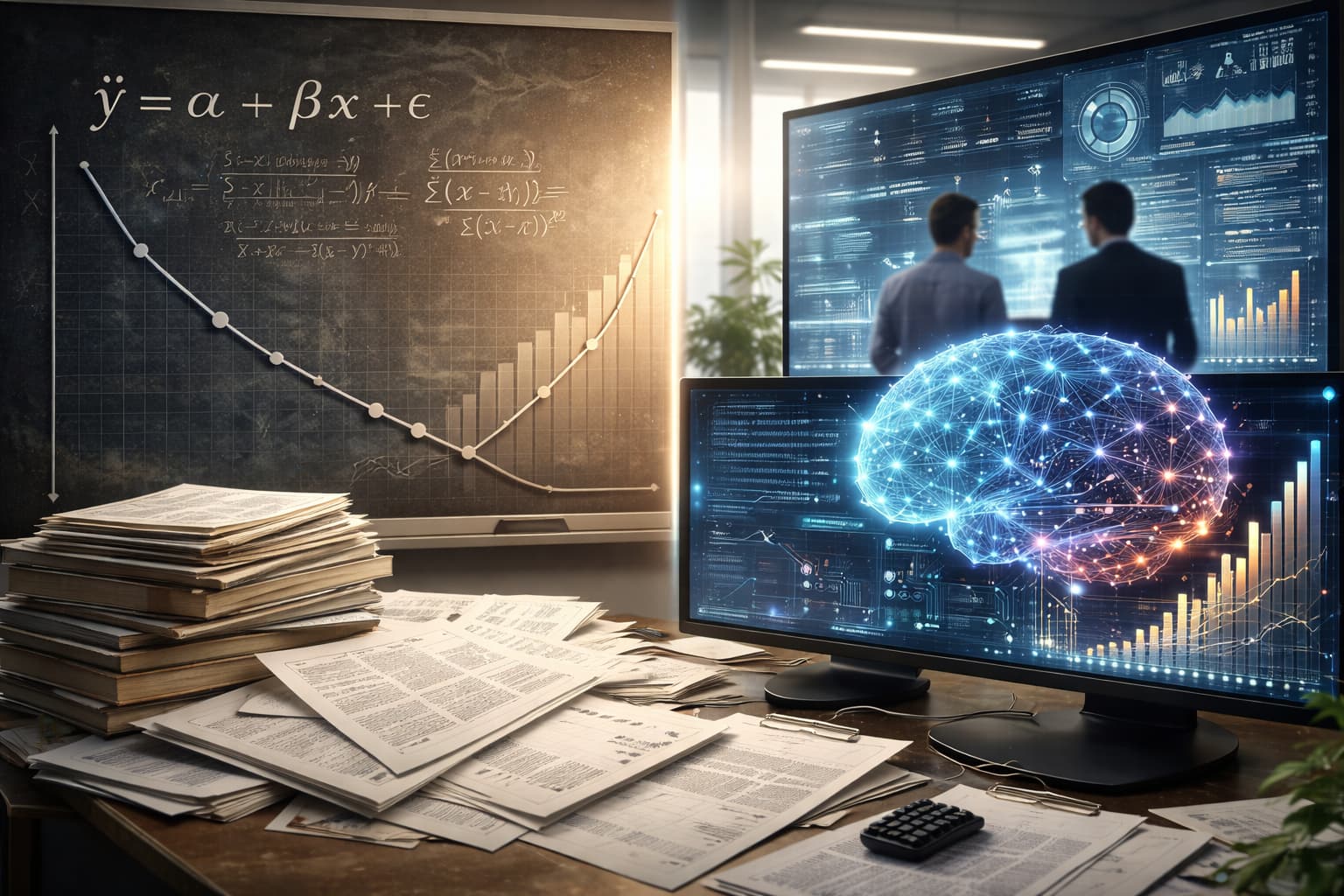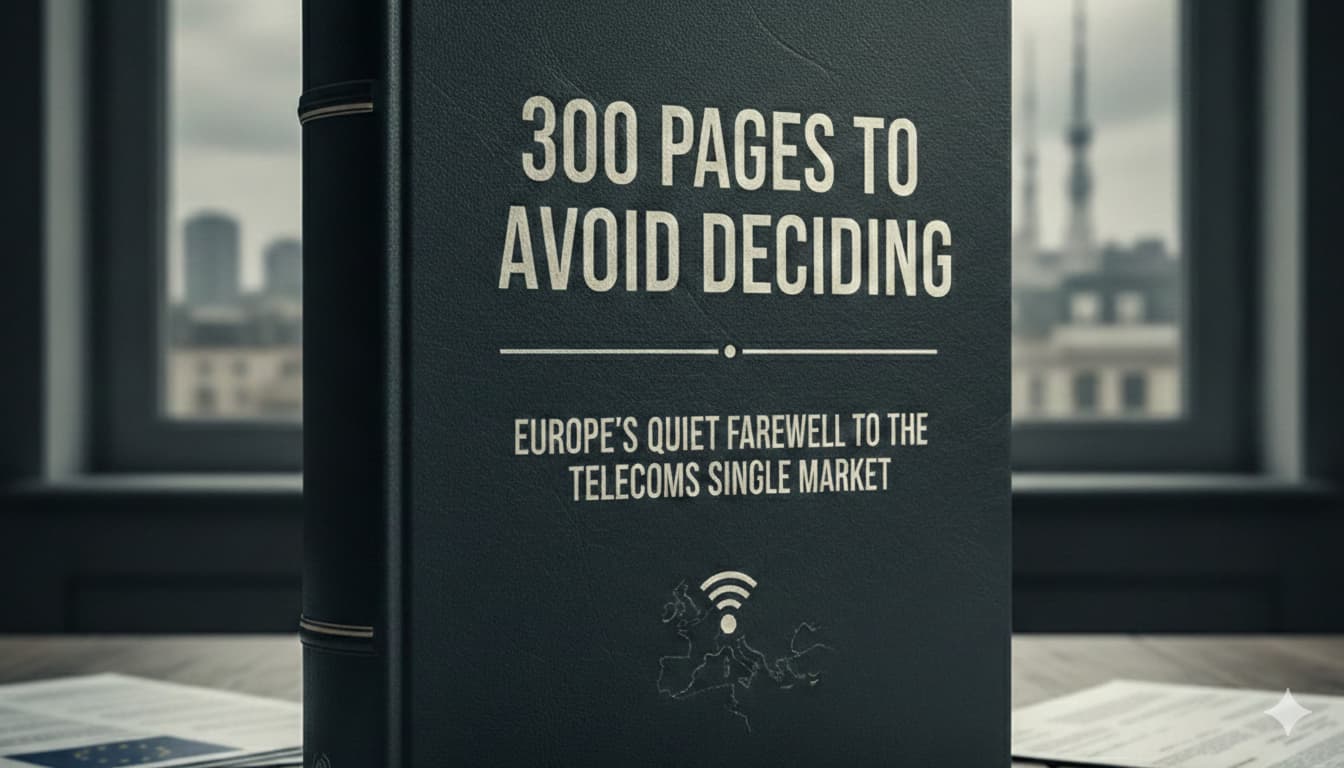I leader dell’Unione Europea approvano il principio di una riduzione del 90% delle emissioni entro il 2040, ma le tensioni interne e il peso della competizione globale rischiano di rallentare la marcia verso la neutralità climatica.
Tra transizione ecologica, sicurezza energetica e difesa industriale, l’UE cerca di mantenere la leadership mondiale nella lotta al cambiamento climatico, mentre cresce la resistenza di governi e cittadini preoccupati per i costi della rivoluzione verde.
L’Europa davanti al bivio del clima
A meno di un mese dal vertice globale sul clima COP30, i leader europei hanno raggiunto un accordo politico preliminare per fissare un nuovo obiettivo vincolante: ridurre del 90% le emissioni nette entro il 2040, sulla via della neutralità climatica totale nel 2050.
È una decisione che proietta l’Unione Europea come avanguardia mondiale della politica ambientale, ma che al tempo stesso rivela le profonde fratture tra Stati membri, divisi tra ambizione ecologica e timori economici.
Il compromesso raggiunto, dopo lunghe ore di confronto, ha un retrogusto di fragilità:
pur riconoscendo la necessità di agire contro il riscaldamento globale, i governi hanno inserito una “clausola di revisione”, che in futuro potrebbe attenuare l’obiettivo qualora il quadro economico o tecnologico lo rendesse impraticabile.
L’obiettivo del 2040: tra scienza e politica
Il target del 2040 non nasce nel vuoto.
È il tassello mancante tra il -55% delle emissioni entro il 2030 (già vincolante per legge) e il traguardo net zero nel 2050.
Un percorso disegnato per garantire continuità e coerenza alle politiche del Green Deal, ma che oggi si scontra con la realtà di un continente che affronta guerra, inflazione, crisi energetica e rallentamento industriale.
Gli scienziati non hanno dubbi: per evitare le conseguenze peggiori del riscaldamento globale, l’Europa deve tagliare le emissioni in modo drastico.
Ma i leader politici devono rispondere anche a un’altra urgenza: mantenere il consenso sociale e proteggere la competitività economica.
“Nessuno mette in discussione la protezione del clima,” ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. “Ma dobbiamo farlo senza compromettere la forza della nostra industria”.
Dietro questa frase si nasconde l’essenza del dilemma europeo: come salvare il pianeta senza sacrificare l’economia che lo sostiene.
L’Europa a due velocità della transizione verde
Se i Paesi del Nord e dell’Ovest – come Germania, Paesi Bassi e Scandinavia – si mostrano fiduciosi nelle proprie capacità tecnologiche, l’Est Europa teme di restare indietro.
Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca hanno chiesto più tempo e più fondi, denunciando una transizione “asimmetrica” che rischia di penalizzare i Paesi con economie più fragili e sistemi energetici più dipendenti dal carbone.
Varsavia, in particolare, spinge per una maggiore flessibilità, anche attraverso l’acquisto di crediti di carbonio internazionali o la possibilità di compensare le emissioni con attività forestali.
Tuttavia, l’uso delle foreste come “serbatoio di CO₂” è sempre più controverso: gli incendi ricorrenti e il degrado ambientale stanno riducendo la loro capacità di assorbimento, rendendo meno credibili i bilanci climatici di diversi Paesi.
L’UE si trova così intrappolata in una dialettica di equità e responsabilità: chi può permettersi di agire più in fretta deve farlo, ma chi non può non deve essere lasciato indietro.
Una tensione che, se non risolta, rischia di trasformare la transizione ecologica in una nuova linea di frattura Est-Ovest.
Il nodo finanziario: chi paga la rivoluzione verde
La questione più esplosiva resta quella del finanziamento della transizione.
Nei documenti ufficiali si parla di “enabling conditions” — le condizioni abilitanti — che dovranno sostenere cittadini e imprese nel percorso verso l’economia pulita.
Ma dietro questa formula neutra si nasconde una verità scomoda: i costi della decarbonizzazione sono enormi e la capacità di sostenerli varia enormemente tra i 27 membri.
Il premier olandese Dick Schoof ha espresso un sentimento diffuso:
“Dobbiamo mantenere i nostri obiettivi climatici, ma serve realismo. I cittadini devono poter sostenere la transizione e le imprese devono poter competere”.
In altre parole, l’Europa può guidare la rivoluzione verde solo se riuscirà a non trasformarla in un fardello sociale.
E per farlo, dovrà costruire un nuovo equilibrio tra rigore ambientale e redistribuzione economica, una sorta di Green Welfare capace di rendere la transizione popolare, non punitiva.
Il fattore geopolitico: tra Pechino, Washington e Mosca
La politica climatica europea non vive in un vuoto geopolitico.
Da un lato, la guerra in Ucraina ha spinto Bruxelles ad accelerare l’indipendenza dal gas russo e a investire in rinnovabili.
Dall’altro, la competizione con Stati Uniti e Cina sta ridisegnando la geoeconomia delle tecnologie verdi.
Washington attira investimenti con l’Inflation Reduction Act, offrendo sussidi generosi alle aziende che producono in territorio americano.
Pechino, nel frattempo, domina la filiera globale delle batterie, dei pannelli solari e delle terre rare, consolidando la propria posizione come “fabbrica della transizione”.
In questo scenario, l’Europa rischia di diventare una potenza normativa, ma non produttiva, in grado di fissare regole, ma non di costruire tecnologia.
La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha ammonito:
“La transizione verde è la nostra occasione per rilanciare l’industria europea. Se la perdiamo, perderemo anche la nostra sovranità economica”.
Una transizione in cerca di consenso
Negli ultimi mesi, la Commissione ha iniziato a rivedere alcune misure del Green Deal per placare la crescente opposizione politica.
Il bando alle auto a combustione previsto per il 2035 è in revisione; il mercato del carbonio per i trasporti verrà probabilmente ritardato; e la carbon border tax – pensata per proteggere l’industria europea – sarà modulata per evitare attriti con Stati Uniti, India e Qatar.
Dietro questi aggiustamenti si legge la preoccupazione per una crescente stanchezza climatica tra i cittadini.
Le proteste di agricoltori, autotrasportatori e piccoli imprenditori testimoniano un malessere profondo: la sensazione che la transizione sia stata pensata “dall’alto” e non condivisa “dal basso”.
In molti Paesi, i partiti populisti stanno sfruttando questa frustrazione, proponendo un ritorno al carbone o un rallentamento delle politiche verdi.
La transizione europea rischia così di diventare un campo di battaglia elettorale, più che una strategia comune.
Il rischio e l’opportunità del 2040
Il 2040 non è solo un traguardo tecnico: è una prova identitaria per l’Europa.
Se riuscirà a mantenere la rotta, l’UE potrà dimostrare che la prosperità e la sostenibilità non sono in contraddizione, ma parte di un unico progetto di civiltà.
Se, invece, cederà alle pressioni interne, perderà non solo la leadership climatica, ma la credibilità come potenza globale coerente con i propri valori.
Il rischio è evidente: un’Europa troppo lenta per incidere e troppo divisa per guidare.
Ma la storia europea è fatta di crisi trasformate in opportunità.
Dal carbone e acciaio del dopoguerra nacque l’Unione stessa; forse dal carbonio e dall’idrogeno nascerà la nuova Europa del XXI secolo.
Il secolo verde dell’Europa
Il 2040 rappresenta molto più di una data nel calendario politico.
È la linea di demarcazione tra due modelli di futuro: uno che difende l’esistente e uno che prova ancora a innovare, integrare, guidare.
L’Europa è stata costruita sull’idea che cooperazione e visione possano cambiare il destino di un continente; ora deve dimostrare che possono salvare anche il pianeta.
Il tempo per agire si accorcia, ma la posta in gioco si allarga.
Non si tratta solo di ridurre emissioni, ma di ridefinire il significato stesso di progresso.
Se l’Europa riuscirà a trasformare la crisi climatica nella sua nuova missione fondativa, il 2040 sarà ricordato non come un vincolo, ma come il punto in cui ha imparato di nuovo a respirare.