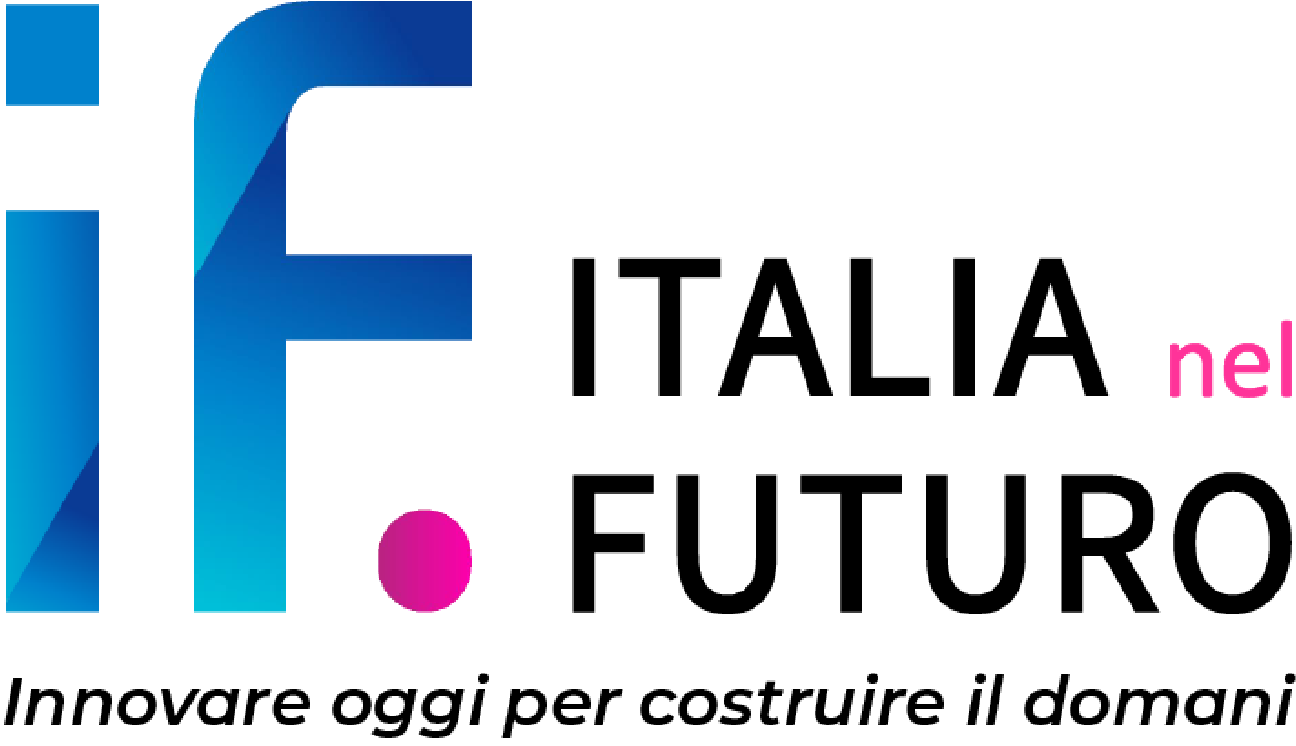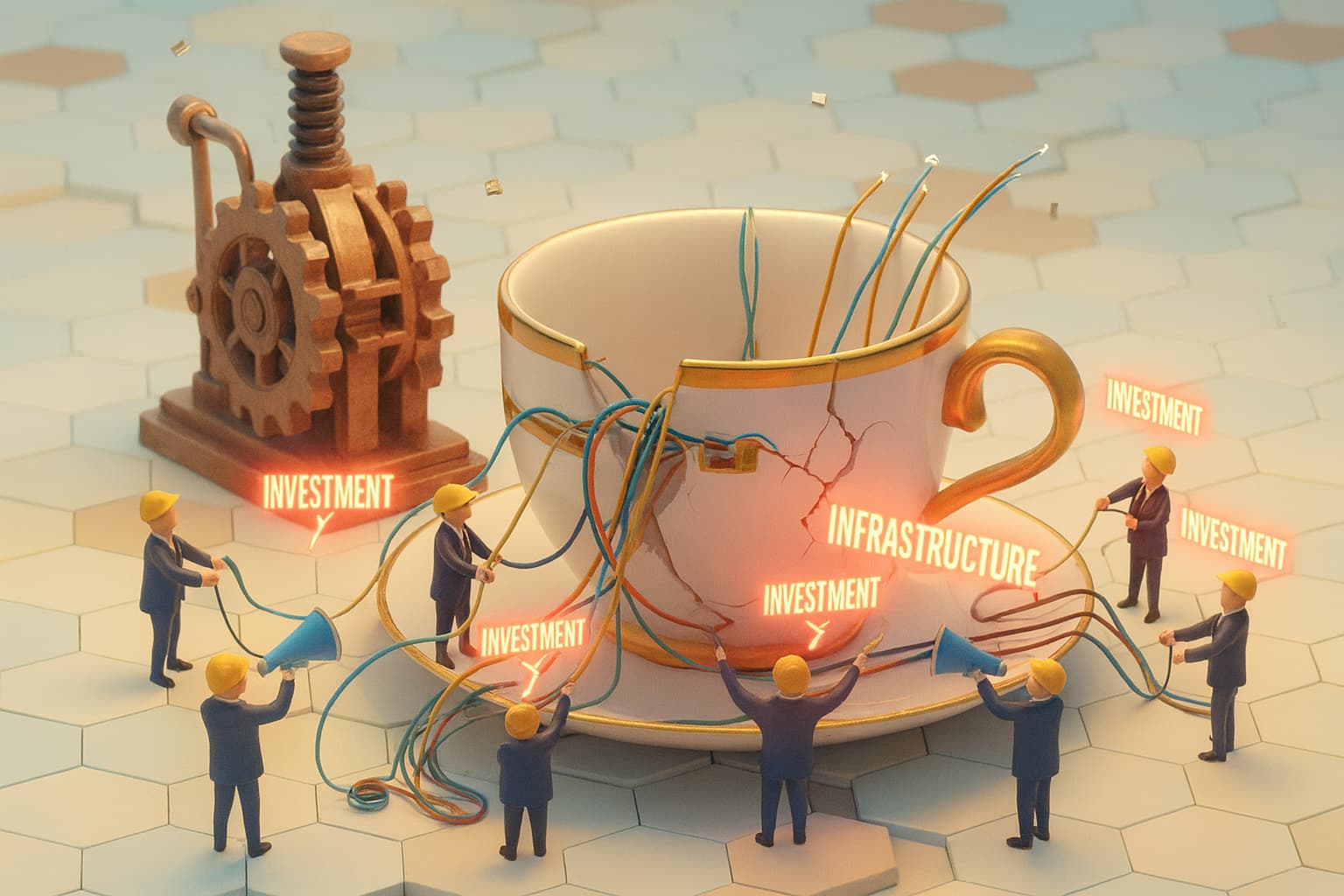L’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur viene presentato come un successo geopolitico: la dimostrazione che l’Europa è ancora in grado di plasmare la globalizzazione, anziché subirla. Uno sguardo più attento suggerisce l’esatto contrario. Questo non è un accordo pensato per il mondo che sta emergendo, ma per uno che non esiste più.
L’accordo si fonda su un presupposto che per decenni ha guidato la politica commerciale europea: l’idea che la riduzione dei dazi e l’ampliamento dell’accesso ai mercati si traducano automaticamente in influenza, convergenza e prosperità. Oggi questo presupposto non è più valido. Nell’economia globale contemporanea, il potere è determinato molto meno dai dazi e sempre più dalle barriere non tariffarie, dai regimi regolatori, dal controllo delle infrastrutture digitali, dagli standard tecnologici, dai flussi di dati e dagli ecosistemi industriali. Su questi aspetti, l’accordo UE–Mercosur dice ben poco.
La sua architettura resta ancorata a una logica di fine Novecento: accesso ai mercati in cambio di accesso ai mercati, soprattutto per le merci. Ma il vero terreno di competizione del commercio moderno è altrove — negli standard per i servizi digitali, nelle regole sui dati, nelle certificazioni tecnologiche, nella sicurezza delle catene del valore, nei sistemi energetici e nella manifattura avanzata. È qui che oggi si esercita il potere economico, ed è qui che l’accordo risulta carente.
In un mondo in cui l’accesso ai dati, alle piattaforme digitali e ai regimi di certificazione determina sempre più spesso chi può commerciare e chi no, gli accordi concentrati principalmente sui dazi rischiano semplicemente di mancare il punto.
Il risultato è maggiore apertura, ma senza rilevanza strategica.
Questa asimmetria emerge chiaramente nelle contraddizioni interne dell’Europa. L’UE chiede ai propri produttori di sostenere i costi delle transizioni verde e digitale attraverso regolazione, prezzi del carbonio, requisiti di conformità e investimenti tecnologici. Allo stesso tempo, apre il proprio mercato a importazioni prodotte in contesti regolatori, tecnologici e ambientali non pienamente equivalenti. Le disposizioni su sostenibilità e cooperazione regolatoria incluse nell’accordo sono politicamente rassicuranti, ma economicamente deboli, basate più sul dialogo che su un reale allineamento vincolante.
Non si tratta di un dettaglio tecnico. Le barriere non tariffarie e gli standard tecnologici sono oggi gli strumenti centrali del potere commerciale. Un accordo che non li affronta in modo sostanziale è, per definizione, un accordo del passato.
I sostenitori dell’accordo lo giustificano spesso con argomentazioni geopolitiche. L’America Latina, sostengono, è troppo importante per essere lasciata all’influenza strategica di Cina e Stati Uniti. La diagnosi è corretta. La conclusione no. L’accesso ai mercati, da solo, non crea allineamento strategico. Non struttura gli ecosistemi digitali, non ancora le catene tecnologiche, non costruisce dipendenze industriali di lungo periodo.
Nell’economia contemporanea, l’influenza si costruisce attraverso investimenti duraturi, integrazione tecnologica e capacità di modellare l’architettura regolatoria e digitale entro cui avverrà la crescita. Su tutti questi fronti, l’accordo UE–Mercosur è sorprendentemente debole. Non incorpora gli standard digitali e tecnologici europei né colloca le imprese europee al centro della futura trasformazione industriale della regione.
Il confronto con le altre grandi potenze è istruttivo. La Cina abbina commercio, infrastrutture, piattaforme tecnologiche, finanziamenti e standard. Gli Stati Uniti integrano sempre più commercio, sicurezza, sussidi e controllo delle tecnologie critiche. L’Europa, invece, continua a negoziare come se la liberalizzazione tariffaria fosse ancora la leva decisiva.
Non lo è.
Il problema più profondo che l’accordo UE–Mercosur mette in luce è concettuale. L’Unione europea non dispone di una strategia economica esterna coerente che integri commercio, tecnologia, politica industriale e geopolitica in un unico quadro. In assenza di tale strategia, gli accordi commerciali rischiano di diventare esercizi di competenza procedurale più che strumenti di potere.
Questo accordo va quindi letto per ciò che è: un compromesso tecnicamente solido e politicamente conveniente, che gestisce l’eredità di un vecchio modello di globalizzazione, ma ignora in larga misura le forze che definiranno il prossimo.
All’Europa non servono meno accordi commerciali. Le servono accordi che riconoscano che barriere non tariffarie, regole digitali e standard tecnologici determinano oggi chi vince e chi perde nel commercio globale. Fino a quando questo cambio di paradigma non avverrà, l’Europa rischia di liberalizzare i mercati mentre perde terreno sul piano strategico.
Il rischio non è che l’Europa sia troppo aperta. È che stia affrontando il futuro con gli strumenti del passato.