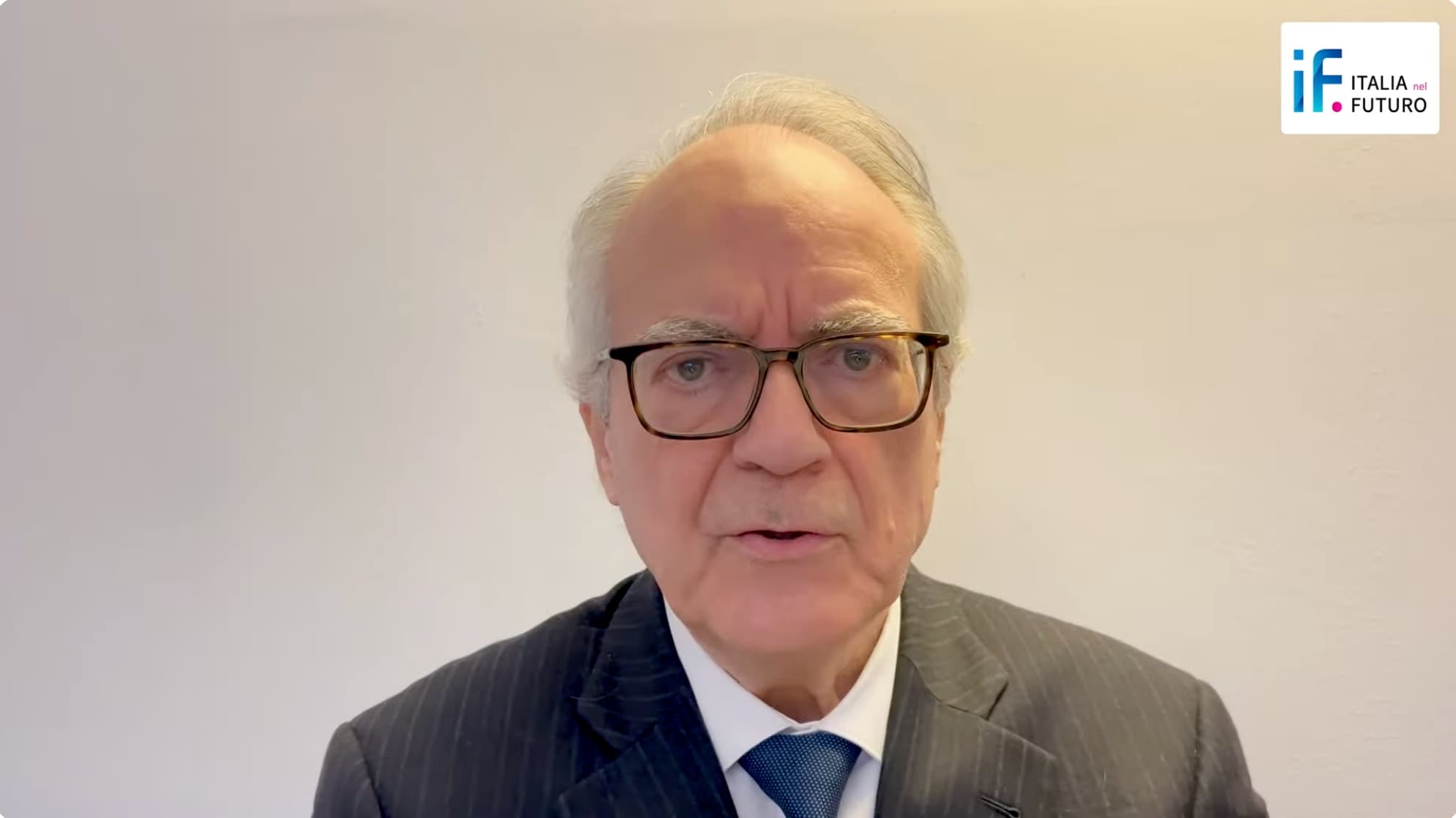I ricercatori militari cinesi modellano un attacco su larga scala per mettere a tacere la rete satellitare di SpaceX su un’area grande quanto Taiwan.
Lo studio indica che neutralizzare Starlink è possibile, ma richiederebbe un’operazione mastodontica con oltre mille droni jammer. Tra algoritmi, orbite e geopolitica, emergono nuovi interrogativi sul ruolo delle costellazioni private nei conflitti moderni.
Quando la guerra ha incontrato lo spazio commerciale
Quando le forze russe entrarono in Ucraina, all’inizio del 2022, Kyiv fece qualcosa che fino ad allora sembrava quasi improbabile: chiese aiuto direttamente a Elon Musk. Voleva Starlink. Aveva bisogno di ricostruire in fretta una rete di comunicazioni che le prime ondate di attacchi avevano quasi demolito.
Pochi giorni dopo, migliaia di terminali apparvero nei rifugi, nei centri di comando, accanto a droni improvvisati e tablet militari. Sembrava un gesto minimale, quasi artigianale; in realtà fu un cambio di paradigma. Starlink riportò online intere zone sotto assedio, spezzando quello che, per un attimo, era parso un blackout totale.
La risposta russa arrivò con la consueta grammatica: jamming, disturbi, tentativi di saturazione dello spettro. Qualcosa funzionò, all’inizio. Poi SpaceX spinse un aggiornamento software e ricalibrò la costellazione. E, quasi come un colpo di scena narrativo, molti jammer russi si zittirono.
Fu una dimostrazione di agilità tecnologica che gli stati maggiori non poterono ignorare. A Pechino, soprattutto, non passò inosservata.
Perché Pechino guarda Starlink con inquietudine strategica
Per la leadership cinese, qualunque scenario riguardi Taiwan ha un centro di gravità molto preciso: il controllo dello spettro elettromagnetico. Senza di esso, nessuna operazione combinata, aria, mare, cyber, spazio, può funzionare davvero.
E qui Starlink entra in scena come un fattore disturbante. Una rete resiliente, capace di adattarsi quasi organicamente alle minacce, distribuita su migliaia di satelliti in orbita bassa. Terminali economici, trasportabili, che possono garantire connettività anche quando tutto il resto cade.
Per la Cina, la possibilità che Taiwan o forze esterne possa appoggiarsi a un sistema così robusto è una sfida che va ben oltre la tecnica: è geopolitica pura.
La domanda, si dice negli ambienti militari, non è tanto “Starlink può essere un problema?”, quanto: “Possiamo spegnerlo, se dovesse servire?”
Dentro la simulazione cinese: un assalto orchestrato al cielo
Uno studio realizzato da un gruppo di scienziati cinesi, pubblicato su una rivista militare-tecnico-scientifica Systems Engineering and Electronics, tenta di rispondere proprio a questa domanda. Non è un documento propagandistico, né una fantasia da romanzo militare. È una simulazione rigorosa, fatta di algoritmi, di modelli orbitali, di mappe di frequenze, di curve di potenza.
Il team ha immaginato uno scenario in cui la Cina volesse rendere inutilizzabile Starlink sopra un’area vasta quanto Taiwan. Non un’interferenza puntuale, ma un blackout funzionale. Una “bolla di silenzio digitale”.
La conclusione è di quelle che fanno sobbalzare: l’operazione è possibile, sì, ma solo dispiegando oltre 1.000 droni jammer, in volo continuo, coordinati in tempo reale, organizzati su livelli diversi di quota e potenza. Un esercito volante di interferenze, costruito per saturare lo spazio radio fino a sommergere il segnale satellitare utile.
Un’immagine quasi irreale: un cielo affollato di droni che non attaccano bersagli fisici, ma combattono contro un’infrastruttura orbitale che, intanto, continua a muoversi sopra le loro teste, cambiando frequenze come un animale che muta pelle.
La dura realtà della scala operativa
Un migliaio di droni specializzati non sono un esercito impossibile, per la Cina. Ma non sono neppure un dettaglio logistico trascurabile. Occorrono piattaforme affidabili, alimentazione continua, coordinamento impeccabile, un sistema di comando che non collassi alla prima interferenza.
Il vero punto, però, è concettuale: per contrastare una costellazione distribuita, serve una forza di disturbo altrettanto distribuita. Non più pochi jammer terrestri da migliaia di watt, ma centinaia, mille piattaforme mobili, capaci di seguire la danza dei satelliti.
È una rivoluzione silenziosa nella dottrina della guerra elettronica e la simulazione cinese ne espone con lucidità la logica: contro un ecosistema adattivo, serve un ecosistema di attacco altrettanto adattivo.
Ciò che la simulazione rivela e ciò che prudentemente evita
Lo studio ammette indirettamente che Starlink è percepito come un nodo militare, pur essendo nato come progetto commerciale.
Riconosce che non è invincibile, ma che piegarlo richiede un livello di complessità e di coordinamento raro, forse rarissimo.
Non affronta, però, un punto cruciale: la capacità di Starlink di aggiornarsi in corsa. Un cambio software, una riconfigurazione del beamforming o un mutamento nei protocolli potrebbe invalidare alcune delle ipotesi simulate. In una guerra elettronica reale, l’avversario non resta fermo. Reagisce e di solito in modi imprevedibili.
Lo studio evita anche di confrontarsi con il rischio politico: un attacco che colpisca una costellazione utilizzata anche da Paesi terzi potrebbe generare frizioni diplomatiche enormi. La guerra elettronica non ha confini netti, brucia tutto ciò che si trova nello spettro.
Lo spazio commerciale diventa infrastruttura militare
Starlink non è un caso isolato. È il simbolo di una tendenza più ampia: tecnologie nate per l’uso civile diventano, repentinamente, elementi di superiorità militare.
È un territorio ambiguo, una zona grigia in cui operano attori privati, governi, forze armate. E in cui le responsabilità non sono più così nitide: fino a che punto è legittimo considerare un’infrastruttura commerciale un obiettivo militare? E quanto è rischioso dipendere da aziende private per la sicurezza nazionale?
La simulazione cinese non risponde, ma solleva domande che domineranno la strategia dei prossimi anni.
La competizione strategica si sposta nelle orbite basse
A prima vista, questo studio potrebbe sembrare solo un esercizio accademico. In realtà, è uno spiraglio sulla prossima fase della competizione globale: non più solo carri armati e portaerei, ma sciami di droni, software dinamici e costellazioni private.
La Cina ha mostrato come potrebbe attaccare. Starlink, con l’esperienza ucraina, ha mostrato come potrebbe difendersi.
Il resto del mondo osserva, con un misto di fascinazione e inquietudine, chiedendosi chi, in questa nuova sfida, avrà l’agilità e le risorse per dettare le regole.
Forse la prossima corsa agli armamenti non avrà il rombo dei motori, ma il silenzio dei satelliti in orbita bassa.
Forse il nuovo “campo di battaglia” è già qui, sopra di noi, invisibile a occhio nudo.
E forse, ecco l’irregolarità, ci siamo accorti troppo tardi che lo spazio commerciale è diventato parte integrante della sicurezza globale.