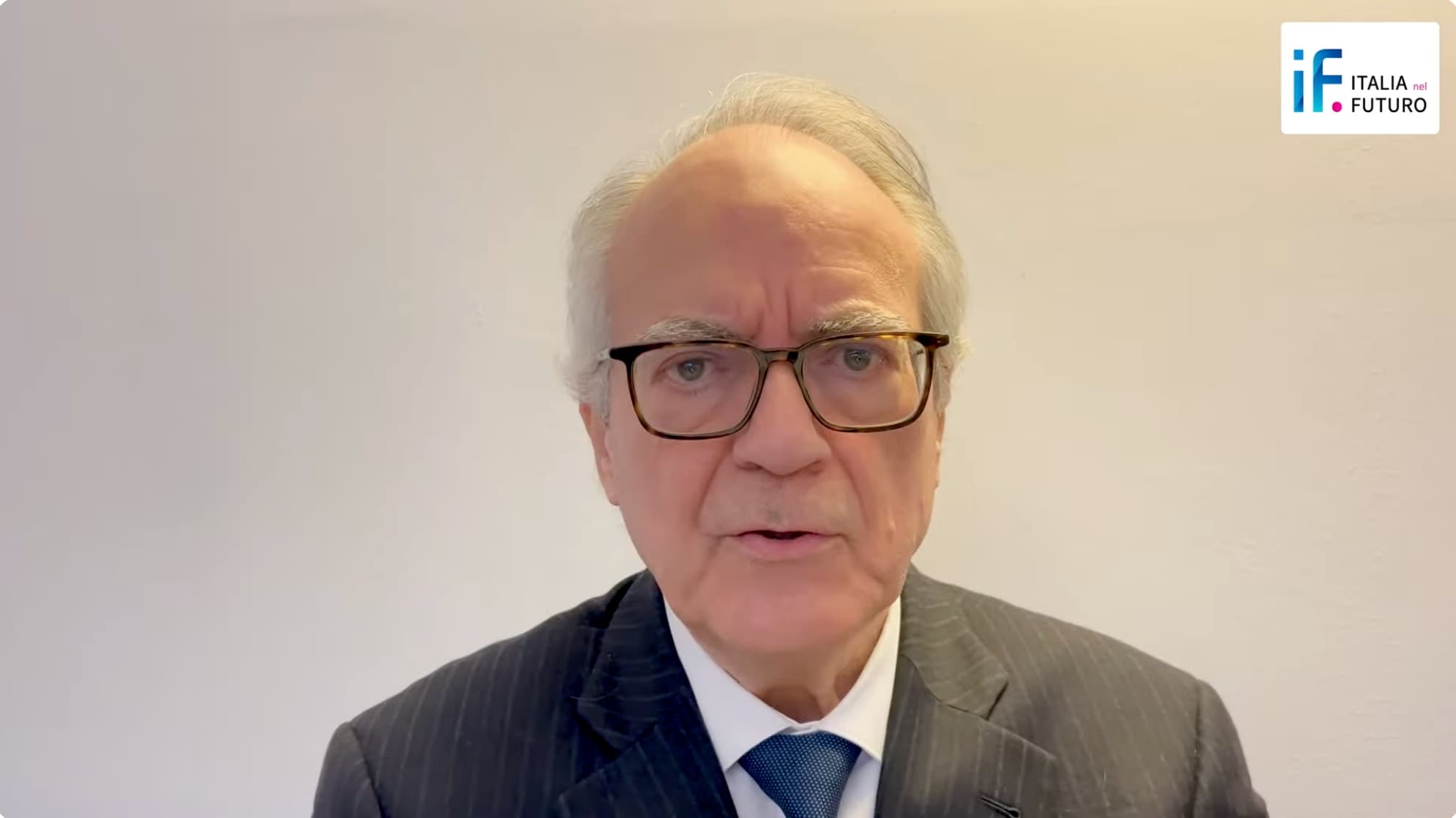Il radiotelescopio CART tra Cina e Argentina è fermo in dogana tra accordi non rinnovati pressioni geopolitiche e sospetti di dual use simbolo della scienza contesa.
Il più grande radiotelescopio dell’America Latina, costruito tra Pechino e Buenos Aires, è fermo in dogana. Dietro il ritardo, l’ombra lunga della competizione tecnologica globale e il nuovo capitolo della guerra fredda tra Stati Uniti e Cina.
Il progetto CART, destinato a esplorare il cielo australe, si è trasformato in un caso diplomatico: pezzi bloccati, accordi sospesi, sospetti di “dual use”. L’Argentina, intrappolata tra potenze, scopre che anche la scienza può essere ostaggio della geopolitica.
Il cielo interrotto
Sotto il vento tagliente della Patagonia, dove la notte si distende come un oceano scuro e il cielo sembra respirare, avrebbe dovuto alzarsi una parabola di metallo capace di ascoltare l’universo.
Il China–Argentina Radio Telescope (CART), concepito come il più grande piatto radio dell’America Latina, doveva essere l’orgoglio di una cooperazione scientifica unica: la fusione tra l’ingegneria cinese e l’orizzonte astronomico argentino.
E invece, oggi, giace in silenzio. I suoi moduli, spediti da Pechino mesi fa, sono fermi alla dogana, bloccati da cavilli tecnici, permessi non rinnovati, forse anche da qualcosa di meno dichiarato: una pressione politica che nessuno ammette, ma tutti percepiscono.
Il progetto che doveva esplorare le stelle si trova ora intrappolato nelle orbite della burocrazia e della geopolitica. Un telescopio sospeso, letteralmente e metaforicamente, tra scienza e potere.
Un sogno scientifico nato in due lingue
Quando, più di dieci anni fa, l’Accademia Cinese delle Scienze (CAS) e la Commissione Nazionale per l’Energia Atomica argentina (CNEA) firmarono l’accordo, la narrazione era limpida: scienza condivisa, progresso reciproco, conoscenza senza confini.
La Cina portava fondi, materiali e know-how ingegneristico. L’Argentina offriva il terreno, i tecnici locali e una posizione astronomica strategica nel Sud del mondo. Un partenariato “alla pari”, almeno sulla carta.
Nella realtà, il progetto è diventato anche una vetrina di influenza tecnologica. Per Pechino, CART è parte di un mosaico di infrastrutture globali che spaziano dall’Africa all’Asia, dai porti ai data center, dalle basi spaziali ai telescopi. Ogni antenna è un pezzo di una rete silenziosa: una costellazione terrestre del soft power scientifico cinese.
Per Buenos Aires, invece, il telescopio rappresentava un riscatto simbolico, la possibilità di tornare a giocare nel campo delle nazioni che producono sapere, non solo materie prime. Un modo per dire: anche noi possiamo osservare il cosmo, non solo subirne le leggi.
Dogane, veti e sospetti: quando la politica blocca il cielo
Poi, a metà 2025, il filo si è spezzato. L’accordo tecnico bilaterale che permetteva il transito dei componenti cinesi non è stato rinnovato in tempo. Risultato: container fermi, tempi indefiniti.
Ufficialmente, le ragioni sono “amministrative”. Ma ufficiosamente, si parla di pressioni discrete provenienti da Washington, preoccupata dall’espansione cinese in America Latina.
Gli Stati Uniti osservano da tempo con sospetto le infrastrutture scientifiche cinesi nel continente, considerate, nel linguaggio diplomatico, “a rischio dual use”: cioè potenzialmente utilizzabili tanto per la ricerca quanto per scopi strategici.
L’Argentina, stretta fra il debito con il Fondo Monetario e la necessità di non alienarsi l’appoggio di Pechino, ha scelto la strategia dell’attesa. Non un rifiuto, ma una pausa. Un modo elegante per non scontentare nessuno e scontentare tutti.
La nuova frontiera della competizione globale
CART non è solo un telescopio: è una metafora perfetta del mondo post-globale.
Negli anni Sessanta la competizione spaziale si misurava in razzi e bandiere sulla Luna. Oggi si gioca su tutt’altra scala: algoritmi, frequenze, centri dati, reti di osservazione condivisa.
Chi controlla i flussi scientifici, controlla il modo in cui il sapere viene generato e, spesso, anche come viene raccontato.
La Cina, negli ultimi anni, ha investito miliardi nella costruzione di infrastrutture scientifiche nei Paesi emergenti, con un obiettivo duplice: aprire nuovi canali di ricerca e disegnare un ecosistema alternativo a quello dominato dall’Occidente.
Gli Stati Uniti rispondono con programmi di “cooperazione trasparente”, fondi multilaterali e clausole di sicurezza.
Il risultato? Una scienza divisa in due orbite, che a parole resta universale, ma nei fatti si misura a colpi di sfiducia reciproca.
Buenos Aires, capitale di un equilibrio impossibile
Nel mezzo, c’è l’Argentina.
Un Paese che cerca investimenti, ma anche legittimità. Che ha bisogno della Cina, ma teme l’effetto collaterale del suo abbraccio.
Con un’economia fragile e una classe politica attraversata da fratture ideologiche, Buenos Aires deve negoziare ogni progetto come fosse un atto di bilanciamento.
Il telescopio CART, in questo contesto, è diventato una pedina strategica: un modo per misurare fino a che punto un Paese di medio peso può muoversi senza essere risucchiato dalle orbite delle superpotenze.
Eppure, per la comunità scientifica locale, il danno è tangibile: laboratori fermi, ricercatori in attesa, progetti sospesi.
Come spesso accade, la diplomazia lavora nel silenzio, ma il prezzo lo paga chi fa scienza.
Scienza sotto sequestro
Ogni ritardo ha un costo. Non solo economico.
La dogana che trattiene i pezzi del telescopio non è un semplice posto di confine: è il simbolo di una nuova frontiera del controllo politico sulla conoscenza.
La scienza, un tempo rifugio dell’universalismo, è diventata terreno di contesa. Arma bianca della competizione globale, spesso usata senza dichiararlo.
In un mondo che parla di “open data” e “collaborazione”, cresce il sospetto che ogni bit possa nascondere un codice strategico, ogni segnale un canale segreto.
E così, ciò che doveva ascoltare le stelle ora ascolta il rumore della politica.
Un rumore statico, pieno di interferenze.
CART come metafora del XXI secolo
Il destino del radiotelescopio sino-argentino va oltre i container di Buenos Aires. È una lezione su come la scienza non possa più vivere fuori dalla diplomazia e su quanto fragile sia il confine tra cooperazione e competizione.
Non è un’eccezione, ma un paradigma: il sapere globale è diventato territorio conteso e chi costruisce infrastrutture costruisce potere.
Il problema, però, non è solo geopolitico. È anche epistemico.
Perché quando la ricerca si frammenta lungo linee di alleanza, il rischio è che la scienza perda la sua funzione più nobile: essere il linguaggio comune dell’umanità.
CART non è solo un telescopio fermo: è una domanda aperta su come vogliamo o non vogliamo fare scienza nel mondo che viene.
Il silenzio delle stelle
Il telescopio CART doveva cercare nel buio tracce di luce antica, segnali lontani di stelle ormai spente.
Oggi è lui a essere spento.
Non per un guasto tecnico, ma per un cortocircuito politico.
Eppure, anche in questa sospensione, resta qualcosa di profondamente umano: la volontà di guardare oltre, nonostante tutto.
Forse, un giorno, quelle parabole di metallo torneranno a muoversi. Forse, dietro un gesto tecnico, un bullone serrato, una frequenza captata, si ricucirà un frammento di fiducia.
Perché la vera scommessa del XXI secolo non è chi costruirà il telescopio più grande, ma chi saprà guardare il cielo senza trasformarlo in un campo di battaglia.
Finché non capiremo questo, continueremo a perdere non solo dati o prestigio, ma la possibilità di essere una civiltà che ancora sa stupirsi del cielo.