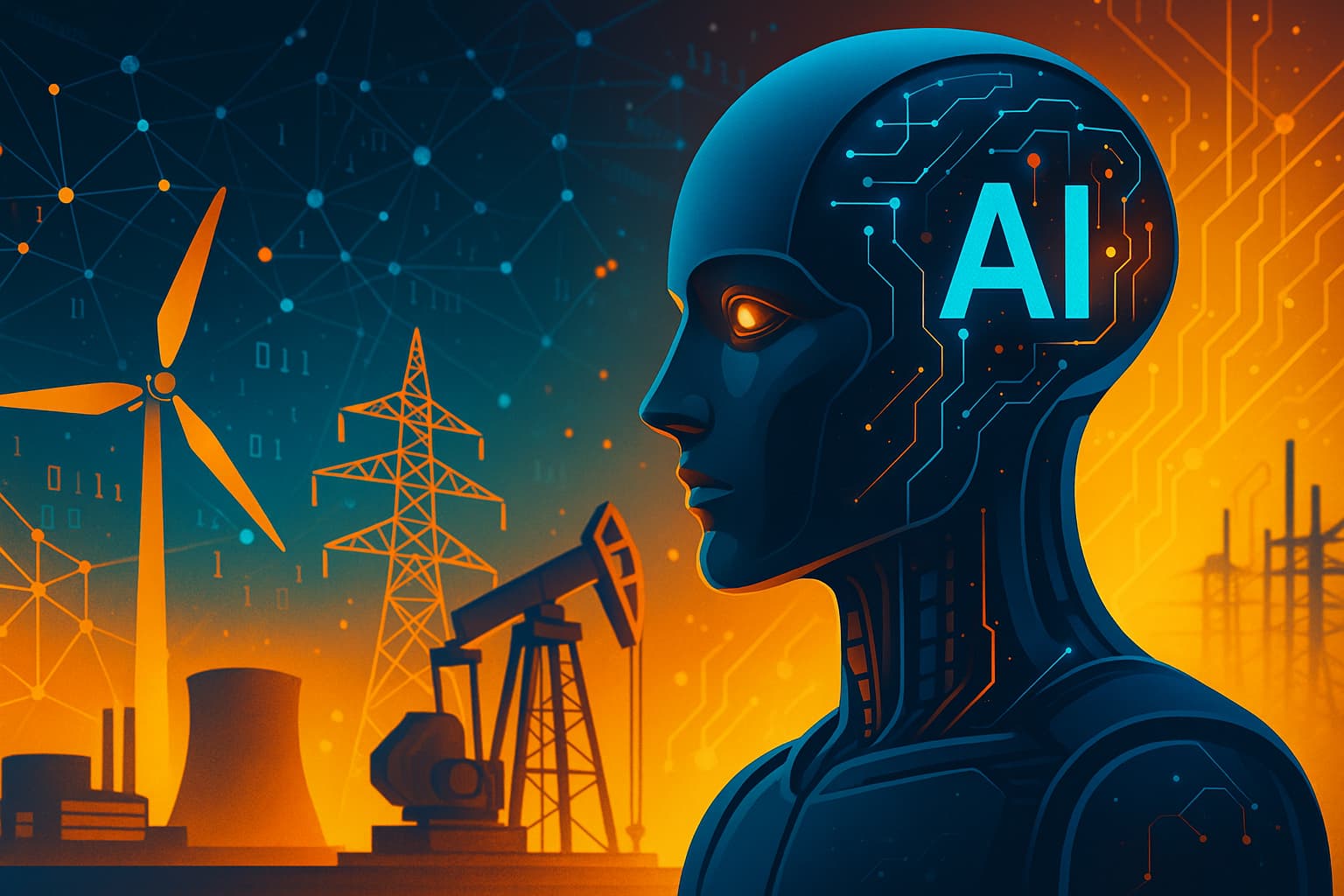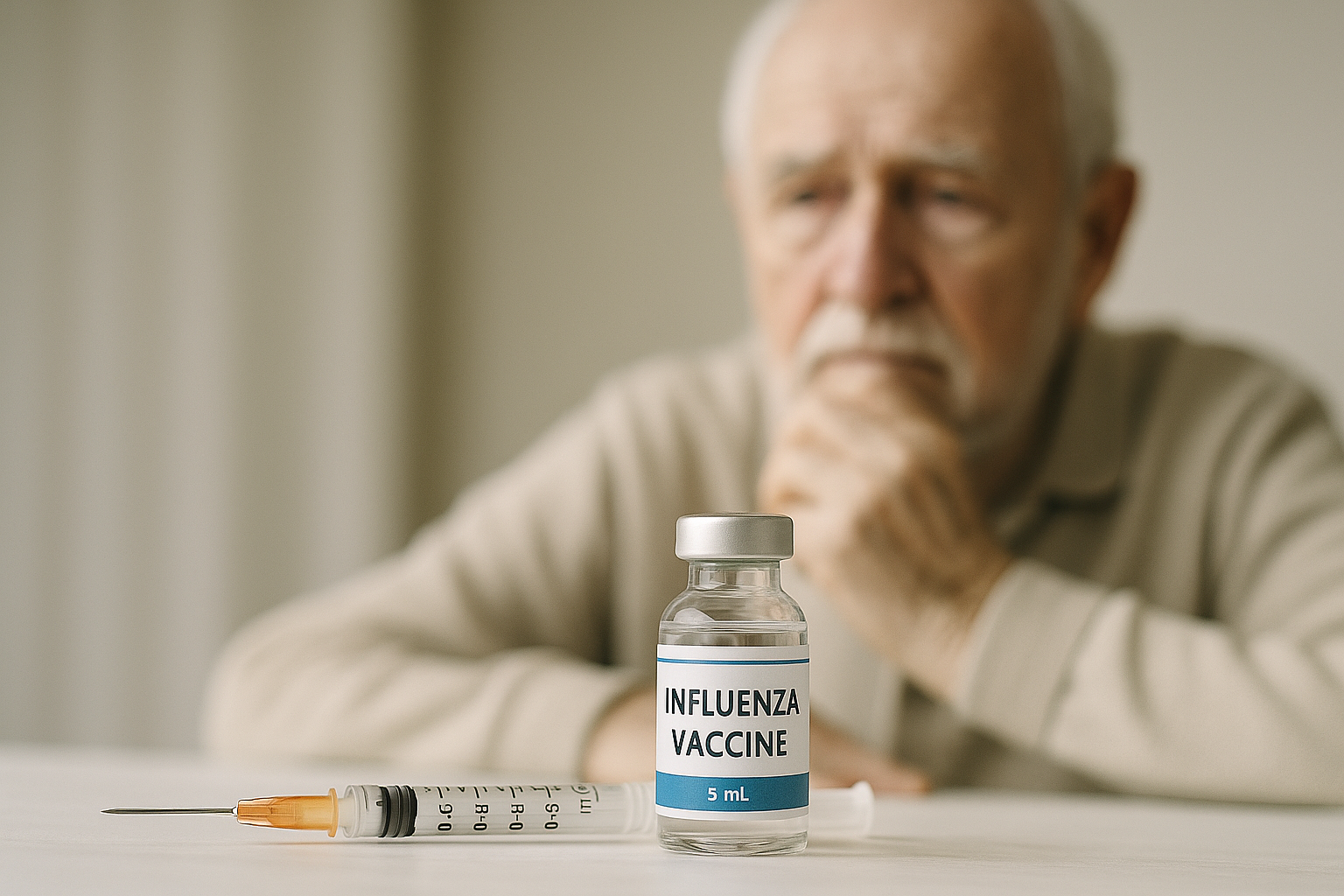La tregua Israele–Hamas riaccende i riflettori sul presidente USA, ma la decisione del Comitato norvegese è già chiusa: 338 candidature registrate (244 persone e 94 organizzazioni), scadenza al 31 gennaio e segretezza di 50 anni. Nel 2024 ha vinto Nihon Hidankyo, i sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki.
Un premio che arriva sempre “in ritardo”: cosa conta davvero per il 2025
Il Nobel per la Pace 2025 viene annunciato oggi, venerdì 10 ottobre, a Oslo. Non è una sorpresa che il nome di Donald Trump circoli con insistenza dopo il cessate il fuoco Israele–Hamas e il pacchetto di scambi di prigionieri: è l’inevitabile effetto di un risultato che, se reggerà, avrà peso storico. Ma il punto tecnico è un altro: la decisione è stata già presa nei giorni scorsi e le candidature valide sono quelle arrivate entro il 31 gennaio. La macchina del Nobel segue un calendario che non si piega all’attualità: mesi di screening, report indipendenti e deliberazione finale “a porte chiuse”.
I numeri (ufficiali) di quest’anno
Per il 2025, l’Istituto Nobel ha registrato 338 candidature: 244 individui e 94 organizzazioni. È un dato pubblico, a differenza dei nomi, che restano coperti da segreto per 50 anni secondo lo statuto della Fondazione. Il record di sempre resta il 2016 (376). Quest’anno, tra i “papabili” discussi dai media figurano corti internazionali, reti civiche in Paesi in guerra e — tra i nomi politicamente visibili — Trump. Che sia tra i candidati non lo conferma il Comitato (non lo fa mai), ma diverse nomination pubbliche sono state rese note da proponenti legittimati.
Trump e il dossier Gaza: cosa pesa (e cosa no)
Il recente cessate il fuoco tra Israele e Hamas — negoziato con un ruolo di Washington e rivendicato dalla Casa Bianca come tassello centrale — ha rilanciato la discussione su un possibile Nobel a Trump. A questo si aggiungono citazioni di mediazioni in altri dossier (Armenia–Azerbaigian) e nuove nomination annunciate da figure pubbliche, inclusi politici esteri. Ma, tecnicamente, le candidature sopraggiunte dopo il 31 gennaio contano per il 2026, non per il 2025; e la decisione 2025 è chiusa. Gli esperti interpellati dalle principali agenzie restano scettici su un suo successo immediato, pur riconoscendo che la tregua è un punto politico rilevante.
Chi può candidare e come funziona la selezione
Non serve alcun invito: possono proporre nomi parlamentari e ministri, giudici di corti internazionali, ex vincitori, direttori di centri studi sulla pace, docenti universitari di discipline affini. Dopo il 31 gennaio, il Comitato lavora su una shortlist con l’aiuto di consulenti accademici norvegesi e internazionali; i primi report arrivano in primavera e la decisione finale matura a inizio ottobre. La procedura è costruita per schermare la pressione mediatica e diplomatica; e per questo i dossier restano coperti per mezzo secolo.
Il precedente 2024: perché Nihon Hidankyo ha fatto scuola
Nel 2024 il premio è andato a Nihon Hidankyo, la confederazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. La motivazione ha sottolineato l’impegno per un mondo libero da armi nucleari e la forza della testimonianza diretta dei hibakusha. È un segnale forte su una linea di lungo periodo: il Comitato premia non solo chi “firma accordi”, ma anche chi sposta il pendolo morale del dibattito internazionale sui temi strutturali della pace (disarmo, diritti, istituzioni).
America e Nobel per la Pace: una relazione complicata
Gli Stati Uniti hanno ottenuto circa un decimo dei riconoscimenti individuali del secolo scorso, spesso tra controversie: da Theodore Roosevelt (1906) a Woodrow Wilson (1919), fino ai casi di Henry Kissinger (1973) e Barack Obama (2009). Alcuni premi sono stati letti come “messaggi” al potere di turno più che come rendiconti a consuntivo; altri, come quello a Jimmy Carter (2002), hanno valorizzato lavori umanitari e di mediazione a lungo raggio. Il punto: il Nobel per la Pace è sempre anche un atto pedagogico, un’indicazione di rotta.
Candidature “annunciate”: tra lobbying pubblico e realpolitik
La deputata statunitense Claudia Tenney ha reso pubbliche in passato candidature a favore di Trump per gli Accordi di Abramo (2024) e ha dichiarato di voler proseguire. Nelle ultime ore anche figure politiche estere hanno comunicato nomination, segno della valenza geopolitica del premio. Ma conviene ricordare due regole d’oro: 1) la pubblicità di una candidatura non la rende più forte; 2) il Comitato non commenta i nomi, né conferma né smentisce. Per il 2025, dunque, conta solo ciò che è stato formalmente registrato entro la scadenza.
Perché il Nobel “sbaglia” spesso… e perché serve comunque
Molti critici affermano che il premio arrivi troppo presto (premiando promesse più che risultati) o troppo tardi (canonizzando storie già scritte). Entrambe le cose sono in parte vere. Ma il suo scopo non è un audit ex post, bensì un incentivo: spostare risorse, attenzione e legittimità verso processi di pace ritenuti credibili e “contagiosi”. È un esercizio imperfetto, ma in un’epoca in cui i negoziati sono spesso spezzettati e invisibili, una piattaforma simbolica globale continua ad avere potere di agenda.
Cosa guardare nelle prossime ore (e nei prossimi mesi)
Tre nodi indicano la traiettoria:
- Durabilità della tregua Gaza–Israele e implementazione degli scambi
- Ruolo delle istituzioni internazionali (ICC, ICJ, reti civiche locali) nei conflitti “dimenticati”
- Narrativa del Comitato: se punterà su un risultato puntuale o su cause sistemiche (come il 2024).
Qualunque sia il vincitore 2025, la vera prova è il “day after”: quanta leva diplomatica e finanziaria il premio riuscirà a mobilitare sul terreno.
La pace come infrastruttura, non come evento
Il Nobel per la Pace non è una medaglia al collo di un singolo leader, è una leva d’influenza in un ecosistema frammentato. Che il nome sia un attivista, un’istituzione, una rete civica o un capo di Stato, la domanda resta la stessa: il premio sposta davvero i rapporti di forza a favore della pace? Se la risposta è sì, la polemica sul “chi” lascia il posto al “come”. È lì che si misura il valore del Nobel: nella capacità di trasformare un titolo in infrastruttura di dialogo — fondi, accesso, protezioni — capace di durare oltre il ciclo delle breaking news.