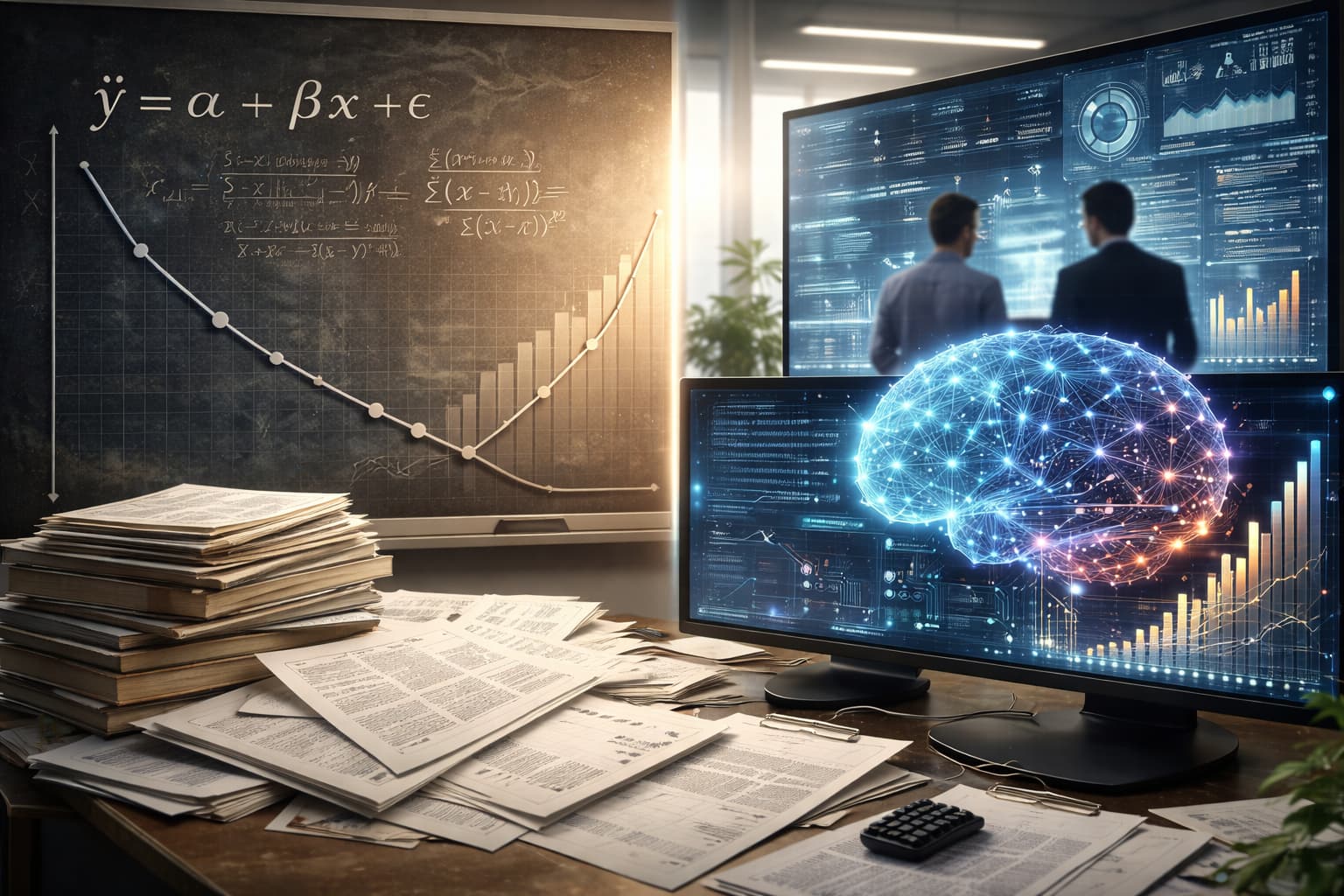La previsione sul PIL 2025 sale al 4,8% e avvicina l’obiettivo ufficiale di Pechino. Ma tra tregue tariffarie a scadenza, export “front-loaded”, immobiliare in affanno e disoccupazione giovanile in aumento, la sostenibilità del ciclo resta la vera posta in gioco.
Nel mezzo di un ciclo globale reso instabile da dazi, elezioni e riallineamenti strategici, la Cina sorprende: la Banca Mondiale alza la stima di crescita per il 2025 al 4,8%. È un segnale di resilienza che racconta un’economia capace di adattarsi e un apparato politico-amministrativo che sa distribuire stimoli mirati. Ma dietro il numero si vede un equilibrio sottile: domanda interna cauta, immobiliare fragile, minore spinta dalle esportazioni e un contesto geopolitico che normalizza l’eccezione tariffaria. La domanda per investitori, policy maker e imprese non è se la Cina crescerà nel 2025 — lo farà — ma a quale prezzo, e con quali basi per il 2026.
L’upgrade della Banca Mondiale: che cosa cambia davvero
La Banca Mondiale ha rivisto al rialzo la crescita cinese 2025 dal 4,0% al 4,8%, segnalando un miglioramento del quadro regionale e l’efficacia dei sostegni mirati varati da Pechino. Lo stesso rapporto indica, tuttavia, un raffreddamento nel 2026 al 4,2%, quando l’export perderà vigore e gli stimoli fiscali verranno sgonfiati per contenere il debito pubblico. Nel complesso, l’Est Asia e Pacifico è vista al 4,4% nel 2025. Numeri che non cambiano la struttura del ciclo, ma ne riallineano le aspettative.
L’obiettivo politico del 5% e la “qualità” della crescita
Pechino mantiene per il 2025 il target di crescita “intorno al 5%”. La distanza tra obiettivo politico e previsione multilaterale resta gestibile, ma impone coerenza nell’uso degli strumenti: stimolo selettivo alla domanda, disciplina sul credito, sostegno alle PMI innovative e gestione ordinata del real estate. La stessa Banca Mondiale, a giugno, invitava a spostare l’asse dagli investimenti pubblici ai consumi, segnalando i vincoli di produttività, demografia e debito. In altri termini: la quantità del PIL 2025 è credibile, la qualità dipenderà dalle riforme.
La tregua tariffaria USA-Cina: numeri, scadenze e ambiguità
Dopo l’escalation primaverile — con l’aumento dei dazi USA su tutti i beni cinesi fino all’84% e poi al 125% — Washington e Pechino hanno concordato a maggio una tregua di 90 giorni che ha ridotto i dazi al 30% (USA) e 10% (Cina), prorogata ad agosto per altri 90 giorni fino a metà novembre. È un cuscinetto temporaneo: senza un nuovo accordo, la minaccia di dazi a tre cifre resta sul tavolo. Alcune stime strutturali (media effettiva su base ampia) continuano a indicare livelli tariffari USA nell’ordine del 57,6%, a riprova di un contesto ormai “eccezionale” normalizzato. Per le filiere, ciò significa hedging permanente, ridisegno dei fornitori e investimenti logistici anti-shock.
Export e “front-loading”: resilienza o illusione contabile?
La tenuta dell’export 2025 è stata amplificata da un fenomeno ciclico: l’anticipo delle spedizioni (“front-loading”) prima delle scadenze tariffarie. La dinamica, ben documentata dai dati di primavera-estate, sostiene i volumi nel breve, ma prepara un fisiologico “payback” nei trimestri successivi, soprattutto nei comparti tech-electronics. È un paradosso di questa fase: l’extra-spinta commerciale migliora i numeri del 2025, ma sottrae crescita potenziale al 2026. Per il manifatturiero e la logistica, la priorità diventa spalmare ordini e scorte in modo più “antifragile”.
Indicatori domestici: consumi cauti e real estate in sofferenza
La domanda interna rimane il punto debole. Ad agosto le vendite al dettaglio sono salite del 3,4% a/a, sotto le attese, segnalando una propensione al risparmio ancora elevata. L’immobiliare continua a pesare: gli investimenti del settore sono scesi del 12,9% nei primi otto mesi, con prezzi in calo nella maggior parte delle città monitorate. Questi dati non invalidano il 4,8%, ma ne riducono i moltiplicatori: famiglie prudenti e patrimonio immobiliare in correzione frenano l’effetto dei trasferimenti fiscali.
L’effetto “Golden Week”: termometro dell’economia reale
La settimana di festa tra 1 e 8 ottobre ha mostrato segnali misti: record di traffico ferroviario nel primo giorno e volumi di viaggio molto elevati su tutta la finestra festiva, ma un quadro di spesa ancora da consolidare. Per policy e mercati il punto non è la quantità dei viaggi, ma la conversione in scontrini, margini e salari. Il turismo domestico “value for money” indica che l’elasticità al prezzo resta alta: un’economia che muove molto, ma spende con parsimonia.
Lavoro e coesione: il nodo generazionale
La disoccupazione tra i 16–24enni (esclusi gli studenti) è risalita in agosto al 18,9%, vicino ai massimi dall’introduzione della nuova metodologia. È un dato politicamente sensibile: un mercato che crea meno posti qualificati nei servizi avanzati e nel tech riduce il moltiplicatore dei redditi e incide sulla fiducia delle famiglie. Per attenuare il rischio sociale, le autorità stanno spingendo su assunzioni pubbliche, programmi di riqualificazione e canali di credito agevolato, ma senza una crescita robusta dell’occupazione privata la spesa delle famiglie resterà prudente.
Politica industriale: tra sovraccapacità, innovazione e diritto dell’innovazione
La strategia di Pechino resta centrata su semiconduttori, veicoli elettrici, rinnovabili, robotica e infrastrutture digitali. Tuttavia, la combinazione di vincoli all’export di tecnologie chiave, contestazioni per presunti sussidi distorsivi e controlli su investimenti esteri impone di affinare gli strumenti: IP robusta, standard aperti ma esigenti, governance dei dati e incentivi “a tempo” per evitare trappole di sovraccapacità e prezzi dumping-like sui mercati esteri. Qui il diritto dell’innovazione diventa politica economica: il perimetro legale fa la differenza tra leadership e overhang regolatorio.
Finanza pubblica e rischi sistemici: la gestione del debito conta più del PIL
La traiettoria 2026 al 4,2% sconta sia il venir meno degli stimoli sia i vincoli di bilancio di governi locali e LGFV. Il rischio sistemico non è l’insolvenza “evento”, ma l’erosione silenziosa della capacità di spesa pubblica e la compressione del credito al settore privato. Una normalizzazione ordinata richiede regole chiare su project finance, priorità d’investimento (capex “verdi” e digitali ad alta produttività) e mercati dei capitali più profondi per drenare risparmio verso impieghi produttivi.
Catene del valore in movimento: “friend-shoring” non è un sinonimo di de-globalizzazione
Le tariffe a geometria variabile accelerano la riallocazione: più Vietnam, India e ASEAN nell’arredo, nell’elettronica leggera e nella componentistica; più Europa come mercato di sbocco per alcuni comparti cinesi; più resilienza multi-hub per multinazionali che cercano ridondanza operativa. Non è il tramonto della globalizzazione, ma la sua riscrittura: meno efficienza pura, più robustezza. Per le aziende, la capacità di ribilanciare geografie e contratti è ora un vantaggio competitivo al pari del prezzo.
Che cosa osservare nei prossimi 12 mesi
Tre variabili guideranno la traiettoria: (1) l’esito della tregua tariffaria di metà novembre; (2) la profondità delle misure “pro-consumi” (fiscali e regolatorie) rispetto a nuovi piani di spesa in infrastrutture; (3) la gestione dell’immobiliare (ristrutturazioni, fusioni, inventario). In controluce, la capacità di creare occupazione privata qualificata nel digitale e nei servizi avanzati determinerà la qualità della crescita e la tenuta sociale.
Oltre il 2025, un test di credibilità
Il 4,8% è una vittoria tattica; la strategia si gioca sul come si cresce. Se il 2026 scenderà davvero al 4,2%, la differenza la faranno riforme “di qualità”: Stato che arretra dove pesa, mercato che avanza dove innova, regole chiare su concorrenza, dati e capitale, e un welfare che liberi i consumi. In un mondo frammentato, la Cina può “tenere banco” se trasforma il vantaggio di scala in vantaggio istituzionale. Altrimenti, la resilienza 2025 resterà una parentesi contabile in un decennio di crescita più lenta e diseguale.