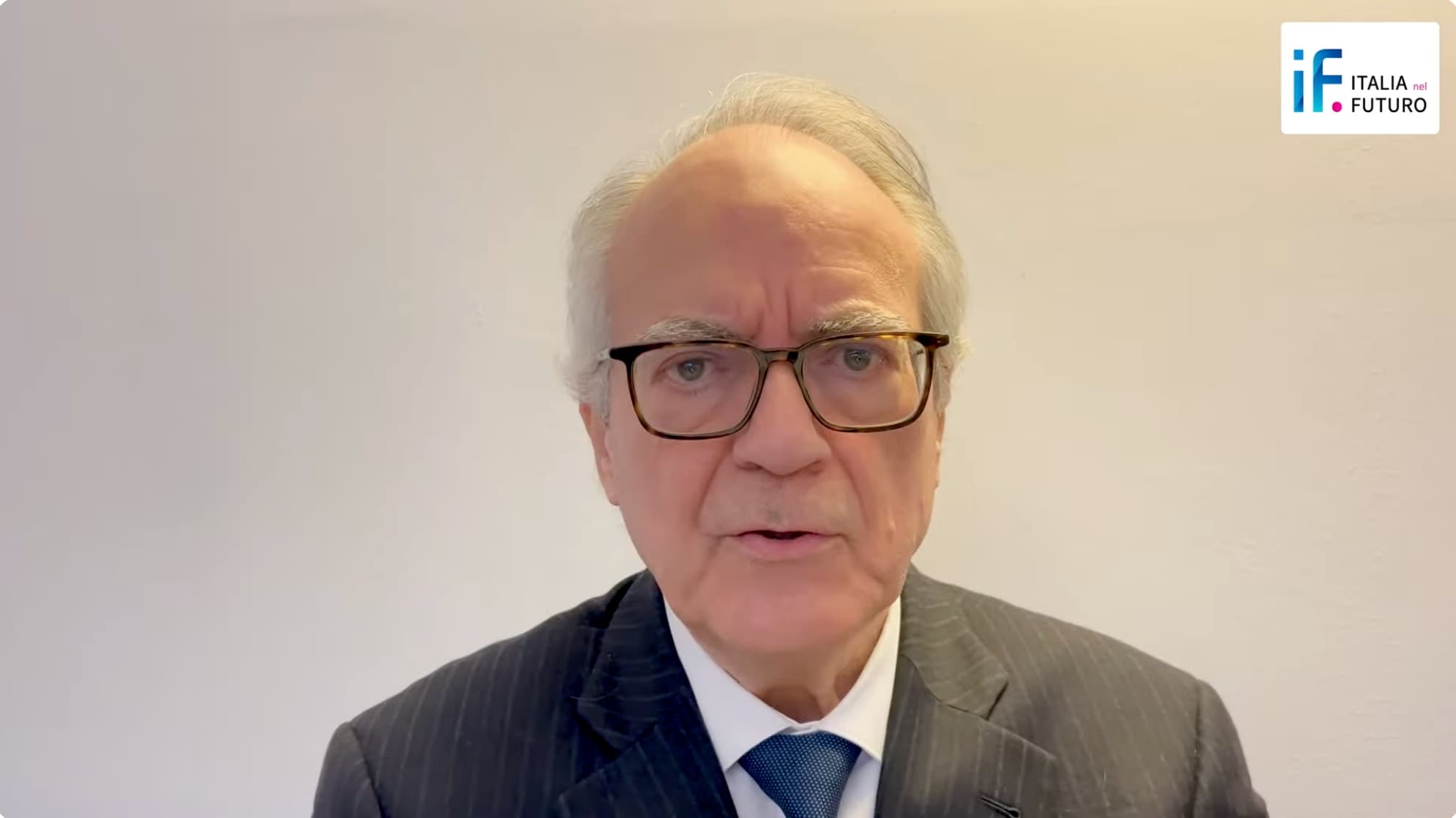Con un accordo da oltre un miliardo di dollari con Commonwealth Fusion Systems in Virginia, Eni accelera la trasformazione da oil major a energy tech company, investendo sulla tecnologia che potrebbe riscrivere il futuro dell’energia globale.
Un tempo simbolo dei combustibili fossili, oggi Eni si gioca la carta più ambiziosa della sua storia: scommettere oltre un miliardo di dollari sulla fusione nucleare. L’accordo con la startup americana CFS non è solo un contratto di fornitura, ma un segnale al mondo intero: la corsa alla nuova frontiera dell’energia è iniziata, e l’Italia non vuole restare a guardare.
La posta in gioco: dal petrolio al Sole
Per decenni Eni ha incarnato l’immagine della grande compagnia petrolifera italiana, con i suoi pozzi, i suoi oleodotti e le sue piattaforme sparse in mezzo al mare. Oggi, però, il colosso di San Donato Milanese cerca di cambiare pelle: non più solo una oil major, ma una energy tech company pronta a guidare la rivoluzione energetica.
La decisione di investire in un progetto che mira a replicare la fusione nucleare sulla Terra non è un dettaglio di comunicazione. È la dimostrazione di come Eni voglia giocarsi la sua reputazione e il suo futuro non più nel fossile, ma in una tecnologia che, se funzionerà, promette energia pulita, sicura e virtualmente inesauribile.
Perché la Virginia
Il progetto sorgerà in Chesterfield County, in Virginia, un territorio che sta diventando la capitale mondiale dei data center. Qui risiedono enormi infrastrutture digitali che consumano quantità impressionanti di elettricità per alimentare l’economia digitale e, soprattutto, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Non è un caso che Eni e CFS abbiano scelto proprio questa area: se la fusione riuscirà a diventare una realtà industriale, i primi clienti naturali saranno proprio i giganti tecnologici, sempre più ossessionati dal garantirsi forniture energetiche stabili e “carbon free”. In questo senso, la Virginia rappresenta un banco di prova globale: il luogo dove il sogno della fusione potrebbe trasformarsi in business.
La metamorfosi di Eni
Eni non è nuova alla fusione. Dal 2018 investe in Commonwealth Fusion Systems, convinta che questa tecnologia possa diventare la chiave per risolvere il dilemma energetico del XXI secolo: come produrre più energia senza aggravare la crisi climatica.
“Crediamo che la fusione sia un modo dirompente e fondamentale per affrontare i problemi energetici, sia sul fronte dei costi che su quello della sostenibilità”, ha dichiarato Lorenzo Fiorillo, direttore tecnologia e R&S di Eni. Dietro questa affermazione si nasconde una strategia precisa: posizionarsi tra i primi player globali in un settore che, se riuscirà a superare le sue sfide tecniche, potrebbe valere migliaia di miliardi nei prossimi decenni.
La scommessa CFS
Commonwealth Fusion Systems, nata come spin-off del MIT, è oggi una delle startup più finanziate al mondo nel settore della fusione: ha raccolto quasi 3 miliardi di dollari e nel giugno scorso ha firmato un contratto simile con Google, sempre legato al progetto ARC in Virginia.
Il suo approccio si basa sull’uso di magneti superconduttori ad alta temperatura, in grado di confinare il plasma necessario a innescare la reazione di fusione. Il CEO, Bob Mumgaard, ha riassunto così la fase attuale: “Non ci chiediamo più se la fusione funzionerà, ma quando e come riusciremo a portarla su scala industriale”.
È una dichiarazione che segna un cambio di paradigma: dalla ricerca di base alla prefigurazione di un mercato.
Una sfida scientifica ancora aperta
Ma il percorso non è privo di rischi. Ottenere la fusione su scala industriale significa raggiungere e mantenere il cosiddetto engineering break-even, ovvero produrre in modo stabile più energia di quanta ne serve per alimentare il processo.
Nel 2022 il Lawrence Livermore National Laboratory in California ha raggiunto per un istante il bilancio energetico positivo in un esperimento con i laser, ma trasformare quell’episodio in un sistema continuo e commercialmente competitivo è tutt’altra storia. La fusione resta ancora oggi un traguardo a metà tra scienza visionaria e ingegneria complessa.
Eppure, con investimenti miliardari da parte di aziende energetiche e big tech, il settore sembra aver varcato una soglia psicologica: non è più un sogno da laboratorio, ma una sfida industriale e geopolitica.
Geopolitica della fusione
La corsa alla fusione non riguarda solo la scienza, ma anche gli equilibri di potere globali. Stati Uniti, Europa, Cina, Giappone e Corea del Sud stanno investendo in progetti paralleli, con approcci diversi, ma con un obiettivo comune: diventare i primi a dominare la tecnologia più rivoluzionaria del secolo.
Per l’Italia, il ruolo di Eni in Virginia significa sedersi a un tavolo strategico dove si decide il futuro dell’energia. Per gli Stati Uniti, ospitare un progetto come ARC vuol dire non solo attrarre capitali e know-how, ma anche rafforzare la propria posizione come leader nella transizione energetica globale.
Il futuro sotto il segno del Sole
L’accordo tra Eni e CFS non è solo un’operazione industriale. È una dichiarazione di intenti: un colosso del petrolio che scommette la propria credibilità sulla possibilità di trasformare la fusione nucleare da sogno a realtà.
Il rischio è enorme: se la tecnologia dovesse rivelarsi troppo lenta o costosa, l’investimento potrebbe sembrare un azzardo. Ma se funzionerà, il passo compiuto da Eni sarà ricordato come un momento di svolta, il punto in cui l’energia del Sole ha iniziato a scendere sulla Terra.
La fusione non è ancora pronta per alimentare il mondo. Ma il fatto che aziende come Eni e Google siano disposte a impegnare miliardi di dollari è già di per sé un cambio di paradigma. Segno che il futuro dell’energia non si gioca più soltanto nei campi petroliferi o nelle miniere di carbone, ma nelle stanze dove si prova a domare la stessa forza che tiene accese le stelle.