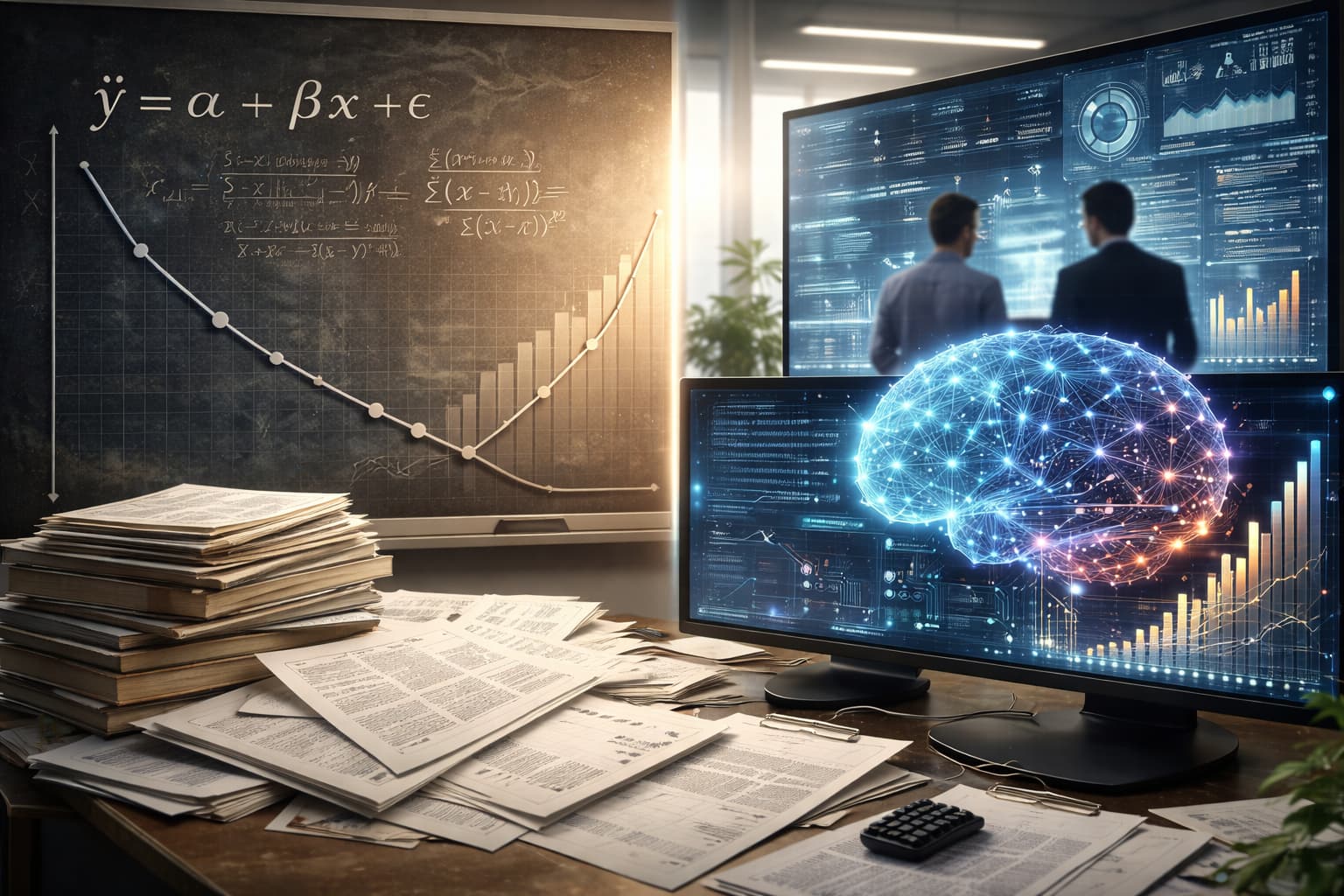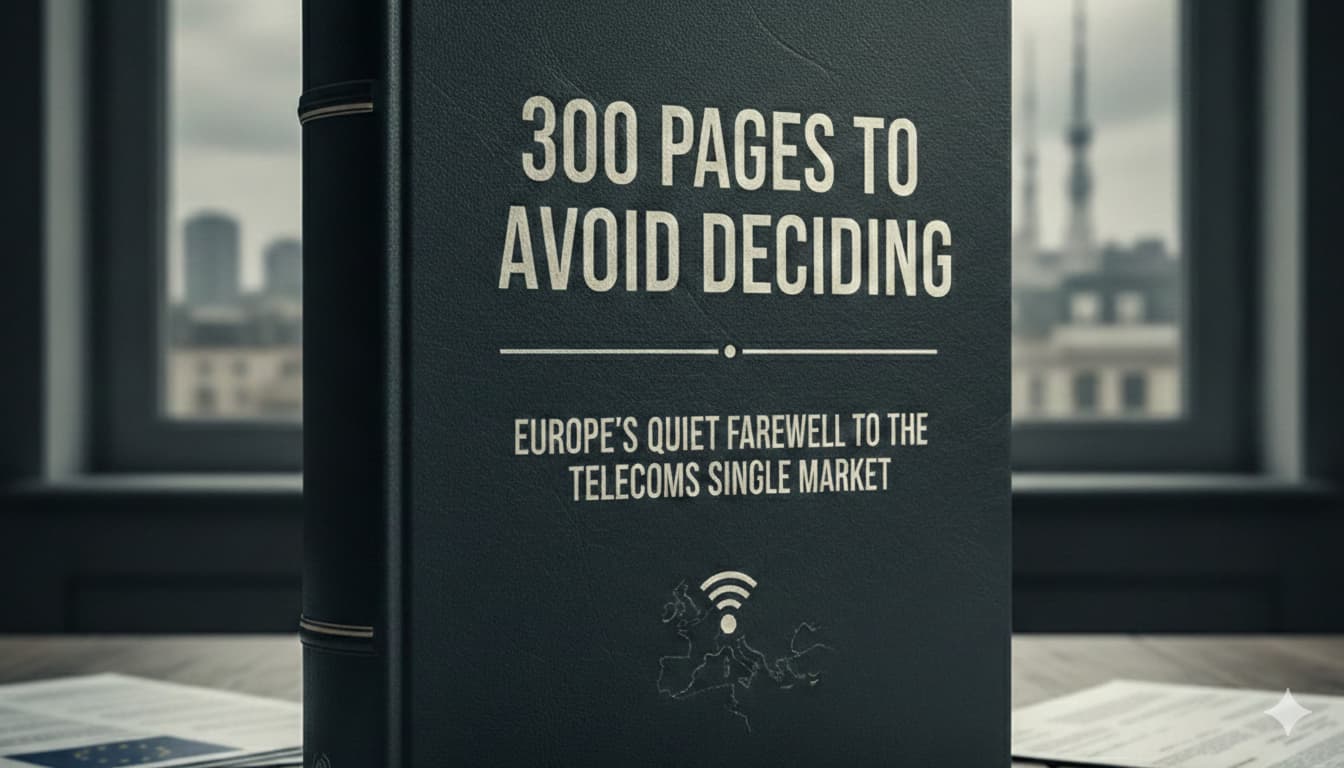Per la prima volta i 32 membri dell’Alleanza Atlantica rispettano l’impegno fissato nel 2014. Ma dietro i numeri restano squilibri, pressioni fiscali e la necessità di tradurre la spesa in capacità industriali, tecnologiche e militari in grado di rispondere a Russia e Cina.
Per la NATO il 2025 segna un passaggio storico: tutti i membri rispettano finalmente l’obiettivo del 2% del PIL in spese per la difesa, dopo anni di ritardi e polemiche transatlantiche. Ma dietro il successo numerico si cela un interrogativo cruciale: più risorse significano davvero più sicurezza? Con Russia e Cina in crescita e un’Europa chiamata a rafforzare la propria autonomia industriale, la sfida non è più raggiungere le percentuali, ma trasformarle in capacità concrete di deterrenza e risposta.
Dal 2014 al 2025: un obiettivo diventato obbligo
Quando nel 2014 la NATO fissò l’obiettivo del 2% del PIL da destinare alla difesa, molti Paesi europei lo considerarono un traguardo teorico, utile per placare le pressioni di Washington più che come impegno vincolante. All’epoca, solo pochi alleati rispettavano quel parametro; la maggioranza oscillava intorno all’1%, confidando nell’ombrello di sicurezza americano. L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha rappresentato un punto di svolta. L’idea che la guerra convenzionale fosse un fenomeno del passato è crollata in poche settimane, costringendo governi e opinioni pubbliche a riconsiderare la priorità della difesa.
Il 2025 segna, dunque, non solo un traguardo formale, ma un cambio di paradigma: la sicurezza europea è tornata a essere un bene pubblico da finanziare, anche a costo di sacrifici fiscali. Il dato che tutti i 32 membri abbiano raggiunto la soglia del 2% va letto come il segnale di una presa di coscienza collettiva, ma non cancella la disomogeneità nella qualità della spesa.
La spinta dell’Est: Polonia e Baltici come laboratori di deterrenza
I dati confermano che Polonia (4,48%), Lituania (4%) e Lettonia (3,73%) sono gli unici alleati a superare già oggi la nuova soglia del 3,5% fissata a L’Aia. Non sorprende: la vicinanza geografica alla Russia e la memoria storica di dominazioni passate hanno trasformato questi Paesi in avanguardie del riarmo. Varsavia, in particolare, ha avviato un piano di modernizzazione senza precedenti, puntando non solo sugli acquisti da partner come Stati Uniti e Corea del Sud, ma anche sulla ricostruzione di una propria base industriale militare.
Questo modello riflette una convinzione strategica: per i Paesi dell’Est la deterrenza non è concetto astratto, ma esigenza esistenziale. In prospettiva, il loro attivismo potrebbe ridisegnare i rapporti di forza all’interno della NATO, spostando il baricentro della sicurezza europea verso Est, con implicazioni politiche e industriali di vasta portata.
Oltre le cifre: il monito di Mark Rutte
Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sintetizzato il nodo cruciale: “I soldi da soli non garantiscono sicurezza”. La frase, pronunciata all’inaugurazione di una fabbrica Rheinmetall di munizioni in Germania, tocca un nervo scoperto. Se è vero che l’aumento delle spese è una condizione necessaria, non è affatto sufficiente. La deterrenza si misura nella capacità effettiva di produrre armi, mantenere scorte, garantire interoperabilità e mobilitare forze in tempi rapidi.
La guerra in Ucraina ha dimostrato che il problema non è solo di budget, ma di resilienza logistica e capacità industriale. Molti Paesi europei hanno scoperto di non avere riserve sufficienti di munizioni o linee produttive scalabili. Il rischio, dunque, è che l’aumento dei bilanci resti sterile se non si accompagna a una vera politica industriale della difesa, coordinata a livello transnazionale.
Difesa e politica industriale: verso una “NATO economy”?
Il passaggio da spesa a capacità richiede un salto qualitativo nella governance industriale. La NATO, storicamente alleanza militare, è chiamata a trasformarsi anche in piattaforma di coordinamento economico-industriale. L’obiettivo del 5% del PIL entro il 2035 (ndr “almeno il 3,5% del Pil” per le spesa della difesa entro il 2035, “per finanziare i requisiti fondamentali della difesa e per soddisfare gli obiettivi di capacità della Nato” e l’1,5% del Pil per le spese più generali di sicurezza) , che comprende infrastrutture dual use, cybersecurity e logistica, apre un mercato immenso per il settore privato. Strade, porti, ferrovie e reti digitali diventano asset di sicurezza collettiva.
Il problema, però, è la frammentazione: l’Europa conta decine di sistemi d’arma duplicati, prodotti da industrie nazionali in concorrenza tra loro. Senza standardizzazione, i costi aumentano e l’interoperabilità si riduce. Il futuro dipenderà dalla capacità di integrare le catene di fornitura, armonizzare le gare d’appalto e creare un ecosistema che bilanci sovranità nazionale e efficienza collettiva.
La sostenibilità economica e finanziaria
Il 2% del PIL è diventato realtà, ma non senza conseguenze sui bilanci pubblici. Per Paesi come Polonia o Lituania, superare il 4% significa allocare risorse enormi, sottraendole ad altri capitoli di spesa. Se nel breve termine il riarmo genera occupazione e stimola l’innovazione tecnologica, nel medio periodo pone interrogativi sulla sostenibilità fiscale e sulla compatibilità con le politiche sociali e climatiche.
Dal punto di vista finanziario, il rispetto del 2% riduce le tensioni transatlantiche e soddisfa le richieste americane. Ma l’effetto sugli investitori dipenderà dalla capacità di trasformare la spesa in ritorni strategici. I mercati osservano: se la difesa diventa un driver strutturale dell’economia occidentale, ci sarà un riallineamento degli investimenti verso il comparto militare-industriale, con implicazioni per tutto l’indotto.
La cornice giuridica e il diritto dell’innovazione
L’espansione delle spese militari apre un fronte giuridico delicato. L’uso crescente di intelligenza artificiale, droni autonomi e armi cibernetiche impone di ridefinire i limiti del diritto bellico e del diritto dell’innovazione. Qual è la responsabilità legale in caso di errore di un sistema autonomo? Chi detiene la proprietà intellettuale degli algoritmi utilizzati in contesti bellici? Come garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario in un contesto tecnologicamente ibrido?
La NATO dovrà non solo rafforzare la cooperazione militare, ma anche promuovere un quadro normativo transnazionale che bilanci necessità operative e principi etici. Il rischio, altrimenti, è una corsa agli armamenti tecnologici priva di regole, con conseguenze imprevedibili.
Dietro l’apparente unita’ restano tensioni
La convergenza sul 2% manda un messaggio chiaro a Mosca: l’Alleanza è compatta e determinata. Ma dietro l’apparente unità restano tensioni. Gli Stati Uniti continuano a sostenere la quota maggiore delle capacità militari, mentre i Paesi europei faticano a emanciparsi dal supporto americano. Il nuovo obiettivo del 3,5% e del 5% al 2035 è ambizioso , ma presuppone un consenso politico interno che non è scontato.
Le opinioni pubbliche europee sono divise: se in Polonia o nei Paesi baltici il riarmo è percepito come necessità vitale, in altre nazioni prevalgono preoccupazioni per il welfare e la transizione ecologica. La sfida politica della NATO sarà dunque mantenere coesione interna mentre cresce la pressione esterna, in un contesto globale sempre più instabile e multipolare.
Un futuro di sicurezza condivisa ma non scontata
Il traguardo del 2025 segna un momento storico per la NATO, ma è solo l’inizio di una fase nuova. La vera domanda è se l’Alleanza saprà trasformare percentuali di PIL in capacità operative, coesione politica e innovazione tecnologica. In caso contrario, il rischio è che i numeri restino simbolici e che la deterrenza si riveli fragile di fronte a crisi reali.
La sfida dei prossimi dieci anni sarà quindi duplice: industrializzare la difesa europea per ridurre dipendenze critiche e, allo stesso tempo, preservare il consenso politico interno, evitando che l’aumento delle spese diventi terreno di divisione. Il futuro della NATO dipenderà dalla capacità di dimostrare che più spesa significa davvero più sicurezza.