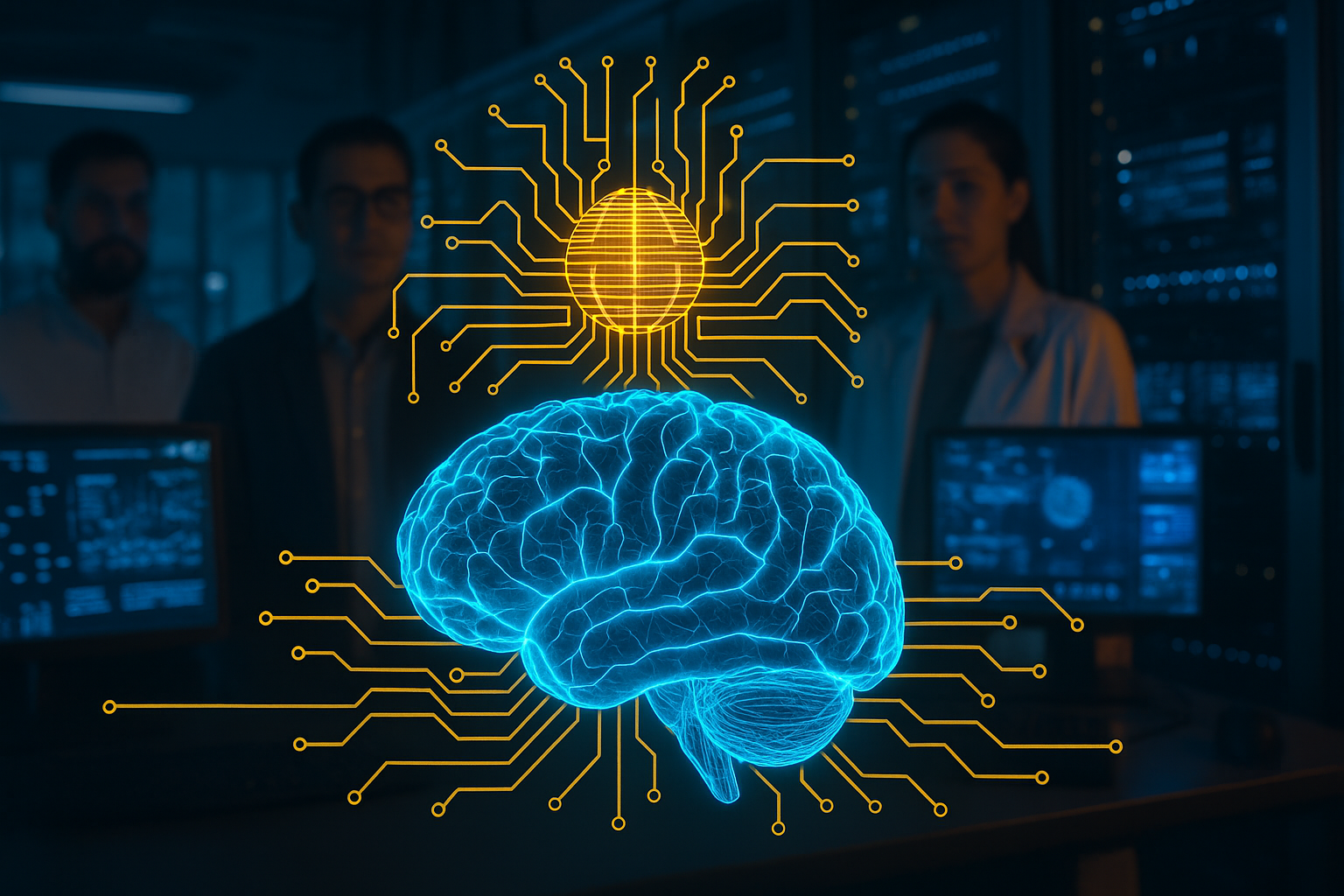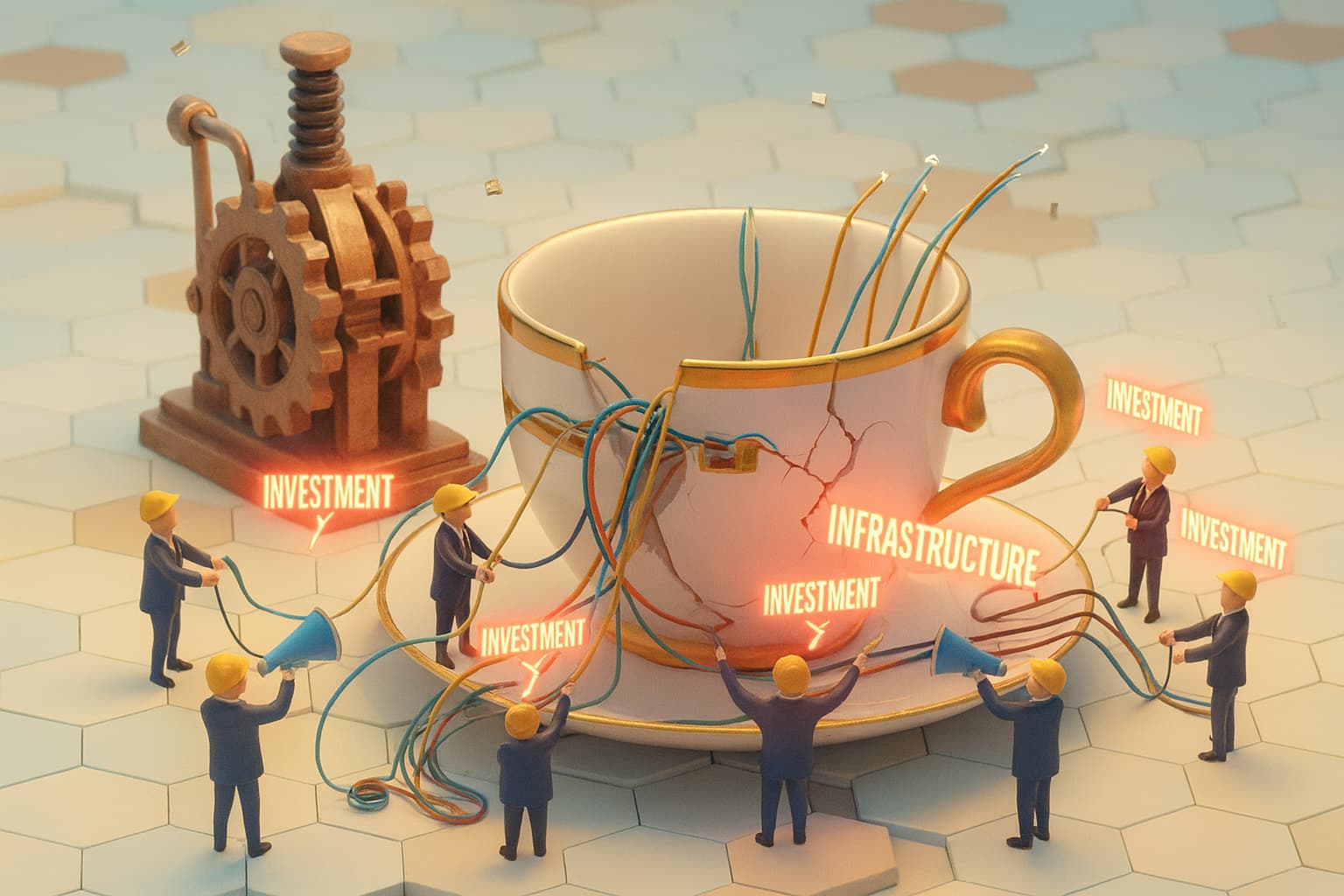Negli ultimi giorni una notizia ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo: un team cinese guidato dal professor Pan Jianwei, grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è riuscito a ordinare oltre duemila atomi in appena sessanta millisecondi, costruendo quello che è stato definito il “cervello” di un computer quantistico (fonte: The Quantum Insider).
Non si tratta soltanto di un traguardo tecnico, ma di un segnale di straordinaria portata, che ci invita a riflettere su come l’umanità stia spingendo il limite della conoscenza a una velocità che rischia di superare la propria capacità di governarla. La promessa contenuta in questa conquista è enorme: l’unione tra IA e tecnologie quantistiche potrebbe permettere di affrontare problemi oggi considerati insormontabili. Computer in grado di risolvere calcoli che richiederebbero secoli in pochi secondi aprirebbero frontiere inedite nella medicina, nella chimica, nella ricerca di nuovi materiali e nell’ottimizzazione delle energie rinnovabili. Sarebbe possibile simulare fenomeni complessi, dal funzionamento del corpo umano al comportamento del clima, e individuare soluzioni a crisi globali che appaiono altrimenti inaccessibili.
L’immagine di un “cervello artificiale” che sa ordinare il caos invisibile della materia diventa metafora potente della capacità dell’uomo di trasferire fuori da sé un’intelligenza che sappia ampliare il raggio del pensiero e della progettazione. Ma ogni luce porta inevitabilmente con sé la propria ombra. La stessa potenza che promette progresso cela rischi sistemici che non possono essere ignorati. Un computer quantistico potrebbe mettere fine in poco tempo alla sicurezza informatica su cui oggi poggiano banche, governi, sistemi di comunicazione, rendendo obsolete le chiavi crittografiche che proteggono dati e transazioni.
Sul piano geopolitico, questa rivoluzione rischia di tradursi in una corsa al predominio tecnologico, in cui la ricerca di supremazia prevale sulla cooperazione internazionale e la conoscenza diventa arma di potere.
Ancora più insidioso è il divario tra la rapidità dello sviluppo tecnico e la lentezza con cui maturano l’etica, il diritto, la consapevolezza collettiva. Non è la macchina in sé a essere pericolosa, così come non lo sono stati il fuoco o l’elettricità, ma l’uso che l’uomo sceglie di farne. Il vero pericolo risiede nello squilibrio fra la capacità di costruire e quella di governare ciò che si è costruito.
Guardando a questa notizia, non si coglie soltanto l’aspetto scientifico: ciò che emerge è il tentativo dell’umanità di generare un cervello esterno a sé, un riflesso della propria mente, che assume i tratti di una ricerca antropologica e persino spirituale. È come se l’uomo cercasse di estendere la propria intelligenza al di fuori dei limiti biologici, nella speranza di intravedere nuove forme di conoscenza. Ma senza un ancoraggio a principi condivisi, questo slancio rischia di generare alienazione, dominio e disuguaglianza. Per questo diventa indispensabile riportare etica e responsabilità al centro del dibattito. Non possiamo lasciare che l’unione tra IA e quantistica diventi il terreno di nuove egemonie, né che venga ridotta a strumento di potere.
È necessario orientarla a obiettivi di cura, di cooperazione, di conoscenza comune. La domanda decisiva non è più se questa rivoluzione avverrà, ma come decideremo di viverla. Il “cervello quantistico” creato dall’intelligenza artificiale ci mostra quanto siamo vicini a strumenti capaci di cambiare radicalmente il mondo: ciò che resta aperto è la scelta se utilizzarli per illuminare il cammino o per alimentare il fuoco che rischia di bruciarci.
La corsa al cervello quantistico: potere globale e fragilità umana
 Giovanni Di Trapani
Giovanni Di Trapani