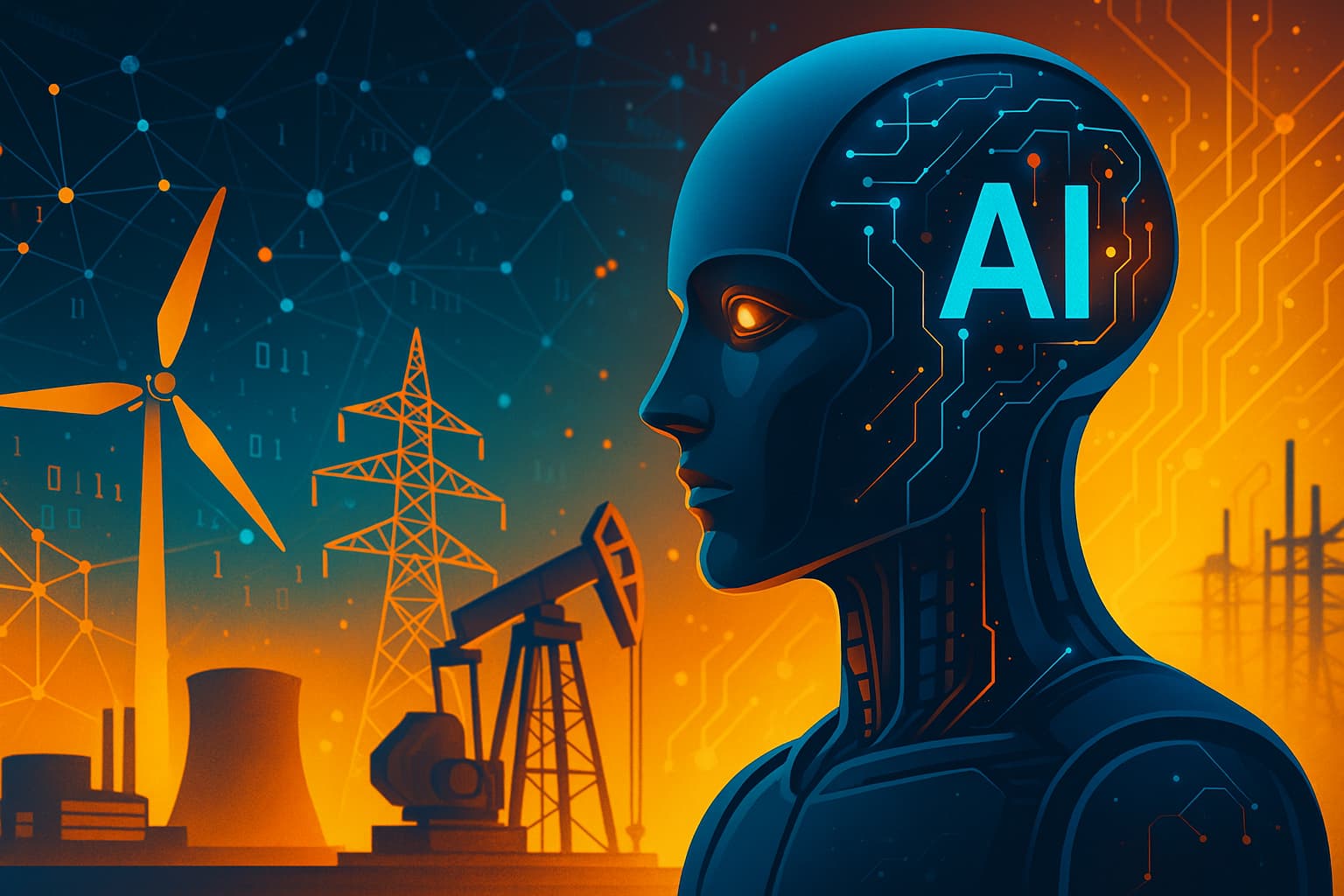Tra benefit, indennità e ruoli di vertice, ecco come si compone la struttura retributiva dell’Unione Europea. Il dibattito sul Pfizergate riaccende l’attenzione su trasparenza, governance e accountability.
La recente mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen, presentata a seguito delle polemiche legate al cosiddetto Pfizergate, ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema delle retribuzioni dei vertici istituzionali dell’Unione Europea. Il focus non riguarda solo gli stipendi in sé, ma anche il rapporto tra compensi, responsabilità pubbliche e trasparenza decisionale in ambito europeo.
La presidente della Commissione: 40.986 euro lordi mensili tra salario e indennità
Secondo quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/300, la retribuzione base della presidente della Commissione Europea è fissata al 138% dello stipendio massimo di un funzionario europeo. Per il 2025, questo si traduce in 34.407 euro lordi al mese, a cui si aggiungono un’indennità di residenza (5.161 euro) e una di rappresentanza (1.418 euro), per un totale mensile pari a 40.986 euro lordi.
Questa cifra la posiziona come la più retribuita tra le figure apicali dell’architettura europea. Si tratta di un compenso che riflette la centralità strategica e operativa della Commissione nella gestione delle politiche comuni, dalla sanità pubblica al mercato interno.
Il contesto politico: il caso Pfizergate e la questione della trasparenza istituzionale
Il Pfizergate nasce da uno scambio di messaggi privati tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla, CEO di Pfizer, durante la fase di negoziazione per l’acquisto dei vaccini anti-Covid. Tali comunicazioni, secondo la Commissione, non rientravano nell’ambito dei documenti ufficiali. Tuttavia, la Corte di Giustizia dell’UE ha stabilito che andavano almeno conservati, in base ai criteri di trasparenza amministrativa previsti dai Trattati.
La vicenda ha riacceso il dibattito su accountability, lobbying e gestione delle trattative extragiudiziarie nell’ambito della politica industriale e sanitaria europea, in un momento in cui la Commissione è chiamata a guidare la transizione strategica su temi come sicurezza digitale, difesa e reshoring produttivo.
I vertici della Commissione: chi guadagna cosa
Dopo la presidente, i compensi più elevati vanno agli Alti Rappresentanti e Vicepresidenti esecutivi. È il caso di Kaja Kallas, attuale Alto Rappresentante per gli Affari Esteri, che percepisce 32.424 euro lordi al mese, mentre i Vicepresidenti – come Teresa Ribera e Stéphane Séjourné – arrivano a 31.177 euro.
I Commissari europei ordinari, tra cui Raffaele Fitto per l’Italia, guadagnano 28.057 euro lordi mensili, la stessa cifra spettante anche al Segretario Generale del Consiglio UE e ai giudici della Corte di Giustizia. La struttura retributiva rispecchia il principio di proporzionalità tra responsabilità funzionali e ruolo istituzionale all’interno del sistema a geometria multilivello dell’Unione.
Charles Michel: lo stesso stipendio base, ma meno benefit rispetto alla Commissione
Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, percepisce uno stipendio base identico a quello di von der Leyen (34.407 euro), ma senza le indennità accessorie che spettano al presidente della Commissione. La differenza, tutt’altro che simbolica, riflette le diverse funzioni previste dal Trattato di Lisbona: esecutive e negoziali per la Commissione, di indirizzo e rappresentanza per il Consiglio.
Gli europarlamentari: fino a 19.662 euro lordi al mese tra stipendio, indennità e missioni
Gli eurodeputati ricevono uno stipendio base lordo di 10.337 euro mensili, che scende tra 8.090 e 8.933 euro netti a seconda del regime fiscale nazionale. A questo si aggiunge un’indennità per le spese generali di 4.950 euro e una diaria di 350 euro al giorno per le giornate di presenza in Parlamento, fino a circa 4.375 euro mensili. Il totale può così raggiungere un valore medio lordo di 19.662 euro al mese.
Oltre al dato numerico, va rilevato come questi compensi includano l’intera operatività dell’attività legislativa europea, dalla partecipazione alle commissioni fino alla rappresentanza esterna nei triloghi e nei forum internazionali.
I funzionari di carriera: una struttura retributiva fondata su merito e anzianità
I funzionari UE, inquadrati nei livelli da AD5 a AD16, costituiscono la spina dorsale tecnico-amministrativa dell’Unione. Un AD5 (livello di ingresso) percepisce 5.670 euro lordi mensili, mentre un AD14 (livello medio-alto) può arrivare a 13.322 euro. I dirigenti apicali (AD16) ricevono tra 17.054 e 24.942 euro lordi a seconda dell’anzianità.
Questi funzionari sono responsabili di dossier legislativi, policy brief, studi d’impatto, analisi giuridiche e relazioni interistituzionali. La struttura retributiva riflette una logica comparabile ai sistemi di carriera pubblica di tipo europeo-continentale, con elementi di progressività e meritocrazia.
Assistenti e Contract Agents: il motore invisibile dell’amministrazione europea
Gli assistenti amministrativi partono da una retribuzione mensile lorda di 3.645 euro, gestendo compiti operativi, documentali e logistici. I Contract Agents, personale a contratto a termine, hanno una retribuzione che va da 3.624 euro a 7.602 euro lordi al mese, a seconda del grado e dell’esperienza.
In molti casi, questi professionisti coprono attività strategiche, come la redazione di proposte legislative, l’analisi economica, la comunicazione istituzionale o il supporto giuridico. La crescente esternalizzazione di ruoli strategici verso questi profili solleva interrogativi anche sul fronte della stabilità occupazionale e continuità amministrativa.
Un sistema sotto osservazione: trasparenza e sostenibilità nel lungo termine
Il tema delle retribuzioni dell’élite amministrativa e politica dell’UE assume una rilevanza crescente nel contesto della governance multilivello europea. In un momento storico segnato da sfide complesse – digitalizzazione, difesa comune, transizione verde, inflazione – la questione non è solo quanto si guadagna, ma come si giustifica il compenso pubblico rispetto all’impatto, alla trasparenza e al controllo democratico dell’azione istituzionale.
L’episodio del Pfizergate dimostra quanto sia fragile l’equilibrio tra efficacia negoziale e trasparenza. E riapre il dibattito su etica pubblica, lobbying e accesso ai documenti, questioni centrali in ogni riforma ambiziosa delle istituzioni europee.