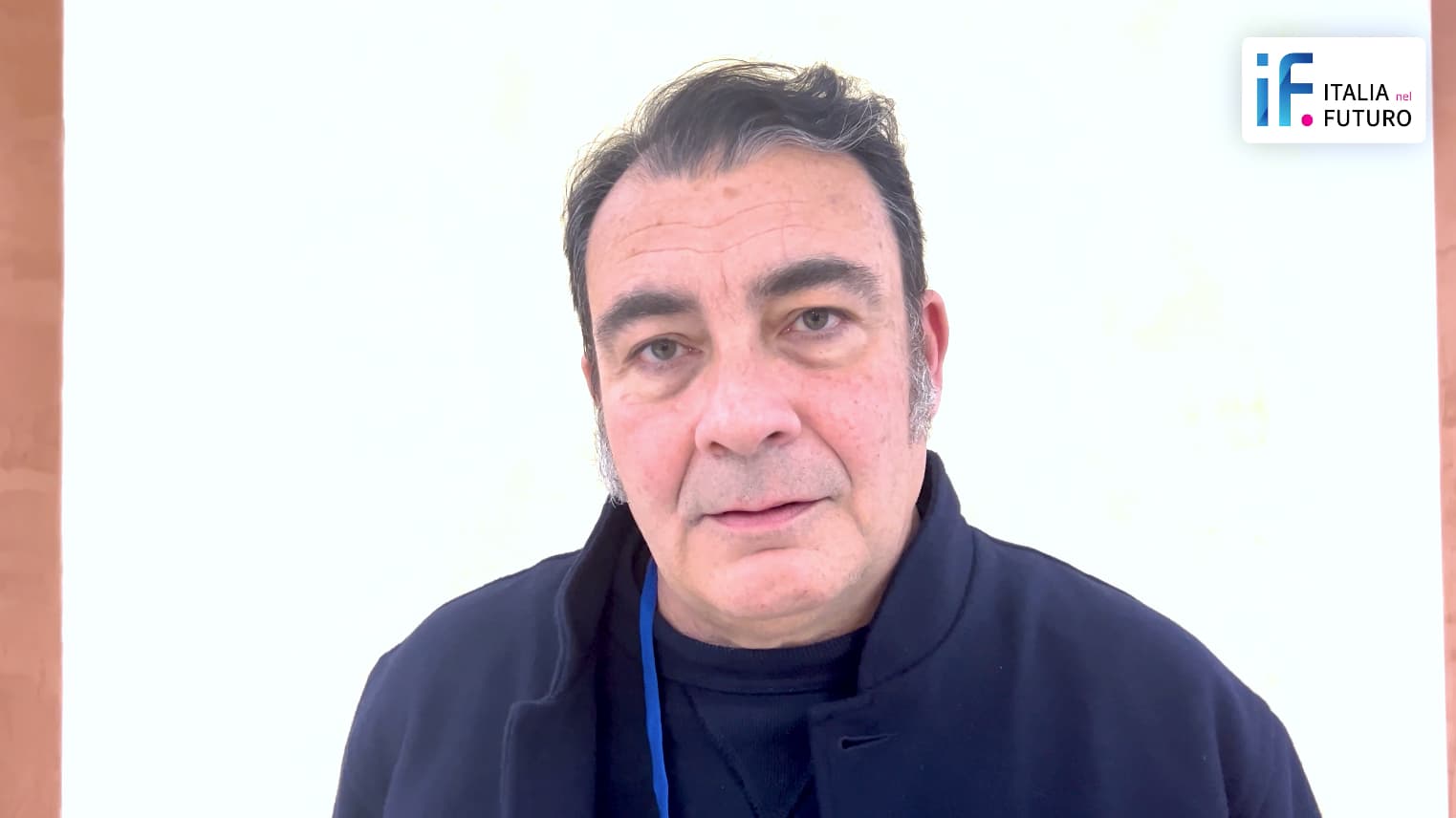L’Europarlamento introduce soglie minime e semplificazioni al meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (CBAM), esentando i piccoli importatori e posticipando al 2027 la vendita dei permessi. Una svolta normativa che alleggerisce gli oneri amministrativi senza indebolire l’impatto ambientale della misura.
Con un voto atteso e strategico, il Parlamento europeo ha approvato le modifiche al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), lo strumento centrale del Green Deal per allineare la concorrenza internazionale agli standard climatici europei.
Tra le novità principali:
- Esenzione per chi importa meno di 50 tonnellate annue di beni soggetti a CBAM
- Slittamento al 2027 dell’inizio della vendita dei permessi di emissione
- Conferma della piena operatività del meccanismo per i grandi importatori dal 2026
Queste modifiche, proposte dalla Commissione europea a febbraio 2025, mirano a ridurre la complessità burocratica per oltre il 90% degli operatori economici interessati.
Impatto normativo: meno obblighi per la maggioranza, stessa pressione sui principali emettitori
Sebbene oltre il 90% degli importatori sarà escluso dagli obblighi, la Commissione ha sottolineato che il 10% restante copre il 99% delle emissioni associate alle merci importate nei settori ad alta intensità carbonica: acciaio, cemento, alluminio, fertilizzanti.
Il principio guida resta quello della equivalenza regolatoria: i prodotti importati da paesi con regolamentazioni ambientali meno stringenti dovranno affrontare un onere simile a quello sostenuto dai produttori UE nell’ambito del Sistema di Scambio delle Emissioni (ETS).
Il nuovo sistema sostituisce le regole precedenti, secondo cui qualunque entità che importasse beni coperti da CBAM per un valore superiore a 150 euro sarebbe stata soggetta alla tassa.
Una risposta industriale alla concorrenza climatica globale
Il CBAM nasce con una duplice finalità:
- Evitare la delocalizzazione delle emissioni (“carbon leakage”), impedendo alle imprese europee di trasferire la produzione in paesi con minori vincoli ambientali
- Difendere la competitività dell’industria UE, che già internalizza il costo del carbonio.
In questo contesto, il meccanismo rappresenta una risposta indiretta anche alle politiche ambientali più permissive promosse da alcuni partner commerciali, in primis gli Stati Uniti, dove l’amministrazione Trump sta smantellando diverse normative federali sul clima.
Tempistiche e prossimi passaggi istituzionali
Dopo il voto dell’Europarlamento, la proposta sarà esaminata dal Consiglio dell’Unione Europea. Secondo fonti diplomatiche, gli Stati membri sostengono le esenzioni e il trilogo con la Commissione e il Parlamento potrebbe portare all’approvazione definitiva già nel secondo semestre 2025.
Il calendario aggiornato:
- 2026: entrata in vigore dell’obbligo di acquisto dei permessi CBAM per i grandi importatori
- 2027: inizio delle aste pubbliche per l’acquisto di quote CBAM
Riflessi economici e strategici: industria, commercio e finanza del carbonio
L’evoluzione del CBAM ha implicazioni trasversali per:
- Le imprese industriali europee, che vedranno un miglior bilanciamento competitivo tra produzione interna e importazioni
- Le PMI importatrici, ora escluse dal perimetro regolatorio per via delle basse soglie quantitative
- I mercati del carbonio, che dovranno adeguare i propri strumenti di pricing al nuovo flusso di domanda generato dalle importazioni coperte
A livello giuridico, la riforma rafforza il principio di “non discriminazione ambientale” e potrebbe generare contenziosi commerciali presso l’OMC, specie con paesi esportatori colpiti come Cina, India e Turchia.
Il CBAM diventa più efficiente senza perdere forza
La decisione del Parlamento UE rappresenta un esempio virtuoso di semplificazione normativa con mantenimento dell’efficacia ambientale.
Escludere operatori marginali consente di concentrare gli sforzi amministrativi e di enforcement su pochi soggetti ad alto impatto, senza alterare gli obiettivi climatici dell’Unione.
Il Carbon Border Adjustment Mechanism si conferma un dispositivo centrale per la diplomazia climatica europea e per la transizione giusta dell’industria continentale.