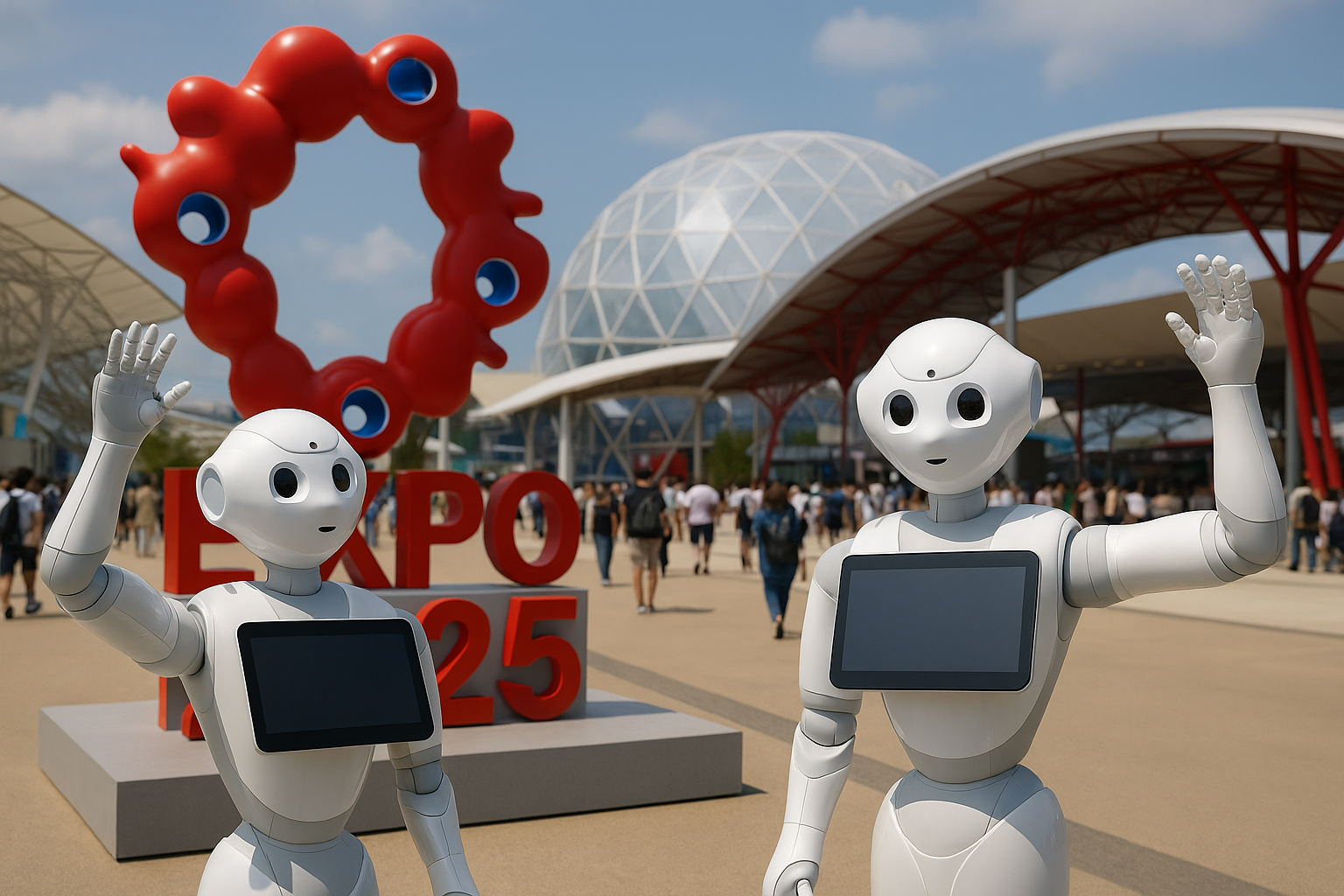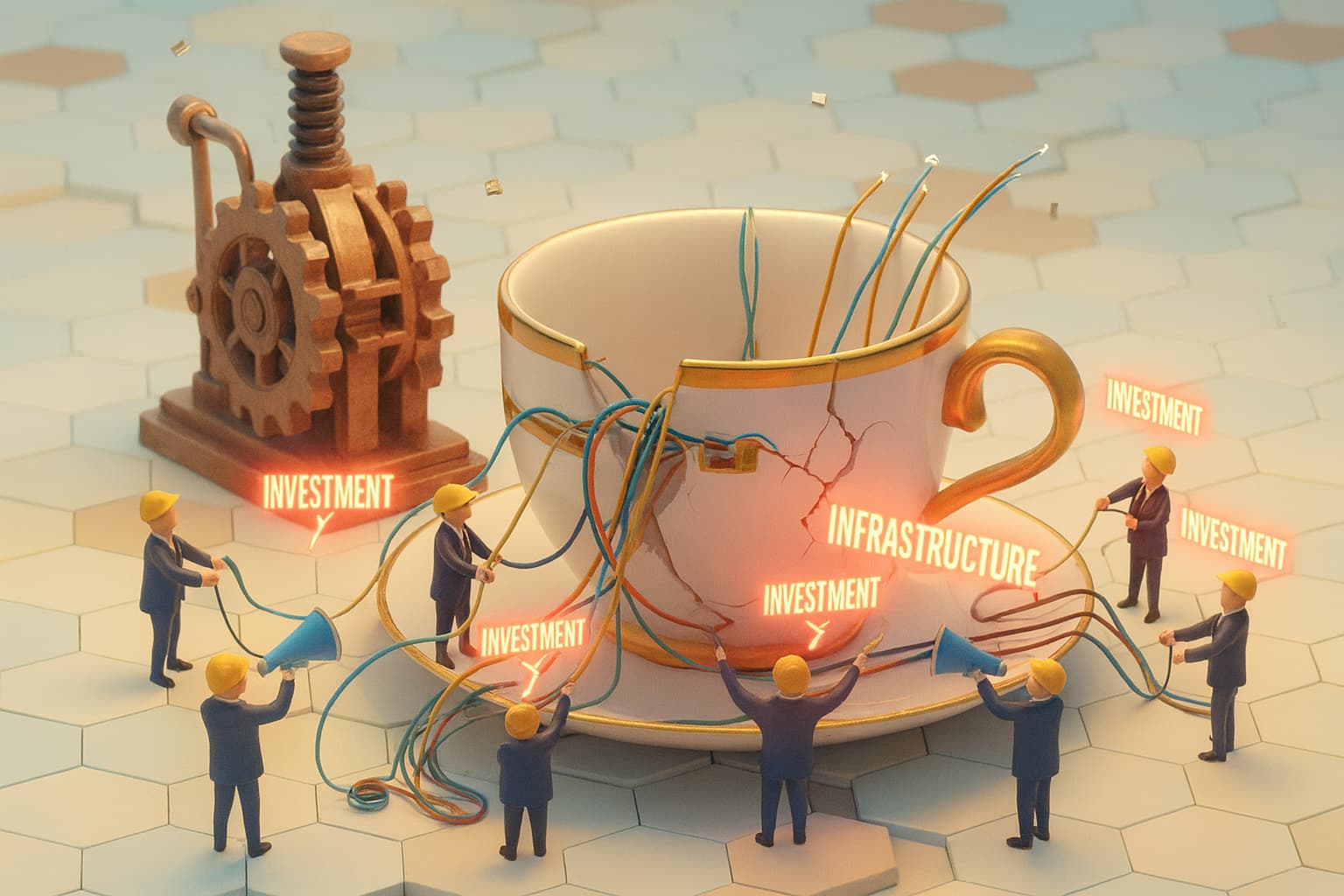Durante la mia recente visita all’Expo 2025 di Osaka, sono rimasto colpito non solo dalla scala dell’evento, ma anche dai suoi limiti strutturali, limiti che rischiano di minare la rilevanza delle Esposizioni Universali in un contesto globale in rapido cambiamento.
Organizzata sull’isola artificiale di Yumeshima da aprile a ottobre, l’Expo punta ad attirare 28,2 milioni di visitatori. Tuttavia, nelle prime due settimane, l’affluenza è stata ben al di sotto delle aspettative: circa 1 milione di visitatori in totale, con numeri giornalieri lontani dalla media prevista di 150.000 ingressi.
Ciò che ha colpito maggiormente è stata la composizione demografica: la stragrande maggioranza dei visitatori è asiatica, prevalentemente giapponese, con pochissimi stranieri e una presenza europea quasi nulla. Per un evento che si dichiara di portata globale, questo solleva seri interrogativi sulla sua effettiva capacità di coinvolgimento e inclusività.
Un’altra grave assenza è la dimensione gastronomica e dell’ospitalità. Mi ha sorpreso constatare che il cibo elemento centrale nell’identità e nel successo di Expo Milano 2015—sia quasi del tutto assente a Osaka. A Milano, la gastronomia fu un ponte culturale, un motore di affluenza e una concreta espressione del tema dell’Expo. A Osaka, manca un’offerta comparabile. L’occasione persa è evidente.
Queste carenze rivelano un problema più ampio: il formato attuale dell’Expo non risponde più alle aspettative del pubblico globale di oggi. I visitatori si trovano ad affrontare lunghe code per accedere a padiglioni che spesso offrono poco più di video promozionali nazionali o allestimenti statici. Pochissimi Paesi presentano contenuti realmente innovativi e l’evento appare più come una vetrina diplomatica che una piattaforma significativa per idee, tecnologie e collaborazioni.
Tuttavia, l’Expo 2025 mette in luce un aspetto cruciale: l’importanza crescente della partecipazione del settore privato. In un mondo guidato dal cambiamento tecnologico, sono le imprese, non solo i governi, a detenere le chiavi del progresso. Un esempio emblematico è la dimostrazione di robotica umanoide dell’azienda UBTech nel padiglione cinese. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di uno sguardo sul futuro dell’interazione uomo-macchina, e di un chiaro esempio di come l’innovazione aziendale possa accrescere la rilevanza dell’Expo.
Ma come dovrebbe essere un’Expo del XXI secolo?
Dovrebbe essere ibrida, tematica e partecipativa. Invece di organizzare i contenuti per Paese, dovremmo costruire padiglioni globali intorno alle grandi sfide del nostro tempo: clima, salute, mobilità, intelligenza artificiale, sistemi alimentari ed educazione. È essenziale integrare l’accesso digitale, permettendo alle persone di tutto il mondo di esplorare, interagire e imparare in tempo reale. La gestione dei flussi deve essere intelligente, usando strumenti digitali per ridurre i tempi di attesa e personalizzare l’esperienza dei visitatori.
Soprattutto, le Esposizioni Universali devono abbracciare il loro ruolo di piattaforme per la cooperazione e l’innovazione globale. Ciò implica ripensare i modelli di governance per dare spazio non solo agli Stati, ma anche alle città, alle imprese, alle università e alla società civile. Significa curare i contenuti con lo stesso rigore che riserviamo ai forum scientifici o alle grandi mostre culturali.
Il mondo è cambiato. Se le Esposizioni Universali vogliono restare rilevanti, devono trasformarsi da vetrine simboliche a motori dinamici del progresso globale. Osaka 2025 è un invito all’azione. Sta a noi decidere se il futuro dell’Expo sarà modellato dalla nostalgia o dalla visione.