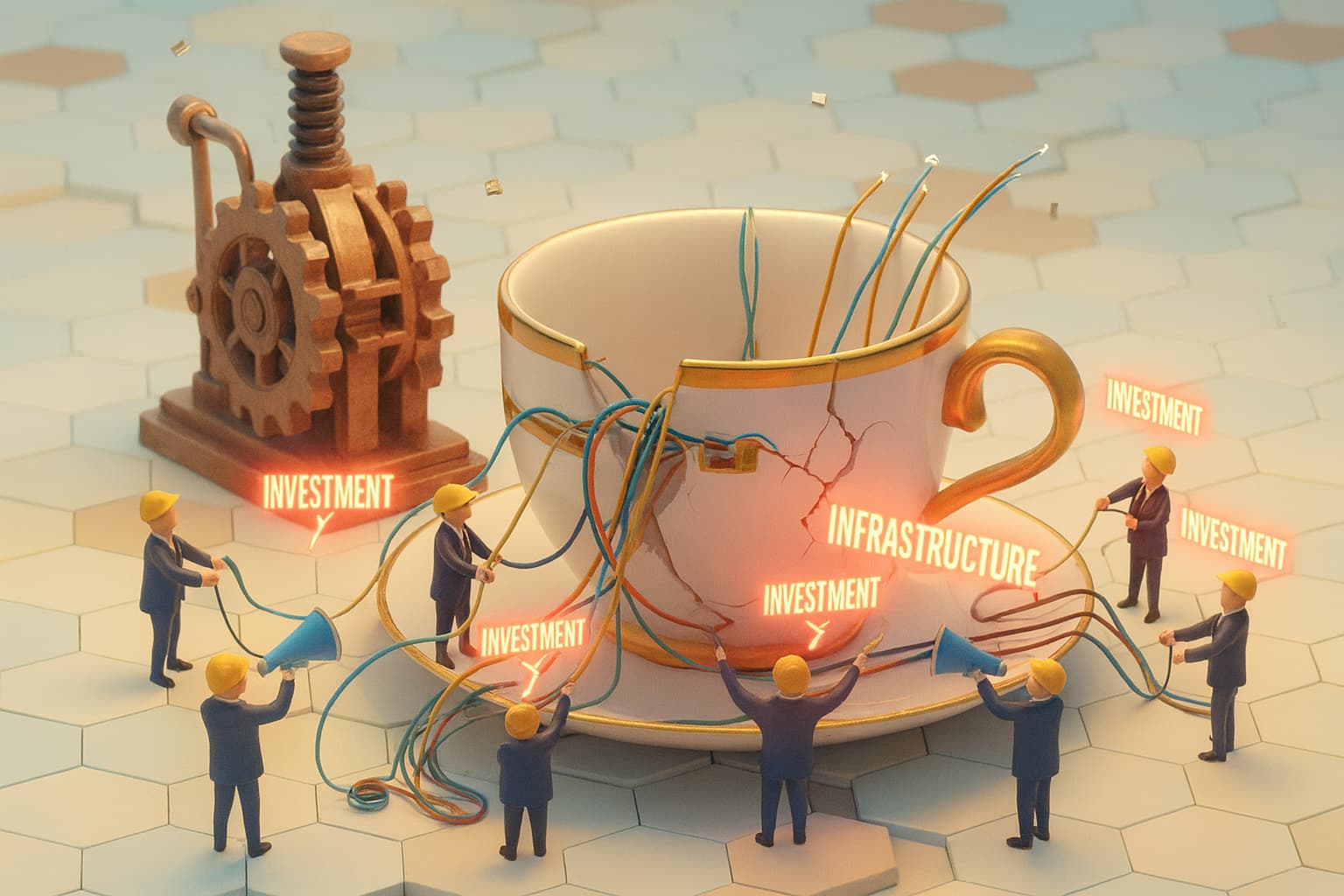Nel dibattito pubblico, il deficit commerciale viene spesso trattato come un campanello d’allarme. Quando un paese importa più di quanto esporta, si teme un indebolimento della competitività nazionale e un freno alla crescita del PIL. Ma questa visione è semplicistica e spesso fuorviante. L’evidenza empirica e l’analisi economica dimostrano che non esiste una relazione automatica tra saldo commerciale e crescita economica.
Contabilità nazionale e realtà macroeconomica
Secondo l’identità della contabilità nazionale, il PIL (Y) è la somma dei consumi (C), degli investimenti (I), della spesa pubblica (G) e del saldo commerciale (X–M). Tuttavia, un disavanzo nella componente (X–M) può essere più che compensato da una dinamica positiva delle altre componenti, in particolare dagli investimenti e dai consumi interni.
Inoltre, dal punto di vista della bilancia dei pagamenti, un deficit commerciale è sempre accompagnato da un surplus del conto finanziario: capitali esteri affluiscono per finanziare l’importazione netta di beni e servizi. Questo è spesso un segnale di fiducia nell’economia da parte degli investitori globali.
Dati ed esempi: la realtà smonta il mito
Stati Uniti. Tra il 1990 e il 2023, gli Stati Uniti hanno mantenuto un deficit commerciale medio intorno al 3–5% del PIL, pur registrando una crescita economica media annua superiore al 2%. Nel 2024, il deficit ha superato i 120 miliardi di dollari al mese, senza che ciò abbia impedito al paese di attrarre massicci investimenti esteri diretti e mantenere la leadership nell’innovazione tecnologica.
India. Con un deficit commerciale cronico, spesso superiore ai 100 miliardi di dollari all’anno, l’India ha comunque raggiunto tassi di crescita del PIL tra il 6% e l’8% negli ultimi dieci anni. Questo grazie a una forte domanda interna e a un’economia sempre più trainata dai servizi e dal digitale.
Germania. Al contrario, la Germania presenta uno dei maggiori surplus commerciali mondiali. Nel 2023 ha registrato un surplus di oltre 180 miliardi di dollari, ma la crescita del PIL è stata negativa (–0,2%). Il paese mostra una domanda interna debole e una forte dipendenza dai mercati esteri, che lo rende vulnerabile a crisi geopolitiche o a cambiamenti nella domanda globale.
Italia. Il caso italiano è particolarmente interessante. Negli anni successivi alla crisi del debito sovrano, l’Italia è tornata ad avere un surplus commerciale significativo (oltre 40 miliardi di euro nel 2022), grazie soprattutto all’export manifatturiero. Tuttavia, la crescita del PIL è rimasta debole e discontinua, con un incremento medio annuale inferiore all’1% tra il 2010 e il 2019. Il surplus commerciale ha convissuto con bassa produttività, stagnazione degli investimenti e scarsa crescita dei salari reali, dimostrando che l’avanzo commerciale, da solo, non è una garanzia di sviluppo sostenuto.
Giappone. Anche il Giappone degli anni ’90, pur mantenendo un forte surplus, ha vissuto un “decennio perduto” con crescita stagnante, dimostrando che un saldo positivo non è garanzia di prosperità.
Il commercio come leva per lo sviluppo
Importare non è sinonimo di debolezza: consente di accedere a beni capitali, tecnologie e competenze che possono accelerare la produttività. In un’economia globalizzata, l’interdipendenza commerciale è una forza, non un problema da evitare. I paesi in deficit sono spesso quelli che investono, costruiscono infrastrutture, consumano e si aprono all’innovazione.
Il saldo commerciale non è una pagella della salute economica di un paese. Un deficit può coesistere — e spesso coesiste — con una crescita robusta, quando è sostenuto da fondamentali sani, da una domanda dinamica e da un contesto macroeconomico stabile. Ossessionarsi per il pareggio della bilancia commerciale rischia di distogliere l’attenzione dai veri motori della crescita: innovazione, capitale umano, produttività e investimenti.
In ultima analisi, la domanda giusta non è “abbiamo un surplus?” ma piuttosto: “stiamo costruendo un’economia capace di creare valore nel lungo periodo?”